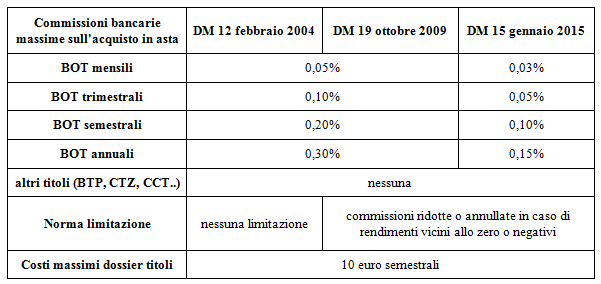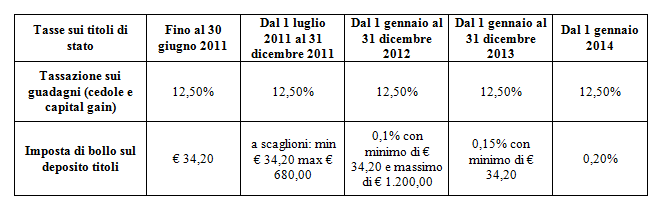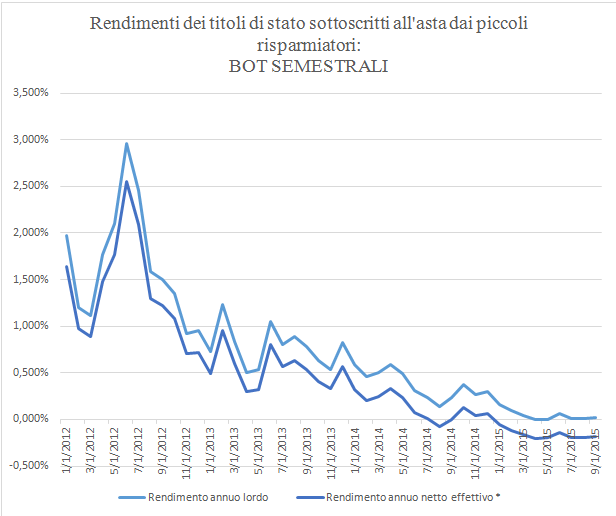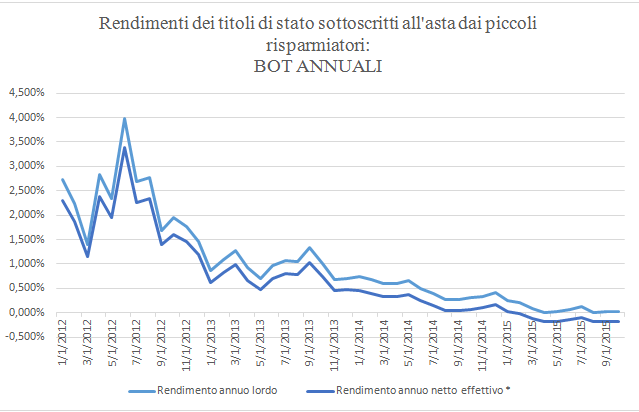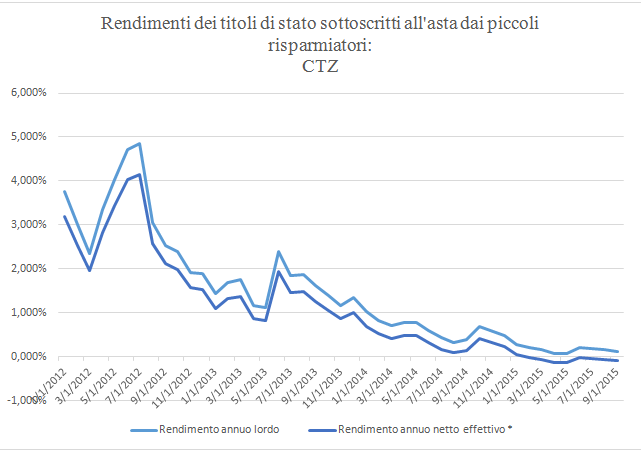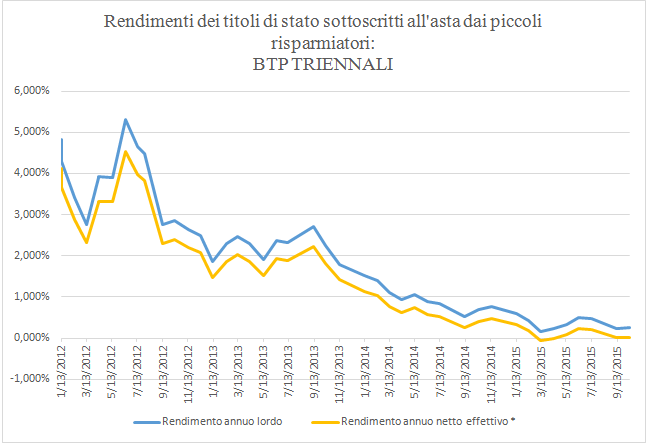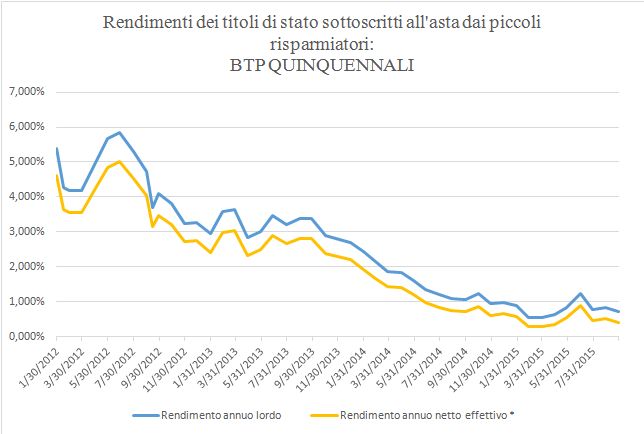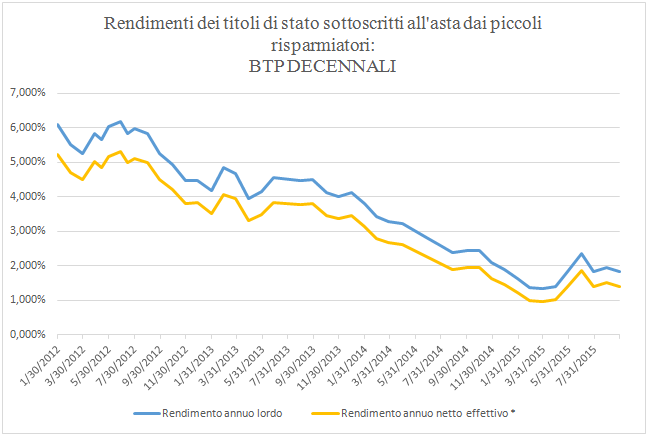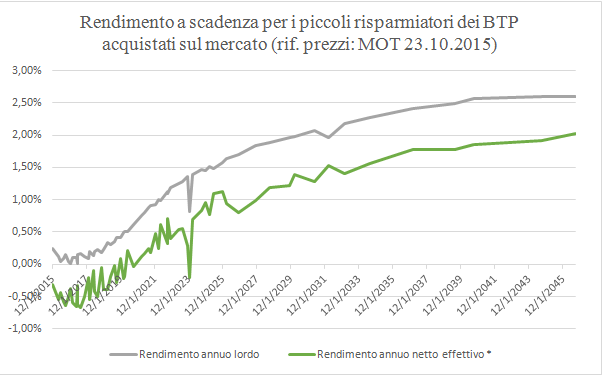Formazione dei nuovi dirigenti pubblici: il modello statunitense contro la lottizzazione
di Giuseppe Pennisi*
In un Paese dove la Pubblica Amministrazione intermedia circa la metà del Pil, l’efficienza della macchina pubblica è cruciale. Dalla metà degli Anni Novanta l’immissione diretta di giovani a livello dirigenziale è avvenuta dopo una procedura concorsuale severa e un corso (inizialmente di due anni e mezzo, includendo uno stage di sei mesi in impresa) presso la Scuola Nazionale d’Amministrazione SNA.
Nella Legge di Stabilità finalmente giunta in Parlamento si delinea un programma che dovrebbe affiancare, e forse sostituire, i concorsi-corsi SNA (che viene commissariata): l’assunzione nel triennio 2016-2018 di 50 dirigenti nelle amministrazioni, di altri 50 nella carriera prefettizia nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori. Le risorse verrebbero da una riduzione delle posizioni dirigenziali nei vari comparti che si renderanno vacanti a ragione del raggiungimento dell’età della pensione degli attuali titolari.
La proposta ha già suscitato le proteste delle rappresentanze dei dirigenti. Il ringiovanimento della dirigenza pubblica è comunque prioritario, dato che mediamente la dirigenza PA italiana è la più anziana dei Paesi OCSE. Ma olezza di particolarismo il fatto che le modalità di selezione e la distribuzione dei vincitori tra i vari comparti vengano delegate a un decreto del Presidente del Consiglio. È ancora vivo il ricordo di quando – durante i quattro mandati di Palmiro Togliatti a ministro della Giustizia – vennero immessi nella magistratura ben 4.000 avvocati, tutti iscritti o fidelizzati al PCI.
Perché non rimuovere tale olezzo, mantenere un unico programma di immissione di giovani dirigenti e utilizzare il modello statunitense dei ‘White House Fellows’, creato nel 1964 durante la Presidenza Johnson e che da allora funziona con piena soddisfazione di tutti? Mira a formare una ventina di ‘eccellenze’ e propone non un’assunzione a tempo indeterminato ma un contratto annuale rinnovabile per un massimo di due volte. Durante questo periodo i giovani lavorano in stretto contatto con il Presidente o il Vice Presidente oppure con i Segretari (Ministri). Il loro lavoro è integrato da seminari, dibattiti, incontri con responsabili politici stranieri. Il programma è rigorosamente non partisan e i ‘White House Fellows’ non vengono selezionati dall’equivalente americano della SNA ma da una commissione di nomina presidenziale in cui due terzi circa sono leader di imprese e un terzo alte figure del mondo accademico.
Nell’adattare questo modello all’Italia si promuoverebbe così una scelta ‘non partisan’ di alte professionalità che intendono servire lo Stato prima di intraprendere carriere nell’industria, nella finanza e nel commercio. Verrebbe così fugato anche il timore di rimpiazzare dirigenti di carriera con ‘nominati’ perché fidelizzati a questo o quel partito.
*Presidente del Comitato scientifico del Centro studi ImpresaLavoro