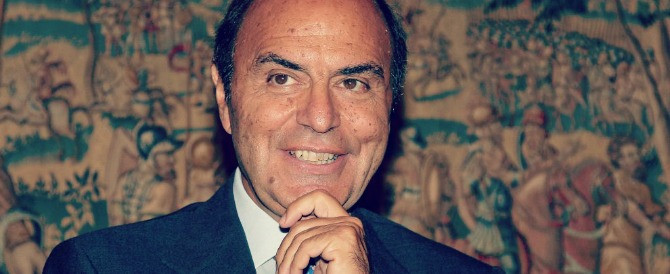Perché l’articolo 18 gioca contro crescita e welfare
Oscar Giannino – Il Mattino
Alla politica piace ragionare per slogan. Sulle intenzioni di Renzi sul Jobs Act, e in particolare sulle modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, fioccano i “timbri”. C’è chi l’ha avvicinato alla Thatcher, chi a Blair, o a Craxi. Il traslato è un modo per non parlare della realtà, ma per definire a prescindere – con giudizi “valoriali” – le intenzioni di modificarla. Un serio riformismo dovrebbe usare un altro metodo. Partire dai fatti: cioè valutare oggettivamente quali effetti reali ha provocato una certa norma, e che cosa determinerebbe invece la sua modifica. Dopodiché, ma solo “dopo” e non “prima”, ciascuno resta libero di giudicare secondo le proprie idee, che in Italia sono ancora quasi sempre “ideologie”.
Se analizziamo oggettivamente le disfunzionalità del mercato del lavoro, si dovrebbe partire dalla bassa occupazione, e dalla bassa produttività. Sulla prima questione, ricordiamo che tra i 15 e i 64 anni, a fine 2013 il tasso di occupazione italiano era al 49,9%, quello tedesco al 72,3%. Sulla seconda: se guardiamo alla manifattura italiana e considerando base 100 il 2000, la produttività oraria è salita al 2013 solo verso quota 110 mentre i salari orari sono arrivati oltre quota 155; nell’eurozona nel frattempo la produttività oraria è passata da 100 a 140 e i salari a 145. Una buona riforma del lavoro dovrebbe deve unire l’identificazione e rimozione sia degli ostacoli all’occupabilità, sia di quelli alla produttività. Ma non è di queste macro disfunzionalità che si parla, purtroppo. Bensì, ancora una volta, dell’abolizione eventuale del reintegro giudiziario in caso di licenziamenti economici, nei nuovi contratti triennali a tutele crescenti che il governo vuole introdurre. Per evitare la divisione “ideologica” di una scelta favorevole o contraria in via pregiudiziale, cerchiamo di capire gli effetti determinati dall’articolo 18.
L’Ocse valuta ogni anno in termini comparati le diverse forme nazionali delle restrizioni ai licenziamenti individuali e collettivi: l’Italia dopo decenni di stabilità a quota 2,76 è scesa con la riforma Fornero a quota 2,51, ma il confronto è con la media Ocse a 2,04, UK a quota 1,03, Svizzera 1,60, Spagna a 2,05, Francia a 2,38. Tutti dunque più flessibili di noi. Solo la Germania ci supera, a quota 2,87. I vincoli al licenziamento assicurano il lavoratore contro le fluttuazioni del mercato del lavoro, ne trasferiscono l’onere sull’impresa, che dovrebbe fronteggiarne gli effetti con maggiore facilità. Ma in concreto, la tutela più forte come modifica il comportamento delle imprese?
Per rispondere a questa domanda, c’è una copiosa letteratura di ricerche comparate in sede Ocse. Maggiore è la protezione, minori risultano i flussi da occupazione a disoccupazione, e viceversa. È il classico effetto di tutela dell’occupazione stabile: da noi amplificata col sistema CIG. Le imprese razionalizzano prodotti e sistemi produttivi meno rapidamente di quanto dovrebbero fare inseguendo le curve di costo e domanda; si abbassa l’utilizzo degli impianti, salvaguardando piante organiche lasciate in CIG ma alzando il costo fisso del capitale fisico e finanziario; e infine la variabilità della domanda di lavoro si risolve con contratti a tempo determinato – i precari a minori tutele come capita in Italia da molti anni, bruciando generazioni intere di più giovani. Ridurre la velocità di distruzione di posti di lavoro sembra una cosa positiva: ma si accompagna alla riduzione di velocità della creazione di quelli nuovi.
Tanto è vero che gli studi comparati Ocse rivelano che maggiore è la protezione dell’occupazione, con limiti a licenziamento e reintegri giudiziali, peggio va per donne e giovani, sia in termini di minor occupazione sia di maggior disoccupazione. Tutto ciò con effetti quantitativamente ancor più negativi quanto più forte è il livello di contrattazione collettiva, cioè quanto i salari fanno più difficoltà a variare tanto verso l’alto se le cose vanno bene, quanto verso il basso se vanno male. In presenza di protezione dell’occupazione le imprese diventano inoltre più selettive, e assumono con maggiore probabilità lavoratori più istruiti. Mentre quando si riduce la protezione dell’occupazione le imprese iniziano a sostituire contratti temporanei con contratti permanenti. Cioè più persone vengono assunte con contratti a tempo indeterminato.
Sin qui, appare evidente dagli studi comparati che esiste uno “scambio” tra protezione al licenziamento ed effetti collettivi positivi se il primo si attenua, quando i benefici verificati della tutela superano i costi privati e pubblici. Ma cerchiamo di capire anche se studi seri sono stati fatti in Italia, sugli effetti dell’articolo 18. Molte ricerche si sono incentrate sull’effetto-soglia. Se cioè la tutela per i lavoratori sopra le 15 unità di dipendenti per impresa rappresentasse un freno alla crescita dimensionale delle aziende italiane. Quasi tutte le ricerche – di Garibaldi, Pacelli, Schivardi, Torrini – concordano che l’effetto soglia esiste, ma è meno rilevante di quanto spesso si creda. Non spiegherebbe che il 2% delle decisioni di non crescere. Piuttosto, anche le imprese italiane analizzate sotto i 15 dipendenti hanno manifestato effetti importanti sui flussi di lavoratori in entrata e in uscita. Assunzioni e licenziamento nei contratti a tempo indeterminato sono calati nelle imprese piccole rispetto alle grandi, sostituiti anche qui dal ricorso massiccio dei contratti a tempo determinato. Tutto ciò ha in sostanza allungato i tempi di attesa verso “posti protetti” nella vita di ogni lavoratore.
Ci sono poi altri due effetti, ai quali i più non guardano. Quello dell’articolo 18 sui salari, e quello sulla produttività. Le ricerche italiane mostrano che le imprese traslano l’effetto-assicurazione al posto fisso – quella che in gergo tecnico si chiama job property – riducendo i salari settimanali: solo che la rigidità dei contratti nazionali di categoria per la parte salariale garantisce anche qui i già tutelati, e la riduzione comparata di salario va a carico dei contratti a tempo determinato che dalle tutele sono esclusi. L’apartheid di cui parla Renzi non è solo quella tra chi è tutelato dall’articolo 18, una minoranza secca dei 22,4 milioni di lavoratori italiani, e chi no. C’è anche quella dovuta al fatto che gli oneri assicurativi a favore dei tutelati, in una stessa impresa si traduce in minori salari di chi la tutela non ce l’ha. Stiamo parlando di minori salari tra il 10 e il 15%, a seconda dei diversi settori, e una quota di questo gap si deve proprio alla copertura degli oneri di licenziamento dei “tutelati” a tempo indeterminato. Infine, la produttività. La tutela elevata ai licenziamenti induce le imprese anche a un minore stock di capitale per unità di lavoro. C’è chi ha stimato che la riduzione della tutela al licenziamento verso il coefficiente OCSE della Danimarca – 2,20 rispetto al nostro 2,53 – produrrebbe negli anni un incremento dell’11,2%, degli investimenti, e del 7% della produttività del lavoro.
Analizzati tutti questi effetti, la soluzione obbligata è riscrivere il trade off tra tutela al licenziamento ed esternalità negative che ne vengono all’occupabilità e alla crescita della produttività. La soluzione dell’equazione non si fa solo abolendo il reintegro giudiziale, ma con una seria riforma contestuale degli ammortizzatori sociali, del sistema di intermediazione tra domanda e offerta del lavoro, e con più contrattazione decentrata al posto di quella nazionale. Giudicate voi, ora, se il Jobs Act su cui Pd e sindacati si accapigliano proceda secondo questi criteri.