
il tempo


La spesa delle regioni continua a correre
Redazione », Scrivono di noi il tempo, rassegna stampa, regioni, spesa pubblica
Leonardo Ventura – Il Tempo
Nonostante gli annunci di spending review, la spesa corrente delle Regioni continua a crescere: è quanto emerge dall’analisi effettuata dal Centro Studi ImpresaLavoro che, rielaborando i dati resi noti recentemente dalla Corte dei Conti, ha notato come la spesa pubblica corrente delle Regioni nel periodo 2011-2014 sia cresciuta di 3,9 miliardi di euro, passando da 141,7 a 145,6 miliardi (+2,76%). Non tutte le Regioni si sono comportate allo stesso modo. Quelle a statuto speciale hanno ridotto le loro uscite per spese correnti del 2,46%, passando da 31,3 a 30,6 miliardi di euro tra il 2011 e il 2014. Questo «tesoretto» di 0,7 miliardi di risparmi è stato interamente vanificato dall’incremento delle uscite delle Regioni a statuto ordinario, dove la spesa passa da 110,4 a 115,0 miliardi di euro (+4,25%). Fanno eccezione alcune regioni più «virtuose» come la Lombardia e l’Abruzzo.
Al netto degli importi riversati allo Stato per il cosiddetto Fondo di Solidarietà, la Lombardia emerge come la Regione che ha effettuato i maggiori tagli alla spesa corrente, scesa dell’11,63%. L’Abruzzo ha ridotto le proprie spese correnti del 6,09%. Il Lazio, al contrario, detiene il record del maggiore incremento della spesa nel periodo considerato (+33,33%) seguito dalla Calabria (+3l,06%). Tra gli enti a statuto speciale buone performance di riduzione della spesa sono state registrate dalla Provincia Autonoma di Bolzano (-6,33%) seguita dalla Sardegna (-5,94%).
Sempre la Lombardia si conferma la Regione più virtuosa in quanto a spesa corrente pro-capite. Per ogni cittadino la Regione spende infatti 1.739 euro a cittadino, meno della metà di quanto esce dalle casse del Lazio, che con i suoi 3.129 euro di spesa corrente pro-capite fa segnare l’esborso più elevato. Tra le autonomie speciali, invece, è la Valle d’Aosta ad avere una spesa corrente pro-capite decisamente superiore alla media delle altre regioni, ordinarie e non. A causa anche della piccola dimensione e dell’impossibilità strutturale di fare alcune economie di scala, ogni cittadino valdostano costa 8.995 euro ogni anno di spesa corrente. Chi spende di meno per spesa corrente pro-capite è la Sicilia con i suoi 2.529 euro, seguita da Sardegna e Friuli Venezia Giulia. La spending review sembra invece funzionare in Lombardia e Abruzzo: le due Regioni con la minor spesa corrente pro-capite sono anche quelle che hanno effettuato i tagli di spesa più consistenti.

Renzi fa ponti d’oro ai profughi e noi scappiamo dal Belpaese
Redazione », Scrivono di noi emigrazione, il tempo, massimo blasoni, rassegna stampa
di Massimiliano Lenzi – Il Tempo
Siamo tornati ad essere un popolo di emigranti, di gente che fa la valigia e se ne va in cerca di fortuna all’estero, altro che gli sbarchi in Sicilia dal Nord Africa e la retorica dell’accoglienza a prescindere, per aiutare chi sta peggio di noi, anche se a gran parte delle nazioni europee (Austria, Ungheria, Inghilterra e Danimarca) solo a sentir parlare di quote di profughi da accogliere viene l’orticaria e non ne vogliono sapere. La crisi economica, in questi anni, ha fiaccato la resistenza e le speranze di futuro di una parte consistente delle famiglie italiane, portando quasi 600mila nostri connazionali, dal 2008 ad oggi, ad andarsene via dal Belpaese in cerca di lavoro e di una vita migliore.
I numeri sugli italiani che tornano, come nella scorsa metà del secolo scorso, li ha raccolti (su elaborazione dei dati Eurostat) una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro. «Dal 2008 al 2013 – si legge – gli emigrati italiani sono stati complessivamente 554.727, di cui 125.735 soltanto nel 2013 con una crescita rispetto al 2008 del 55% su base annua. Il 39% di questi italiani (214.251, di cui 47.048 soltanto nel 2013) sono giovani di età compresa tra i 15 e 34 anni». Anche in questo caso si segnala un trend in rapida crescita: rispetto al 2008 i giovani che hanno scelto di trasferirsi oltre confine sono aumentati del 40%. Si tratta di numeri importanti che dovrebbero interrogare la politica, a cominciare da Govrno Renzi, troppo impegnata a far della facile retorica sui doveri dell’accoglienza che avrebbero gli italiani verso i migranti che sbarcano dall’Africa, per ricordarsi invece degli italiani che se ne vanno dall’Italia. Volendo calcolare un numero annuale, vien fuori che in questi sei anni se ne sono andati via dal nostro Paese 92.455 italiani all’anno, in pratica la popolazione di una città media italiana.
Dove vanno i nostri connazionali a cercar fortuna? Secondo i dati della ricerca, in questi ultimi sei anni la destinazione più gradita è stata la Germania (che ha accolto 59.470 nostri connazionali, di cui 13.798 solo nel 2013), seguita dal Regno Unito (51.577 emigrati, di cui 14.056 solo nel 2013), dalla Svizzera (44.218 emigrati, di cui 10.537 solo nel 2013), dalla Francia (38.925 emigrati, di cui 9.514 solo nel 2013) e dalla Spagna (25.349 emigrati, di cui 4.537 solo nel 2013). Si ratta insomma di Paei europei che non saranno il paradiso ma offrono, per chi se ne va, maggiori opportunità di farcela (con, ovviamente, tutte le difficoltà che essere fuori dal proprio Paese comporta) e un sistema, a cominciare da quello fiscale, più semplice del nostro. La graduatoria dei Paesi di destinazione, poi, cambia se guardiamo ai più giovani, di età compresa tra i 15 e 34 anni: per loro la meta preferita è il Regno Unito (27.263 emigrati, pari al 53% del totale), che precede la Germania (24.445, pari al 41% del totale), la Svizzera (16.653), la Francia (14.682) e la Spagna (11.377).
Altri Paesi di destinazione dei nostri emigranti sono poi il Belgio (12.064 connazionali, di cui 4.457 giovani), l’Albania (9.470, di cui 3.442 giovani) e la Slovenia (1.629, di cui 351 giovani). Emigrare dall’Italia in Albania, una via della speranza che sarebbe stata impensabile fino a pochi anni fa quando eravamo noi il Paese sognato dagli albanesi. Furi dall’Europa la parte del leone la fanno gli Stati Uniti: 26.072 italiani (fra questi 9.104 giovani), di cui 5.560 soltanto nel 2013.
«I nostri emigranti – spiega Massimo Blasoni, imprenditore e presidente del Centro Studi ImpresaLavoro – scelgono in larghissima parte di continuare a vivere all’interno dell’Unione europea, spostandosi in Paesi che garantiscono loro un sistema formativo e un mercato del lavoro decisamente superiori a quelli italiani». Maggiore riconoscimento del merito, migliore formazione e più facilità, se si ha talento, di farcela. C’era una volta, in Italia.

Debiti, le aziende aspettano 70 miliardi
Redazione », Scrivono di noi debiti PA, il tempo, impresalavoro, imprese
Marco Valeri – Il Tempo
Lo Stato chiede soltanto. Ma non dà. O meglio, quando si tratta di pagare non è certo il più puntuale dei creditori. Una cosa che ovviamente fa infuriare i contribuenti che spesso, per versamenti fatti con qualche giorno di ritardo, si vedono recapitare multe salate. Eppure la realtà dei debiti saldati con ritardi di mesi è certificata dalla Banca d’Italia che smonta, di fatto, l’entusiasmo di Matteo Renzi che lo scorso anno aveva annunciato trionfalmente che avrebbe saldato tutti i conti della Pubblica amministrazione per la data del suo onomastico, ovvero il 21 settembre. In realtà già allora lo stock di debito nei confronti delle imprese era di circa 66,5 miliardi di euro a cui dovevano essere sottratti 31/32 miliardi già pagati. La tendenza era quella comunque di assicurare il saldo dell’arretrato entro la fine del 2014. Martedì scorso invece la sorpresa dal pulpito di Banca d’Italia.
La verità di Visco
Nelle stime presentate da Bankitalia nella «Relazione Annuale 2014», il debito commerciale della Pubblica amministrazione italiana nei confronti dei fornitori privati ammontava lo scorso 31 dicembre a circa 70 miliardi di euro. Un’informazione preziosa, dal momento che dallo scorso 30 gennaio la «Piattaforma per la certificazione dei crediti» del Mef non ha più aggiornato il monitoraggio del pagamento dei debiti maturati dalla Pa al 31 dicembre 2013. All’epoca il Governo sosteneva di aver pagato 36,5 miliardi su un totale di 74,2 miliardi di euro: poco meno della metà del dovuto.
Stato «lumaca»
Il dato fornito dai tecnici della Banca d’Italia non fa che confermare quanto denunciato già a febbraio dal Centro studi ImpresaLavoro e che fa parte del buon senso economico: i debiti commerciali si rigenerano con frequenza, dal momento che beni e servizi vengono forniti di continuo. Pertanto liquidare, solo in parte, i debiti pregressi di per sé non riduce affatto lo stock complessivo:questo può avvenire soltanto nel caso in cui i nuovi debiti che si creano risultino inferiori a quelli oggetto di liquidazione. Ne consegue altresì che il ritardo del Governo nel pagamento di questi debiti sia costato nel 2014 alle imprese italiane la cifra di 6,1 miliardi di euro. Questa stima è stata effettuata prendendo come riferimento l’ammontare complessivo dei debiti della nostra Pubblica amministrazione (così come certificato da Bankitalia), l’andamento della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi (così come certificato da Eurostat) e il costo medio del capitale che le imprese hanno dovuto sostenere per far fronte al relativo fabbisogno finanziario generato dai mancati pagamenti. Elaborando i dati trimestrali di Bankitalia, il centro studi ha stimato che questo costo aggiuntivo per gli interessi sia stato nel 2014 pari all’8,97% su base annua (in leggero calo rispetto al 9,10% nel 2013).
La bomba interessi
A questa grave situazione se ne aggiunge anche un’altra che potenzialmente sarebbe ancora più grave: se lo Stato italiano dovesse infarti adeguarsi alla direttiva europea sui pagamenti della Pa e riconoscesse ai creditori gli interessi di mora così come stabiliti a livello comunitario, le casse dello Stato sarebbero gravate da un esborso di ulteriori 2,4 miliardi di euro.
Ultimi in Europa
Per pagare i suoi fornitori lo Stato italiano impiega 41 giorni in più della Spagna, 50 giorni in più del Portogallo, 82 giorni in più della Francia, 115 giorni in più della Germania e 120 giorni in più del Regno Unito. La Cgia di Mestre guidata da Giuseppe Bortolussi spiega che «nonostante i tempi di pagamento nell’ultimo anno siano scesi di 21 giorni, secondo Intrum Iustitia nel 2015 la nostra Pa si conferma la peggiore pagatrice d’Europa, visto che salda mediamente i propri fornitori dopo 144 giorni, contro i 34 giorni medi che si registrano in Ue. Rispetto ai nostri principali partner economici, la Francia salda le proprie fatture dopo 62 giorni, i Paesi Bassi in 32 giorni, la Gran Bretagna in 24 giorni e la Germania dopo 19 giorni».

La pratiche fiscali costano 20 euro al giorno
Redazione Scrivono di noi filippo caleri, fisco, il tempo, impresalavoro, imprese, massimo blasoni, tasse
Filippo Caleri – Il Tempo
Non solo fisco esoso e rapace. In Italia le imprese sopportano un costo esoso anche solo per restare in regola e per portare a termine le decine di adempimenti chiesti dall’amministrazione fiscale. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi ImpresaLavoro, una azienda media spende, infatti, ogni anno 7.559 euro per disbrigare adempimenti burocratici relativi al pagamento delle imposte: una cifra che non ha eguali in Europa e che rappresenta una vera e propria tassa ulteriore e mascherata che le aziende sono costrette a sostenere.
Un numero che è emerso dall’incrocio di due dati: quello reso noto dalla Banca Mondiale all’interno del rapporto Doing Business e relativo alle ore annue necessarie per svolgere adempimenti fiscali e quello relativo al costo orario medio del lavoro nel nostro paese così come sostenuto dalle aziende e rilevato da Eurostat. Un’azienda italiana, mediamente, deve infatti dedicare ogni anno 269 ore per preparare, compilare e pagare i moduli relativi alle imposte sul lavoro, sul valore aggiunto e sui redditi di impresa. Questo tempo comporta ovviamente un costo, che Eurostat stima mediamente in 28,1 euro l’ora. L’assorbimento di dipendenti dedicati a queste mansioni e quindi distolti dall’effettiva produzione costa così ogni anno alle aziende 7.559 euro.
Per una volta l’Italia riesce a battere anche la Germania che, nonostante un costo orario del lavoro più alto di 3 euro rispetto al nostro, con «solo» 218 ore necessarie a pagare le tasse chiede alle sue imprese uno sforzo di 736 euro inferiore al nostro. Il Paese supera anche la Francia che, pur avendo un sistema fiscale pesante come quello italico in termini quantitativi, richiede solo 137 ore all’anno per svolgere tutte la pratiche relative al fisco. È anche vero che in Europa vigono anche sistemi più complessi di quello applicato in Italia – spiega il rapporto della Fondazione – ad esempio quello bulgaro, quello ungherese o quello della Repubblica Ceca. Il basso costo del lavoro rende però decisamente meno oneroso impiegare risorse in compiti burocratici.
«Quando analizziamo il total tax rate cui sono sottoposte le imprese italiane – commenta il presidente di ImpresaLavoro Massimo Blasoni – molto spesso ci dimentichiamo che le tasse emerse non rappresentano il totale del peso che le aziende devono sopportare. La burocrazia non è solo un laccio che blocca lo sviluppo e gli investimenti privati: è anche un costo. Per questo è sempre più necessario agire rapidamente per semplificare il nostro sistema, partendo da quello fiscale. Si tratta di una riforma urgente e che può essere realizzata a costo zero. Basta volerlo».
Mentre si pagano costi pesanti per pagare le tasse. Queste ultime non accennano a diminuire. E l’eventuale sostituzione di una serie di tasse comunali con la «local tax» porterebbe in un’«unica» soluzione 26 miliardi di euro nelle casse dei Comuni italiani. A calcolarlo è l’Ufficio studi della Cgia, l’associazione degli artigiani di Mestre, che ha elencato le principali imposte/tasse comunali e i relativi gettiti che potrebbero essere sostituiti dalla nuova «tassa unica» che i sindaci dovrebbero applicare a partire dal 2016. Ebbene, tra Imu e Tasi (21,1 miliardi di euro), l’addizionale comunale Irpef (4,1 miliardi di euro), l’imposta sulla pubblicità (426 milioni di euro), la tassa sull’occupazione degli spazi e aree pubbliche (218 milioni di euro), l’imposta di soggiorno (105 milioni di euro) e l’imposta di scopo (14 milioni di euro), il gettito totale si aggira sui 26 miliardi di euro.

Renzi ci prova: ecco le sue liberalizzazioni
Redazione Edicola - Argomenti filippo caleri, il tempo, liberalizzazioni, marco valeri, Matteo Renzi
Filippo Caleri e Marco Valeri – Il Tempo
Abolizione del «prezzo imposto» sui libri, eliminazione del mercato di «maggior tutela» per il gas, vendita libera di medicinali di fascia C nelle parafarmacie. E ancora: rimozione dei vincoli per l’apertura di nuove farmacie, studi notarili, pompe di benzina e persino edicole; ma anche via libera a Uber (il servizio di noleggio con il cellulare), al cambiamento di operatore telefonico in tempi sprint e all’ingresso dei privati nel trasporto pubblico locale e per la creazione di nuove cliniche sanitarie. Renzi tenta il bis delle lenzuolate di Bersani o perlomeno ci prova. Insomma, lobby permettendo, sono in arrivo le «Renzuolate». Per avere l’elenco ufficiale delle nuove liberalizzazioni si deve attendere il 20 febbraio, quando il Disegno di Legge Concorrenza arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Ma la bozza del provvedimento che circola in queste ore, datata 15 gennaio, delinea già la maggior parte degli interventi, che riguarderanno molti settori, dall’editoria all’energia, fino al sistema bancario e alle assicurazioni.
Libri più cari
La bozza prevede sia l’abolizione del prezzo imposto dall’editore, con possibili rincari, soprattutto sui libri di testo scolastici, sia l’eliminazione del tetto massimo del 15% di sconto applicabile sulla vendita di libri. In pratica viene sancita la fine dei limiti imposti dalla Legge Levi del 2011, varata in seguito alle proteste dei piccoli editori e dei librari indipendenti, preoccupati dalla concorrenza dei grandi gruppi editoriali e delle grandi catene di librerie. Preoccupazione che non scompare. Secondo Cristina Giussani, presidente del Sindacato Italiano Librai, l’intervento «è un favore ad Amazon e a tutti quei gruppi che hanno le capacità economiche per vendere libri sottocosto e mettere fuori mercato, una volta per tutte, le librerie indipendenti e i piccoli editori».Energia
A partire dal 30 giugno 2015 scomparirà anche il servizio «di maggior tutela» del gas per i clienti domestici, nel quale le tariffe sono fissate trimestralmente dall’Autorità per l’energia. Nella stessa data cesserà anche la possibilità per le piccole imprese di aderire al servizio di maggior tutela per l’energia elettrica. Una doppia novità che porterà alla piena liberalizzazione del mercato, ma che potrebbe avere come effetto collaterale un improvviso aumento dei prezzi per i clienti un tempo tutelati. Un rischio riconosciuto anche dal Governo: nella bozza, infatti, si prevede di condurre «un monitoraggio dei prezzi durante la fase di liberalizzazione», per evitare sorprese.Rc Auto
Moltissime le novità nel campo assicurativo. Rispuntano gli sconti obbligatori per gli assicurati che accettano di installare sulla propria auto le famose «scatole nere», i dispositivi che registrano le attività del veicolo. La nuova bozza, però, prevede sconti anche per chi accetta di sottoporre il proprio veicolo ad ispezione da parte delle compagnie assicurative. Ma cambiano anche le misure per la trasparenza e per l’assegnazione delle classi di merito, che ora prevedono aumenti meno salati del premio assicurativo per chi viene «declassato».Farmacie e farmaci di fascia C
Il ddl Concorrenza interverrà pesantemente anche sul tessuto delle farmacie. Attualmente, infatti, la norma prevede la possibilità di aprire una farmacia ogni 3.300 abitanti. La bozza del disegno di legge prevede il dimezzamento di tale soglia, abbassandola a 1.500 abitanti, e permettendo quindi il raddoppio del numero di farmacie. Novità anche per i farmaci di fascia C con ricetta, destinati al trattamento di patologie lievi, che potranno essere venduti anche nelle Parafarmacie e nei corner dei supermercati.Trasporti locali
Altra grande novità del sarà l’arrivo dei privati nel trasporto pubblico locale. La bozza prevede infatti che imprese diverse dal concessionario del servizio di trasporto «possano fornire servizi anche in sovrapposizione alle linee gestite in regime di esclusiva». Viene abrogato anche l’obbligo per le auto del Noleggio con conducente (NCC) di ricevere prenotazioni solo presso l’autorimessa: un divieto che stava a cuore soprattutto ai taxi, ma che ora scompare. E che facilita la vita ad Uber, il servizio di trasporto 2.0 che utilizza guidatori privati e, appunto, NCC.Edicole, benzina e parrucchieri
Le Renzuolate prevedono, fra le tante cose, anche l’abolizione delle autorizzazioni comunali per l’apertura di nuovi punti vendita di quotidiani e periodici insieme alla rimozione dei vincoli residui all’apertura di nuovi impianti di distribuzione carburanti, e allo sviluppo del «non oil», la parte di business delle pompe di benzina che non è legata al carburante, come vendita di giornali e prodotti di altro tipo. Anche gli acconciatori saranno liberalizzati: la durata prevista dei corsi di qualificazione per accedere alla professione di parrucchiere passa dagli attuali due anni a 900 ore, mentre l’apprendistato si riduce da un anno a 300 ore.Notai e banche
Alle banche verrà imposto di trasferire il conto corrente, quando richiesto dai clienti, presso altri istituti tassativamente entro 15 giorni. Per i notai, invece, è prevista la trasformazione del tetto minimo di 7.000 abitanti, necessario per l’apertura di una nuova posizione notarile, in un tetto massimo.
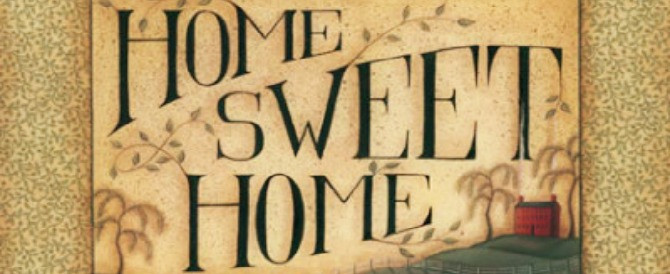
Quasi 21.500 euro a famiglia, ecco gli affari d’oro sulle case
Redazione Edicola - Argomenti carlantonio solimene, casa, famiglie, il tempo
Carlantonio Solimene – Il Tempo
Quasi 21.500 euro l’anno. Per la precisione 21.439,66. Tanto spende il Comune di Roma per ognuna delle 1.931 famiglie vittime dell’emergenza abitativa nella Capitale e ospitate nei C.A.A.T.: Centri di Assistenza Abitativa Temporanea. Praticamente, le suddette famiglie potrebbero permettersi un affitto da quasi 1.800 euro al mese. Un superattico a Prati, per dire.
La realtà è molto diversa. Perché gran parte di quei soldi resta «impigliata» nel sistema delle cooperative che gestiscono i residence. Solo a Roma si parla di 31 coop. Le più importanti? La Eriches 29 – tra le tante che erano riconducibili a Salvatore Buzzi – che intasca circa 5,2 milioni di euro; la San Vitaliano Srl, che sfiora i 4 milioni; la New Esquilino Spa, che ne riceve quasi 3,8. Sono i dati forniti dal prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, nell’audizione in commissioni riunite, Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera, sul decreto Milleproroghe. Il caso è noto. Nel dl licenziato settimane fa, non era stata prevista la proroga della sospensione degli sfratti. Una decisione, quella del governo, che aveva provocato le proteste di associazioni ed enti locali, convinti che si sarebbe andati incontro a una vera e propria emergenza sociale. Aspetto non trascurabile: il Piano casa promosso dal ministro Maurizio Lupi, nonostante sia ufficialmente entrato in vigore nel maggio 2014, è in realtà ancora monco. In particolare, i soldi che dovrebbero costituire il fondo per arginare le emergenze non sono ancora nella piena disponibilità degli enti locali.
E così la discussione in Parlamento sul Milleproroghe si è trasformata in uno scontro tra chi chiedeva di sospendere l’esecuzione degli sfratti, e chi invece difendeva le ragioni dei proprietari. Anche perché, sottolineavano questi ultimi, è difficile distinguere tra chi si trova realmente in difficoltà e i cosiddetti «furbetti». Tra i «morosi incolpevoli» – coloro che hanno sempre pagato e ora sono in difficoltà a causa di perdita di lavoro o grave malattia – e quelli che, invece, approfittano illegittimamente della «generosità» dello Stato. Per vederci chiaro, le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno convocato Pecoraro. Una scelta determinata dalla situazione particolare della Capitale, la città che più di tutte in Italia soffre dell’emergenza abitativa. Ma anche dal fatto che molti dei parlamentari che invocavano una proroga degli sfratti erano di Roma. Gli echi di Mafia Capitale e dei torbidi legami tra politica e cooperative rosse hanno fatto il resto.
Il dossier fornito ai deputati da Pecoraro è esplosivo. Si ribadisce un quadro dai contorni drammatici – nella Provincia di Roma viene sfrattata una famiglia ogni 246 nuclei residenti, in Italia la media è di una ogni 353 – ma al tempo stesso si evidenzia come la spesa sostenuta dal Comune per tamponare l’emergenza sia totalmente sproporzionata rispetto alle reali necessità. Il passaggio «incriminato» è nell’ultima delle cinque pagine dell’«Appunto sull’emergenza abitativa a Roma e Provincia». Si legge: «I C.A.A.T. (Centri di Assistenza Abitativa Temporanea) a oggi in essere sul territorio di Roma sono 31: questi ospitano complessivamente ben 1.931 nuclei familiari per una spesa annua sostenuta nel 2014 pari a circa 41,5 milioni di euro». Dividendo la somma per il numero delle famiglie aiutate, si arriva per l’appunto ai 21.500 euro annui citati. Se il Comune di Roma versasse questi soldi direttamente ai nuclei, ne basterebbe la metà. Ma, in realtà, gran parte di quella cifra resta impigliata nel sistema delle cooperative, ognuna con le sue strutture, ognuna con i suoi tanti dipendenti da pagare. E così alle famiglie non restano che le briciole, non resta che vivere in sovrannumero in abitazioni minuscole sotto gli standard minimi di decenza.
La conseguenza principale di questa situazione è il fenomeno delle occupazioni abusive. «Ad oggi – si legge ancora nel documento presentato dalla Prefettura – nella sola Capitale sono state segnalate alla Questura 109 occupazioni abusive di immobili (…). Nello specifico, n. 2 immobili sono stati occupati nel 2014, n.23 nel 2013, n. 9 nel 2012, n.5 nel 2011 e circa 70 negli anni precedenti». E se nel 2014 il fenomeno ha subìto un rallentamento, è solo grazie all’«efficace lavoro realizzato dalla Prefettura e dalla Questura per attuare tempestivi interventi finalizzati alla rapida risoluzione di tentativi di operare nuove occupazioni». C’è spazio, ovviamente, anche per le rivendicazioni dei proprietari, «che hanno lamentato gravi danni derivanti dal perdurare di occupazioni abusive di immobili di loro proprietà» e di alcune imprese che «a causa di tali occupazioni spesso di durata pluriennale, sono impossibilitate a trarre reddito sull’immobile di loro proprietà per il quale però sono obbligate a corrispondere le relative imposte». Tra condizioni abitative disperanti e legittime rivendicazioni dei proprietari, a ridere sono solo i C.A.A.T., che nell’emergenza hanno trovato lavoro e soldi. Tanti soldi.

La mafia vale 150 miliardi di Pil
Redazione Edicola - Argomenti economia, filippo caleri, il tempo, mafia, sommerso
Filippo Caleri – Il Tempo
Un flusso di denaro lascia costantemente l’Italia per cercare il paradiso. Fiscale chiaramente. Soldi che sfuggono alla tassazione italiana e dunque ricchezza che lascia il Paese depauperandolo di risorse. Un fenomeno tutt’altro che marginale e che sembra crescere a vista d’occhio almeno secondo Banca d’Italia che ieri ha spiegato che «a parità di altre condizioni, i flussi indirizzati verso i cosiddetti paradisi fiscali sono di circa il 36 per cento più elevati di quelli verso gli altri Paesi esteri». Ad affermarlo il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in audizione presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, citando quanto emerge dallo studio sui bonifici verso i Paesi a rischio, frutto della collaborazione tra la Uif e il Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia. La collaborazione è stata avviata di recente e, sottolinea Visco, «la disponibilità di informazioni, la loro condivisione, sono il presupposto per interventi sempre più efficaci». Secondo il governatore, «permane l’esigenza di ampliare le fonti informative della Uif che, in contrasto con gli standard internazionali, non ha, in particolare, accesso alle informazioni investigative». Soldi che scappano e che sono il frutto anche dell’economia illegale, «probabilmente, il macigno più grave che pesa sullo sviluppo dell’economia italiana» secondo Visco. «Le stime sulla quantità di moneta in circolazione – ha detto il capo dell’istituto centrale – suggeriscono che l’economia illegale in Italia nel quadriennio 2005-2008 potrebbe pesare per oltre il 10% del Pil». Vuol dire una perdita di ricchezza che si aggira intorno a 150 miliardi. Le stime, però, non convergono.
L’Istat, parlando di economia «illegale» (stupefacenti, prostituzione, alcol e tabacchi di contrabbando) ha posto il suo valore nel 2011 allo 0,9% del Pil. Quindi meno di 15 miliardi: esattamente lo stesso valore che ha utilizzato per rivalutare il Pil dell’Italia in base alle indicazioni provenienti da Bruxelles. Transcrime (che considera droga, armi, tabacco, contraffazione, gioco e frodi fiscali) parla di un valore di questi mercati da 110 miliardi in Europa, 16 in Italia. Al di là del peso in sé, che sfugge «alle maglie del Fisco e dei processi economici normali», la presenza di una invasiva economia criminale ha anche un forte potere deterrente verso gli investimenti esteri. Visco stima che «se le istituzioni italiane fossero state qualitativamente simili a quelle dell’area dell’euro, tra il 2006 e il 2012 i flussi di investimento esteri in Italia sarebbero risultati superiori del 15% – quasi 16 miliardi – agli investimenti diretti effettivamente attratti nel periodo».

Partecipate, i bilanci oscure di quante vivono nell’ombra
Redazione Edicola - Argomenti il tempo, pietro de leo, società partecipate
Pietro De Leo – Il Tempo
Quello delle società partecipate è un allegro paradosso italiano. Se ne conosce l’enormità, la politica si affretta a condannarle in un formale afflato etico ma quando arriva il momento clou non se ne fa nulla. La stessa legge di stabilità, nel testo approvato al Senato, impone agli enti che vantano partecipazioni non virtuose una razionalizzazione, ma non risultano sanzioni. Insomma un «tenetemi che lo picchio» come per i finti bulli, autentici fifoni, dei tempi che furono. Carlo Cottarelli, commissario straordinario per la riduzione della spesa, nel suo articolato «piano di razionalizzazione delle partecipate locali», era stato chiaro: evitare che le partecipate sconfinassero dai propri compiti istituzionali, magari entrando in concorrenza di mercato con le società private; promuovere l’efficienza attraverso l’applicazione dei costi standard; mettere mano alle forbici per quelle società non operative o non virtuose. Contestualmente al programma fu diffuso l’elenco della galassia di società a partecipazione pubblica.
Così si scopre che la «maglia nera» nelle società con patrimonio netto superiore al milione di euro spetta alla Gestione Agroalimentare Molisana. Un patrimonio netto di 2.109.642 e una perdita che sfiora i 15 milioni di euro. Il Roe è del 691,92% in negativo. Dal suo sito istituzionale, la Regione Molise ci fa sapere che partecipa alla società con una quota del 100%. L’organo amministrativo è composto da un Amministratore Unico che percepisce 50 mila euro annui. Al secondo posto troviamo la «Società per la trasformazione del territorio Holding s.p.a», partecipata al 100% dal Comune di Parma. Nell’oggetto sociale si legge che è un «progetto a realizzazione di interventi complessi per la trasformazione, riqualificazione e valorizzazione del territorio». Tuttavia, l’implacabile tabella di Cottarelli ne segnala una perdita di 27.910.998, con un Roe del 488,29% negativo. Male anche l’aeroporto Gabriele D’Annunzio (che vanta una partecipazione plurima da parte degli enti locali) di Montichiari in provincia di Brescia. Di eroico ha solo il nome. Quanto a performance, il Roe è un disonorevole -217, 65% che segnala una perdita sul 2012 di quasi quattro milioni di euro.
Esistono poi le società partecipate con patrimonio negativo. Al primo posto, con -20.316.751 vi è la società Cmv, 100% partecipata dal Comune di Venezia e che controlla il celebre Casinò. Scorrendo più giù la classifica, troviamo l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, a totale capitale pubblico, con azionista di maggioranza la Regione Piemonte ma con partecipazione anche della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Torino. Dal sito si legge che «ricopre il ruolo di struttura tecnica di riferimento per lo sviluppo di azioni innovative e per il supporto alle politiche nel campo forestale, ambientale e in quello delle risorse energetiche». Patrimonio netto -196.873. E poi ci sono le società di cui non sono disponibili i bilanci: fra queste la società «Borghi marinari» della Sicilia, il lombardo «Caseificio sociale Valsabbino», la piemontese «Banca del Vino» e la pugliese «Comunità delle Università del Mediterraneo». Oltre che una «Azienda Agricola Dimostrativa» di cui non è possibile risalire né al luogo né agli enti partecipanti. Insomma tra formaggi, vini e fantasmi, c’è veramente di tutto.

Altro che posto fisso, si lavora solo a ore
Redazione Edicola - Argomenti il tempo, jobs act, laura della pasqua, lavoratori, lavoro
Laura Della Pasqua – Il Tempo
Archiviata la prospettiva di un posto fisso, per molti l’unica alternativa alla disoccupazione è saltare da un impiego precario all’altro anche nella formula dei cosiddetti mini-jobs. Si tratta del gradino più basso del precariato, sottopagato e ad elevata incertezza. A guidare l’exploit i settori del commercio, della ristorazione, del turismo e dei servizi. A tirare un bilancio è uno studio della Cgia di Mestre. Casalinghe, pensionati, badanti, studenti, disoccupati e «dopolavorisiti» sono le categorie che usufruiscono più di tali voucher, ovvero della possibilità di essere «assunti» per qualche ora da un committente venendo retribuiti attraverso l’utilizzo di un «buono- lavoro» di 10 euro lordi all’ora (pari a 7,5 euro netti).
I mini-jobs proliferano soprattutto nel Nordest: l’anno scorso sono stati venduti oltre il 40% del totale nazionale dei «buoni»: il 28,5% nel Nordovest, il 16,6% nel Centro e il 14,8% nel Sud e nelle Isole. Dal 2012, dice ancora la Cgia, anno in cui questo strumento è stato esteso a tutti i settori economici, il ricorso è più che triplicato: da poco più di 23.800.000 ore utilizzate due anni fa si è passati a 71.600.000 ore previste per l’anno in corso. Numeri triplicati anche se si analizza il trend dei lavoratori interessati: nel 2012 sono state coinvolte poco più di 366.000 persone, quest’anno, invece, ne sono previste più di un milione.
Ma questa forma di precariato ha comunque un risvolto positivo. Il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi, spiega che «proprio in virtù di questo strumento è stato possibile far emergere una quota di sommerso che altrimenti sarebbe stata difficile da contrastare. Ora, anche i lavoretti saltuari sono tutelati. In più, chi viene assunto per poche ore con questi buoni può menzionare nel suo curriculum questa esperienza. Inoltre, per limitare l’utilizzo improprio di questi buoni, il legislatore ha stabilito che ognuno di questi deve essere orario, datato e numerato progressivamente». Tuttavia, la possibilità di aggirare la norma non manca: purtroppo, questa possibilità è presente in qualsiasi caso, figuriamoci quando si tratta di un accordo che, come in questi casi, è di natura verbale.
I voucher rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro possono utilizzare per remunerare quelle prestazioni svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro, garantendo al prestatore d’opera la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail. Sia per l’imprenditore sia per il lavoratore la legge stabilisce degli importi annui limite oltre ai quali l’utilizzo dei voucher non è più consentito. Lo scarto tra il numero dei voucher utilizzati e quelli venduti si sta assottigliando sempre di più: se nel 2013 l’incidenza dei primi sui secondi era dell’88,5, per l’anno in corso ale al 93,8%. Nel 2013, ultimo anno in cui sono disponibili i dati ufficiali, i settori maggiormente interessati dall’utilizzo di questi «buoni-lavoro» sono stati il commercio (25,2% del totale dei lavoratori coinvolti), il turismo-ristorazione (17,6%), e i servizi (13,6). Resta comunque molto elevato l’uso dei voucher anche nel settore manifatturiero (19,5%).


