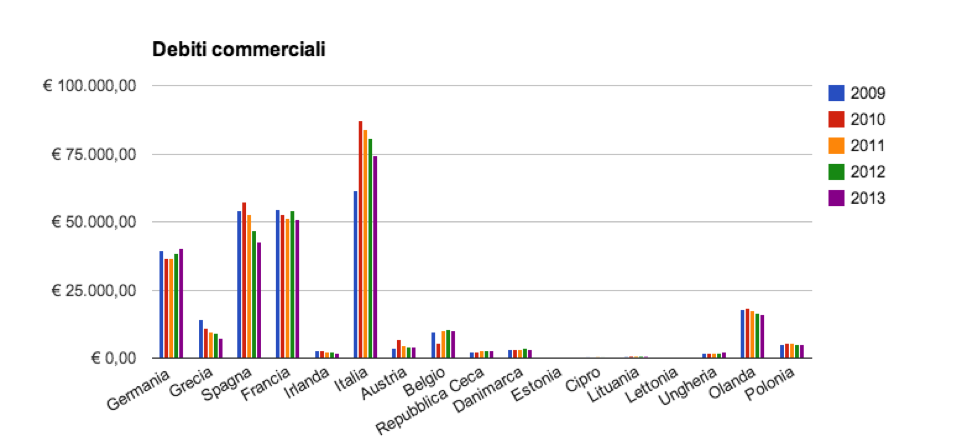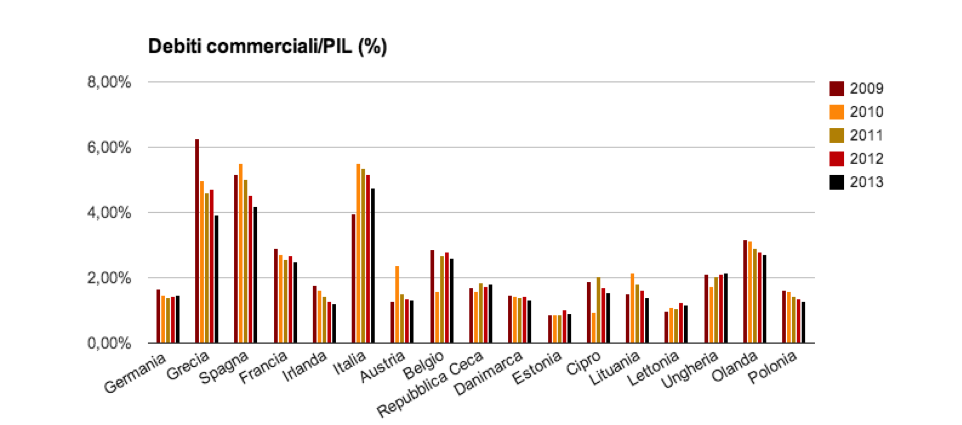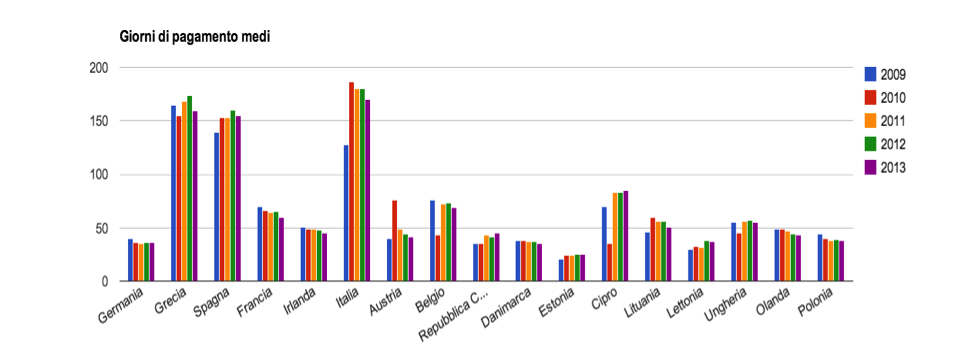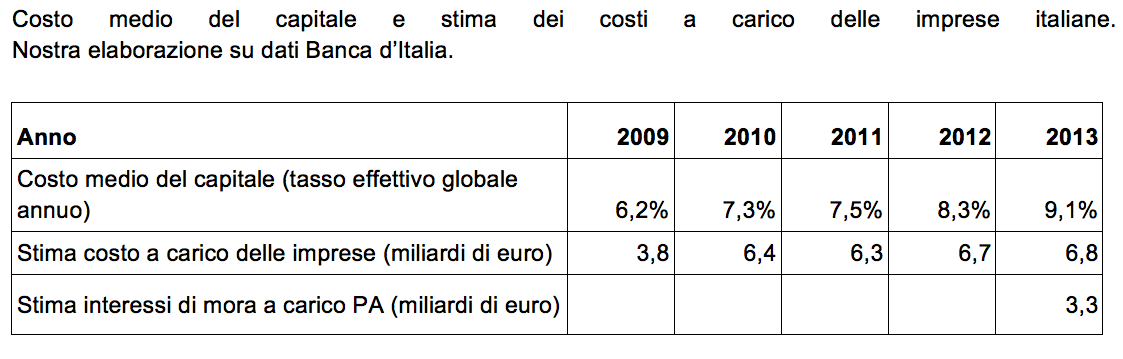SCARICA I GRAFICI E LE TABELLE DEL NOSTRO PAPER
Debiti Commerciali della Pubblica Amministrazione: confronto con gli altri paesi europei.
Debiti Commerciali della Pubblica Amministrazione in rapporto al Pil: confronto con gli altri paesi europei.
Giorni medi per il pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione: confronto con gli altri paesi europei.
Costi a carico delle imprese italiane.