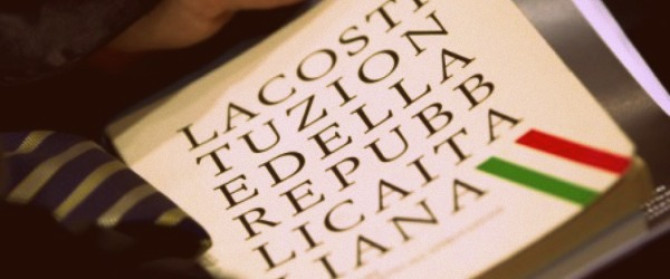Contarelli
Davide Giacalone – Libero
I soldi non ancora risparmiati sono stati già impegnati e spesi. Lo sapevamo e lo scrivevamo prima che lo ricordasse il commissario alla revisione della spesa, Carlo Cottarelli. I soldi per onorare le promesse già fatte non ci sono. In autunno servirà una correzione dei conti per un minimo di 15 o 20 miliardi, ma che nessuno osi chiamarla manovra o stangata. Chiamiamola rottamazione delle assicurazioni date, così si continua il viaggio verso l’avvenire. Tutto questo è il meno, anche perché scontato, mi preoccupano ancora di più i soldi che non sono ancora stati incassati, derivanti dall’equivoco capitolo delle “privatizzazioni”. Come si pensa di utilizzarli? Perché se andranno a equilibrare le partite correnti, a finanziare la spesa, anziché ad abbattere il debito, avremo assicurato la rovina d’Italia. Quella che dovrebbe essere un’arma vincente rischiamo di puntarcela alla tempia, inebetiti dal suo fugace effetto stupefacente.
Nel novembre dell’anno scorso scrivevamo che se il lavoro di Cottarelli fosse andato a buon fine (e ce lo auguravamo), avrebbe inevitabilmente comportato scelte politiche. Al tecnico si chiede la conoscenza, al politico spetta la decisione. Quello di cui finge d’accorgersi Matteo Renzi, quindi, ci era chiaro e lo chiarivamo fin dall’inizio. Scegliere significa discernere fra interessi contrapposti e rompere con le costose e improduttive retoriche in voga. Fin qui, invece, i tagli alla spesa pubblica si sono applicati seguendo due scuole: a. i tagli lineari (il copyright è di Gordon Brown), ciechi e deprecati, ma funzionanti; b. i risparmi dovuti a maggiore efficienza. Nessuno dei due approcci sfiora il problema italiano: troppa spesa, per troppe cose, cui si aggiungono mostruosi interessi sul debito. Noi non dobbiamo (solo) risparmiare, dobbiamo sopprimere funzioni pubbliche disfunzionali. Invece si pensa di rendere pubbliche e rette da spesa pubblica anche le banche del seme. Che la sinistra insegua lo statalismo, cullante e sepolcrale, è frutto di una cultura. Sbagliata. Che faccia lo stesso la destra è frutto di vuoto culturale.
Per questo mi fanno paura quelle privatizzazioni che, per altro verso, auspico. Già è capitato: noi chiediamo vendite e ci ritroviamo con svendite; noi chiediamo più mercato e ci ritroviamo con più mercanti. Se si vendono altre azioni Eni, o una quota della società delle reti, se si punta alla quotazione di Poste o di RaiWay, e così via, dove finiscono i proventi e che si fa del resto? Perché quella roba è patrimonio pubblico, pagato dai contribuenti, ed è bene che sia ben valorizzata e, se venduta, che il ricavo vada massicciamente ad abbattere il debito pubblico, che grava sui contribuenti. Semmai una parte agli investimenti. Neanche un centesimo alla spesa corrente. Ma se, giusto per retare a un esempio, la Rai pensa di usare l’incasso per finanziare un baraccone che andrebbe sbaraccato e venduto nel suo insieme, allora occhio, perché si prepara una gigantesca opera di depredazione e dilapidazione. Al termine della quale saremo più poveri e più indebitati, salvo avere goduto una breve parentesi d’equilibrio nei conti pubblici.
Per evitare che tutti i conti finiscano in contarelli, per evitare che ci si accorga dell’ovvio con mesi e anni di ritardo, direi che non si vende nulla se prima non sono disponibili: 1. il piano generale delle dismissioni; 2. il metodo che si intende seguire (pezzo a pezzo, società di partecipazioni, mandato unico a vendere, etc.); 3. l’impegno non derogabile su come usare i soldi incassati. Si aggiunga che vendere non deve servire solo a far cassa, ma anche mercato. Attirando capitali per investire nella creazione di ricchezza. Da questo punto di vista il decreto “competitività”, che modifica il diritto societario e trasforma la capacità di voto delle azioni, per le società quotate, introducendo il “voto plurimo”, serve a blindare gli assetti esistenti, quindi va in direzione opposta. Con quel meccanismo dall’estero investiranno solo in rendite, portandoci via ricchezza, ma non lo faranno in produzione. E’ un tema tecnico e noioso, ma se chi mette soldi non conta per quanti soldi ci mette semplicemente li mette altrove.
Comprare il consenso elettorale con la spesa pubblica è costume deprecabile e non nuovo. Comprare l’omertà sulle reali condizioni dei conti pubblici e sulle conseguenze del loro mancato risanamento, usando soldi derivanti da patrimonio per occultarle, è costume altrettanto immondo. E disperato. Una grossa parte degli italiani amano essere ingannati, sperando che nulla cambi. Ma a pagare il conto è solo l’altra parte, quella che ancora ci consente d’essere la seconda potenza industriale d’Europa. Sono italiani in minoranza e in crescente difficoltà. Fregarli ancora significa suicidare la nostra sovranità economica. Dopo di che quella politica sarà solo la pacchiana rappresentazione di un Parlamento combattente e irrilevante.