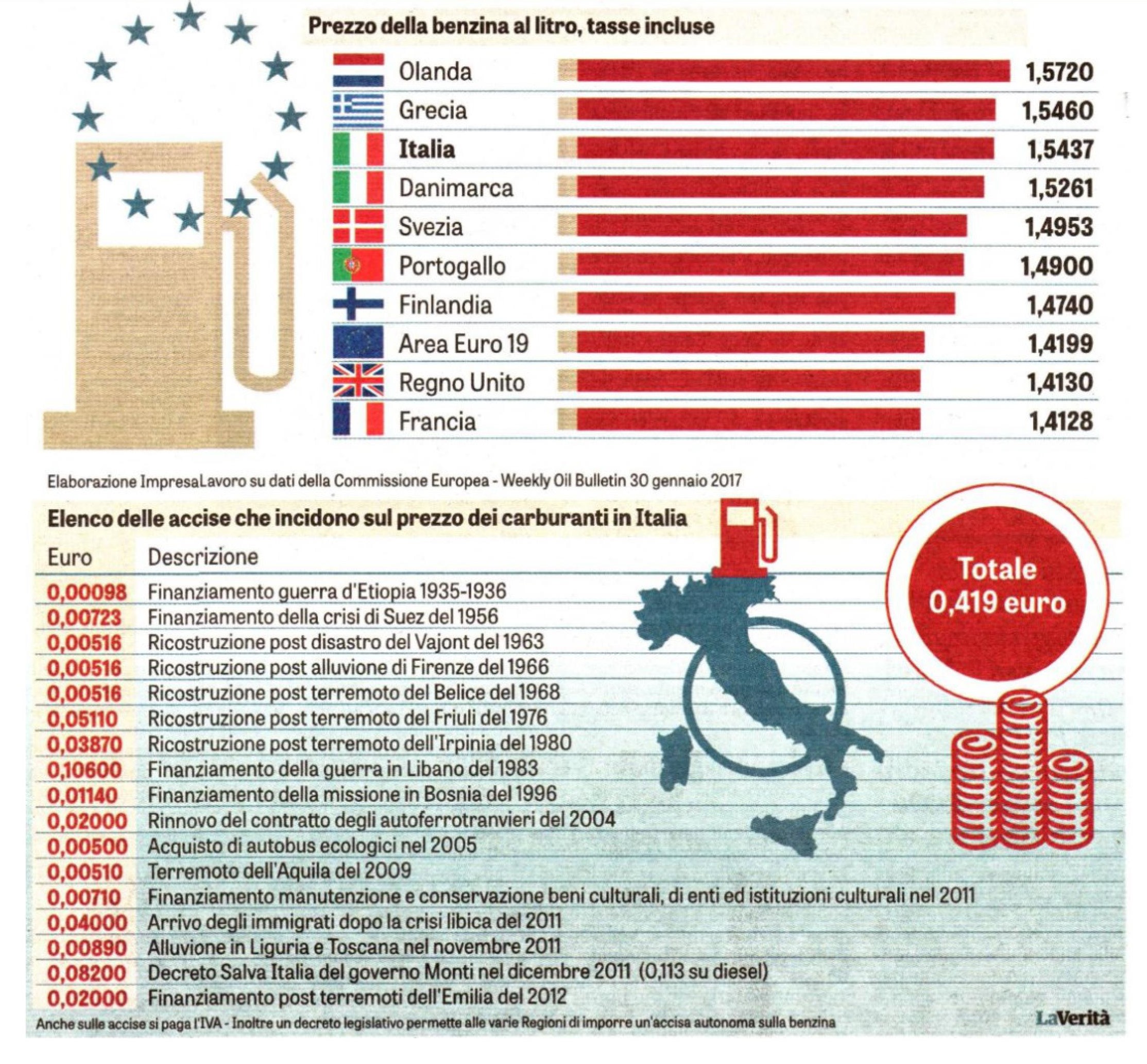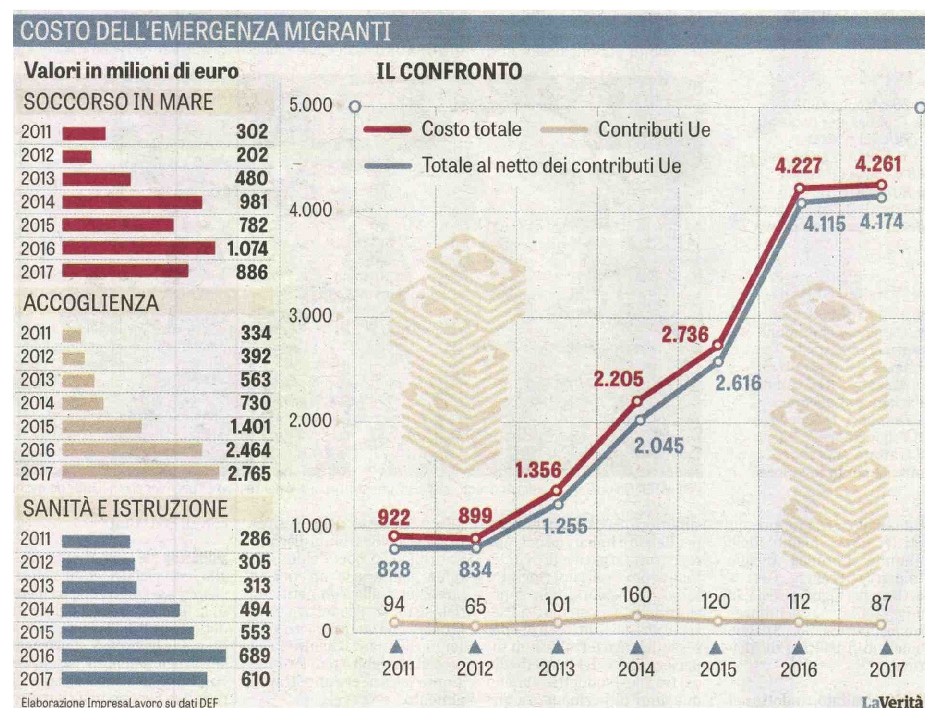Le Regioni a statuto speciale Eden dei dipendenti pubblici
di Adriano Scianca – La Verità
Ma che ci dovrà fare mai, la Valle d’Aosta, con il doppio dei dipendenti pubblici della Lombardia? Parliamo di dati in percentuale rispetto agli abitanti, sia chiaro, eppure tutti questi impiegati dispersi in mezzo alle placide montagne sembrano un po’ messi lì a caso, soprattutto se li paragoniamo ai dipendenti pubblici in servizio nella Regione della capitale economica d’Italia. Non è peraltro l’unico paradosso della Pubblica amministrazione italiana. Ne emergono un bel po’, infatti, dalla ricerca del centro studi ImpresaLavoro (presieduta dall’imprenditore Massimo Blasoni) su elaborazione di dati Istat e della Ragioneria generale dello Stato.
In rapporto a popolazione residente, i 3 milioni e 142.000 dipendenti pubblici italiani sono inferiori a quelli delle altri grandi economie europee ma la loro distribuzione sul territorio nazionale non è affatto omogenea, nemmeno rispetto al numero degli occupati. A fronte di una media italiana del 5,18%, sono le Regioni a statuto speciale quelle con la maggior concentrazione di dipendenti pubblici rispetto alla popolazione residente. A guidare la classifica è infatti la Valle d’Aosta con 11.519 dipendenti, pari al 9,05% dei residenti (bambini e anziani inclusi), davanti al Trentino Alto Adige (78.344 dipendenti, pari al 7,40% dei residenti), Friuli Venezia Giulia (82.380, pari al 6,75% dei residenti) e Sardegna (109.036 dipendenti, pari al 6,53% dei residenti). Segue il Lazio, che sconta l’elevato numero di sedi istituzionali presenti a Roma (380.284. dipendenti, pari al 6,46% dei residenti). In fondo a questa particolare classifica si collocano invece Regioni più popolate ed economicamente più sviluppate come la Lombardia (4,02%) e il Veneto (4,51%). Al di sotto della media nazionale troviamo anche Campania (4,82%), Piemonte (4,86%), Emilia Romagna (5%), Puglia (5%) e Marche (5,17%).
La classifica elaborata da ImpresaLavoro cambia piuttosto nettamente se si prende in esame il rapporto tra il numero dei dipendenti pubblici e quello degli occupati. Al primo posto troviamo la Calabria, con il 22,03%: praticamente, dalle parti della Sila, più di un occupato su quattro è un impiegato statale.Un vero e proprio «lavorificio» che sembra creato più per sistemare le persone che per amministrare una regione che, pure, di problemi da risolvere ne avrebbe. Subito dietro si colloca ancora la Valle d’Aosta, con il 21,01% degli occupati che vengono retribuiti con denaro pubblico. In cima a questa classifica compaiono principalmente le regioni del Mezzogiorno, con un’incidenza dell’impiego pubblico di gran lunga superiore alla media nazionale (13.99%): Sicilia (19.95%), Sardegna (19,30%), Molise (18,06%), Campania (17,89%), Basilicata (17,87%) e Puglia (17,42%) seguite a distanza ravvicinata dal Friuli Venezia Giulia (16,62%) che registra uno dei valori più alti di tutto il Centro-Nord. In coda alla classifica troviamo invece Lombardia (9,44%), Veneto (10,80%), Emilia-Romagna (11,59%) e Piemonte (11,90%).
In compenso viene smentito il luogo comune per cui l’Italia avrebbe più dipendenti pubblici del resto dei Paesi industrializzati. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, in rapporto al numero dei residenti solo la solita Valle d’Aosta ha una percentuale di dipendenti pubblici (9,05%) superiore a quella di Francia (8,50%) e Regno Unito (7,90%). Mentre la media italiana (5,18%) risulta più bassa di quella di Spagna (6,40%) e Germania (5,70%), con 11 Regioni italiane che vantano un tasso di presenza dei dipendenti pubblici inferiore alla media tedesca. Le cose cambiano, ma solo marginalmente, quando ImpresaLavoro prende in esame il numero di dipendenti pubblici in rapporto al numero degli occupati. In questo caso, solo le percentuali di Calabria e Valle d’Aosta sono superiori a quella della Francia (20%). La percentuale di dipendenti pubblici in Italia (13,99%) è invece inferiore a quella di Regno Unito (17%) e Spagna (16%), superando solamente il dato della Germania (11%).
Insomma, l’impressione è che il vero gap, rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, non sia tanto nella sostanza, quanto nell’organizzazione. E poi c’è il nodo, tutto italiano, delle Regioni a statuto speciale. Vere sanguisughe, per lo Stato. È di giovedì scorso il rifiuto, da parte delle Regioni «speciali» di farsi carico dei tagli alla sanità, cosa che potrebbe mettere a rischio l’erogazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza per tutte le altre Regioni. È stato calcolato che su mille euro versati al fisco dal cittadino di una Regione a Statuto ordinario ne rientrano più o meno 200. A un residente di una regione a Statuto speciale tornano invece ben 900. Ora scopriamo che hanno anche un esercito di dipendenti pubblici che a confronto la Germania è il Gabon. Qualcosa, nella Pubblica amministrazione, va rivista.