
economia


Si vince o si perde tutti insieme
Redazione Edicola - Opinioni alfonso ruffo, disoccupazione, economia, il sole 24 ore, lavoro
Alfonso Ruffo – Il Sole 24 Ore
Se tutto va bene siamo rovinati. Cinquant’anni di politiche straordinarie, speciali, di vero o presunto favore, sono stati gettati al vento da una crisi che nel Mezzogiorno dura da sei anni senza interruzioni, promette di resistere anche per i prossimi due e viene paragonata alla Grande Crisi che negli anni Trenta del secolo scorso atterrì l’America. Il risultato è che il divario tra il Nord e il Sud riprende ad allargarsi facendo dell’Italia il Paese con l’economia duale più marcata al mondo, con differenze così forti da un luogo all’altro da rendere la media nazionale un puro dato statistico. Insomma siamo in presenza di due realtà economiche diverse e distanti. Il Rapporto Svimez presentato ieri è in proposito molto eloquente: «Sei anni di recessione ci lasciano un’Italia ancora più divisa e diseguale». Insomma, il Mezzogiorno affonda porta in basso con sé un Centro-Nord che avrebbe ripreso a galleggiare nonostante il perdurare dei marosi. Si spiega così come sia possibile che l’economia italiana nel 2013 sia stata battuta in peggio in Europa solo dalla disgraziata Grecia e dalla piccola Cipro. Le regioni meridionali si avvitano in un circolo vizioso che rischia compromettere qualsiasi capacità di ripresa per una vera e propria dissoluzione della base materiale della crescita come il crollo degli investimenti, in particolare di quelli industriali che risultano dimezzati, fa ragionevolmente temere. La Svimez parla senza mezzi termini di eutanasia.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: i due terzi dei nuovi disoccupati si concentrano al Sud dove i posti di lavoro precipitano al livello di quaranta anni fa e solo un giovane su quattro trova impiego. Il prodotto pro capite torna alla consistenza del 2003 nonostante il progressivo calo degli abitanti. I consumi vanno a tappeto. E non solo quelli voluttuari, come sarebbe naturale, ma anche quelli di prima necessità come gli alimentari. Non è un caso che sia raddoppiato il numero delle famiglie cadute in povertà. Cala la spesa per l’istruzione e per la cura della persona con particolare evidenza su scarpe e vestiti. Chi può abbandona il campo. Sono sempre di più i giovani capaci che lasciano i luoghi di origine e cercano fortuna altrove. Naturalmente non mancano le dovute eccezioni, imprenditori coraggiosi piantati al Sud ma abituati a confrontarsi col mondo; pronti a innovare, sperimentare, conquistare spazio e fatturato. Non hanno nulla da invidiare ai colleghi di qualsiasi parte del globo ma per esistere sanno di diversi sacrificare più degli altri. La preoccupazione è seria. Tanto più che l’interdipendenza tra le due parti del Paese, tra il Sud che sembra afferrato dalle sabbie mobili e il Nord che vorrebbe rimettersi a correre, è più forte di quanto si possa immaginare dal momento che il 75% della produzione settentrionale è ancora rivolto al mercato interno. Il destino dell’Italia è uno. Si vince o si perde tutti insieme. Sullo sfondo ci sono sempre e ancora i fondi europei della vecchia e nuova programmazione che le Regioni dovrebbero imparare a usare bene per migliorare la dotazione d’infrastrutture, materiali e immateriali, e innalzare la capacità di competere.

Ci possono essere stimoli che sanno essere rigorosi
Redazione Edicola - Opinioni alberto mingardi, economia, franco debenedetti, il sole 24 ore, spending review
Franco Debenedetti – Il Sole 24 Ore
Stop all’austerità, sì alla crescita: è il motto dei referendum per abrogare parti della legge che attua il principio costituzionale del pareggio di bilancio. Iniziativa per più versi singolare: non è impresa da poco raccogliere le firme; è controverso che sia “referendabile” una legge approvata con speciali modalità; il pareggio di bilancio è da sempre una bandiera della destra e tra i proponenti ci sono persone che della destra sono stati esponenti di rilievo. E soprattutto si vogliono togliere obbiettivi di bilancio più gravosi di quelli europei: ma non era l’Ue a strangolarci?
Non è austerità il pareggio di bilancio: anche la nuova formulazione, dopo che quella del vecchio art. 81 aveva consentito il formarsi di uno dei maggiori debiti al mondo, consente elasticità per tener conto del ciclo. Il trattato di Maastricht ne fissa il limite nel 3% del Pil, oltre scatta la procedura di infrazione: rispettare quel limite di elasticità viene chiamato austerità. Quanto al debito, doveva essere il 60% del Pil, siamo a più del doppio, abbiamo firmato un trattato che ci impegna a rientrare in 20 anni: rispettare quell’impegno è chiamato austerità. Certo è diverso ripagare i debiti quando l’inflazione è al 2% e la crescita al 3% reale, o quando inflazione e crescita sono entrambi prossimi a zero. Quindi all’inflazione ci pensi la Bce, alla crescita i governi dell’Europa, rendendosi conto che questa è una crisi da domanda, da cui è possibile uscire con interventi che la stimolino: non riconoscere questa soluzione è “austerità”. Ma siccome fare debiti nuovi per meglio pagare quelli vecchi è un’idea che i creditori potrebbero trovare stravagante, si cerca di trovare come, e a spese di chi, sforare sui vincoli senza far sorgere dubbi. Così Paolo Savona sul Sole 24 Ore, considerando che per noi sarebbe un suicidio obbligarsi a decenni di avanzi primari, propone che l’Italia abbatta il debito vendendo cartelle di una maxiprivatizzazione da 400 mld. Jean Claude Juncker, per avere i voti socialdemocratici, promette di spendere 300 mld in infrastrutture. Ma le privatizzazioni dànno soldi veri solo se chi compera può liberamente disporre dei beni acquistati; per le infrastrutture bisogna che i soldi spesi ritornino come profitti.È un problema di domanda? In Europa, può darsi; da noi, fuor di dubbio che c’è (soprattutto) un problema di offerta. È da prima dell’euro che abbiamo incominciato a perdere competitività: ci stupiremmo se i soldi dello stimolo venissero spesi a comperare Bmw anziché Thesis? Il divario di produttività verso l’estero varia da settore a settore, con picchi di eccellenza e diffusi ritardi, ma quella totale dei fattori grava su tutta la nostra economia, e dipende molto dalla qualità dei servizi pubblici, nazionali e locali. Misure anticicliche potranno esserci utili, riforme strutturali sono essenziali. Non possiamo confondere. Invece c’è chi ha interesse a farlo: perché così i lamenti per i sacrifici che inevitabilmente le riforme comportano vengono a fare tutt’uno con quelli per l’austerità; e perché gli stimoli per contrastare l’austerità possono essere dirottati a evitare riforme.
Un anno fa, l’Istituto Bruno Leoni aveva pubblicato un’idea per uno stimolo, firmata da Natale D’Amico e Alberto Mingardi. Uno schema preciso: un taglio per tre anni di fila delle imposte sui redditi, finanziato con privatizzazioni di pari entità, 30 miliardi l’anno per 3 anni. Nessuna modifica all’elevato grado di progressività del sistema tributario. Dopo tre anni, l’entità da rifinanziare non sarebbe più di 30 mld l’anno: i soldi, ancor più se non intermediati dallo stato, ma messi direttamente nelle mani dei cittadini, avrebbero prodotto benefici per l’economia e per l’erario, come sostengono i promotori degli stimoli. Nel frattempo ai proventi da dismissioni dovrebbero essersi aggiunti anche i risparmi da spending review. Tanto privatizzazioni da 30 mld per tre anni? Il doppio dell’1% previsto dal governo, ma meno di un quarto dei 400 di Savona. Ci saranno da modificare assetti societari, contratti di lavoro, disposizioni di legge. Garantire la contemporaneità tra ricavi e spese sarà impossibile: ma un programma serio e dettagliato troverebbe orecchie attente. Il vero problema è politico: è sostenibile, è credibile un impegno che si estende su un arco di tre anni? Appare evidente come le riforme istituzionali che riducano le tortuosità del processo legislativo e rafforzino l’esecutivo sono condizione indispensabile per le riforme di struttura. E per superare l’austerità.
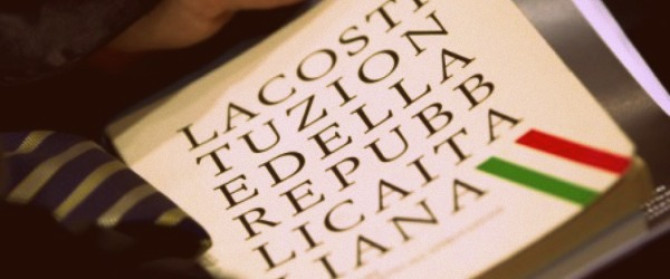
Sui conti si gioca la credibilità dell’Italia, pericolose le tentazioni sull’articolo 81
Redazione Edicola - Opinioni alberto mingardi, Corriere della Sera, economia, fiscal compact, spesa pubblica
Alberto Mingardi – Corriere della Sera
È noto che gli oppositori delle riforme istituzionali, versione Renzi, vorrebbero che la Costituzione restasse così com’è. Ma fanno un’eccezione: per l’articolo 81, modificato nel 2011 perché prevedesse l’«equilibrio» fra uscite e entrate dello Stato. Nei giorni scorsi ne hanno parlato in due interviste sia Nichi Vendola sia Massimo Mucchetti. È una battaglia tutta simbolica: la sinistra ci legge una sorta di rifiuto costituzionale del keynesismo. Per la verità, la stessa cosa si poteva dire dell’art. 81 originario, che obbligava a indicare i mezzi per far fronte alle nuove spese. Sappiamo come andò a finire: sul punto, la Costituzione più bella del mondo rimase lettera morta. Il nuovo art. 81 esige l’«equilibrio» di bilancio, ma aggiustato al ciclo economico, da quest’anno. Subito le Camere hanno votato per consentire al governo di disattenderlo. Si può considerare eccessivamente inflessibile una norma che si lascia forzare già al momento del debutto?
Gioverebbe forse ricordare perché, nel 2011, ci si affrettò a riscrivere l’art. 81. La marcia apparentemente inarrestabile dello spread imponeva di dare un segnale circa la serietà delle nostre intenzioni, quanto a riordino della finanza pubblica (seguendo l’esempio dei tedeschi, che per primi hanno costituzionalizzato il pareggio). Il percorso di revisione costituzionale ebbe inizio sotto il governo Berlusconi e si concluse con il governo Monti ed è in coerenza con il trattato detto Fiscal compact. Che il legislatore abbia voluto tenersi le mani libere, si capisce dal fatto che si parla di «equilibrio» di bilancio, più rassicurante del «pareggio». Le norme costituzionali sono materia plastica nelle mani del ceto politico: la «sterilizzazione» dell’art. 81, quest’anno, lo conferma. Cosa pensare, però, di una classe politica così ansiosa di divellere un argine, sia pure tanto debole, alla propria voracità? Che ne direbbero investitori e partner europei? Chi vuole riscrivere l’art. 81 intende affermare il principio della più ampia discrezionalità nella spesa pubblica. Principio che in Italia ha un’antica tradizione e solide realizzazioni: a cominciare dai nostri 2.200 miliardi di debito.

Crescono le aziende esportatrici in Italia: performance superiori a Francia e Spagna
Redazione Edicola - Argomenti carmine fotina, economia, esportazioni, export, il sole 24 ore
Carmine Fotina – Il Sole 24 Ore
A piccoli passa avanza il plotone degli esportatori italiani. L’annuario Istat-Ice 2014, presentato ieri, segnala un aumento dell’1,3% degli operatori all’esportazione nel 2013, incluse le semplici partite Iva. Cresce dunque la propensione a tentare la strada dei mercati internazionali, complice anche la stagnazione della domanda interna.
In tutto siamo a 211.756 operatori, numero che il governo punta ora a incrementare con il piano straordinario per il made in Italy che potrebbe approdare già al consiglio dei ministri di domani, agganciato al decreto sblocca-Italia (si veda altro articolo in pagina).
L’analisi del presidente Istat, Giorgio Alleva, mostra ancora un certo grado di frammentazione a testimonianza di un’avanguardia a cui si deve buona parte delle performance del nostro export. Questa caratteristica diventa più evidente in termini di redditività, crescente al crescere dell’apertura internazionale dell’impresa: dal 18,7% delle non esportatrici si passa al 22,9% per quelle che esportano meno del 5% della produzione fino a un massimo del 31,3% per le unità che vendono all’estero oltre l’80% della produzione. Per il viceministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il lavoro che il governo deve portare a termine è soprattutto finalizzato a trasformare in esportatori stabili le imprese che hanno maggiori potenzialità. Sono 10-15mila le imprese più integrate sui mercati esteri, 30mila quella in posizione intermedia e «70mila che esportano in modo saltuario: è proprio su quest’ultime che dobbiamo lavorare».I nuovi esportatori si troveranno a competere in uno scenario con diversi elementi instabili ma comunque ancora con ottime prospettive per il made in Italy. Nel 2013 le esportazioni di merci dell’Italia sono rimaste all’incirca stazionarie (-0,1%) mentre sono aumentate dell’1,4% quelle di servizi. L’avanzo commerciale è notevolmente aumentato, passando da 9,9 a 30,4 miliardi – anche per effetto del calo delle importazioni –: il dato più elevato dell’ultimo decennio.
Venendo alle tendenze recenti, il dato cumulato dei primi cinque mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013 mostra un aumento dell’export italiano dell’1,3% ma con un’ampia divaricazione per aree (+4,1% verso la Ue, -2% verso l’extra Ue). Da notare come il contributo alla crescita dell’export totale da parte degli operatori con processi di export più collaudati sia in ulteriore crescita, al 3,1%, dopo il 2,1% del 2013 e il 2,5% del 2012.
E sale, anche se si parla di decimali, la competitività generale del Paese, sottolinea il presidente dell’Ice Riccardo Monti. Nel 2013 la quota di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali è passata dal 2,74 al 2,79% a fronte di un aumento più risicato della Germania e di una crescita zero della Francia. «Rispetto agli altri concorrenti dell’area euro – osserva Monti – le esportazioni hanno guadagnato quota soprattutto nella farmaceutica, nella pelletteria, nei mobili e nei macchinari». Lo spaccato per aree geografiche, invece, vede miglioramenti in Medio Oriente e Nord Africa, ma anche in aree tradizionali come il Nordamerica e l’Asia orientale. L’aumento sebbene limitato delle quote – mette in evidenza il presidente dell’Ice – è particolarmente significativo perché conseguito malgrado l’andamento sfavorevole dei cambi e il limitato accesso al credito all’esportazione.

Quando la multinazionale ci fa del bene
Redazione Edicola - Opinioni economia, fabrizio onida, il sole 24 ore, investimenti
Fabrizio Onida – Il Sole 24 Ore
Sapete qual è la maggiore impresa italiana esportatrice di prodotti ad alta tecnologia, con circa 10 miliardi di euro? L’americana General Electric, tramite le sue controllate italiane Nuovo Pignone (turbine a gas per centrali e condotte), e Avio (componentistica aerospaziale e aeronautica).
Così Riccardo Monti, presidente della nuova Agenzia-Ice, ha sorpreso una buona parte del pubblico che ieri mattina ascoltava la presentazione del rapporto annuale Ice-Istat “L’Italia nell’economia internazionale 2013-2014”. Sotto lo stesso profilo avrebbe potuto citare anche la italo-francese STMicroelectronics, uno dei maggiori produttori mondiali di circuiti integrati capaci di accogliere le esigenze degli utilizzatori più sofisticati. Del resto l’Istat ci ricorda ogni anno che il 24 per cento delle spese di R&S in Italia e circa il 25 per cento delle esportazioni origina dalle imprese a controllo di capitale estero, le quali generano l’11 per cento del valore aggiunto di industria e servizi.
Un’analisi su quasi 500 acquisizioni estere di imprese italiane negli ultimi 10 anni, commissionata a Prometeia dal viceministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda e illustrata nella stessa occasione dal suo capo Segreteria Marco Simoni, conferma quanto emerge sistematicamente da studi settoriali e da microdati in diversi paesi, cioè che le imprese a controllo estero realizzano migliori performance di crescita del prodotto e maggiore dinamica occupazionale. L’impatto del controllo estero su imprese a precedente controllo italiano si fa sentire non tanto sull’impianto generale dell’attività produttiva (tipo di prodotti, design, canali di approvvigionamento ecc.) quanto su efficienza gestionale, crescita dimensionale, nuovi mercati di sbocco, solidità e articolazione finanziaria (minor dipendenza dal canale puramente bancario), organizzazione e selezione dei canali distributivi. Dite poco?Più in generale, l’ingresso del controllo estero nella pianificazione e gestione promuove un più incisivo inserimento nelle cosiddette catene globali del valore, in cui l’impresa acquisita viene spinta a processi di diversificazione e specializzazione con un respiro globale. Un sia pur sommario confronto internazionale negli ultimi anni suggerisce che il Prodotto interno lordo dei paesi che hanno attratto quote maggiori di investimenti dall’estero è cresciuto più della media.
Certo la storia economica italiana recente ha visto casi di acquisizioni dall’estero che, lungi dallo scatenare processi virtuosi, hanno concorso a dimagrire, ridimensionare e talora disintegrare pre-esistenti significative eredità di eccellenze tecnologiche. Eccellenze spesso accumulate sotto l’ombrello delle nostre Partecipazioni statali, poi cedute al miglior offerente, senza alcun disegno di politica industriale, in mancanza di imprenditori nostrani disposti a mettere capitale proprio e scommettere sul loro futuro (come Farmitalia Carlo Erba, Olivetti, Italtel, Telettra, pezzi della chimica fine di Eni e Montedison).Ma un sano giornalismo non farà mai abbastanza nel contraddire con fatti e opinioni una rozza mentalità, purtroppo abbastanza diffusa anche presso esponenti politici e sindacali mediamente illuminati, e peraltro in palese contraddizione con se stessa, secondo cui bisogna andare in giro per il mondo ad attirare investitori esteri nei nostri territori, ma quando grandi gruppi industriali e fondi di investimento di tutto rispetto si fanno avanti, per subentrare a proprietà familiari italiane ormai indebolite e talora prigioniere di conflitti interni inter-generazionali (magari dopo la terza generazione imprenditoriale), gridano all’invasione dello straniero e alla dissipazione del glorioso “made in Italy”. Quasi che lo straniero fosse dominato da un cinico desiderio di rivalsa, e non dal concreto interesse a valorizzare il potenziale di business ancora non pienamente espresso di quel medesimo “made in Italy”, che da solo è in grado di colmare i gusti dei consumatori, fino a imporre un “premium price” rispetto alla concorrenza che viene dal basso.

Imprese, risale la fiducia
Redazione Edicola - Argomenti economia, il sole 24 ore, impresa, imprese, Rossella Bocciarelli
Rossella Bocciarelli – Il Sole 24 Ore
A luglio è risalito verso i massimi degli ultimi tre anni l’indicatore di fiducia dell’insieme delle aziende italiane, passando a quota 90,9 da 88,2 di giugno (il 2005 è base=100). È un segnale positivo e lascia sperare che, dopo due trimestri di stagnazione, nel terzo trimestre del 2014 possa rendersi percepibile qualche refolo di ripresa economica. L’Istat precisa tuttavia che dietro al miglioramento complessivo delle attese, vi sono in realtà aspettative diverse nei vari settori dell’economia: «L’indice complessivo – spiega infatti l’Istituto di statistica – è la sintesi di aumenti della fiducia delle imprese dei servizi, delle costruzioni, del commercio al dettaglio e della lieve diminuzione della fiducia delle imprese manifatturiere». In effetti, se si considera il solo settore manifatturiero, che era stato il primo nei mesi scorsi a registrare dei miglioramenti di aspettative, si vede che quello di luglio è il secondo calo consecutivo, perché peggiorano le valutazioni delle imprese sull’andamento corrente degli ordini (in particolare di quelli sul mercato interno) e della produzione; quanto al futuro, sono stabili le aspettative delle aziende manifatturiere sugli ordinativi mentre migliorano le attese sulla produzione; peggiorano, però, le valutazioni sull’economia in generale e sull’occupazione. Il tono del sentiment delle imprese manifatturiere è inoltre piuttosto differenziato sia se si considerano i raggruppamenti principali di industrie sia se si fa riferimento alle aree geografiche: a luglio la fiducia peggiora in tutti i macrosettori, tranne che in quello dei beni di consumo; sale nel Nordest e nel Centro Italia, mentre scende nel Nord ovest e nel Mezzogiorno.
Le note davvero positive del report dell’Istat si rintracciano invece nei dati trimestrali sulla capacità produttiva (il grado di utilizzo degli impianti è salito al 72,6 per cento nel secondo trimestre contro il 71,6 del primo) e, soprattutto, si desumono dall’indagine sulle aziende non manifatturiere: il sentiment migliora sia nelle costruzioni, sia nei servizi, sia nel commercio. E migliora, in particolare, per il secondo mese consecutivo, il morale delle aziende dell’edilizia, che risale da livelli molto depressi. «Si tratta nel complesso di un buon dato – osserva il chief economist di Nomisma, Sergio De Nardis – ma è da prendere con cautela, tenendo conto della perdita di spinta dell’industria e, soprattutto, dell’esperienza del passato». Da circa un anno, infatti, le indagini campionarie stanno segnalando miglioramenti economici in arrivo senza che questo si sia tradotto sinora in concreti aumenti di prodotto: c’è stato quindi, sinora, uno scollamento fra attese e realtà effettiva dell’attività produttiva. Intanto ieri anche l’Abi ha diffuso le più aggiornate previsioni provenienti dagli uffici studi delle aziende di credito attraverso il suo rapporto Afo. Le stime confermano che nel 2014 la crescita media del Pil italiano difficilmente supererà lo 0,3 per cento: il numero appare più o meno in linea con quanto hanno già previsto Bankitalia, Fondo monetario, Centro studi Confindustria, Prometeia e Cer, mentre il Ref di Milano ha parlato di crescita zero tout court per il 2014.Tuttavia, stima l’Abi, la ripresa arriverà entro l’anno e nel biennio 2015-2016 il Pil dovrebbe aumentare dell’1,3-1,4%, a un ritmo decisamente migliore delle recenti esperienze.

Euro forte, la svalutazione da sola non basta
Redazione Edicola - Opinioni economia, euro, Giorgio Barba Navaretti, il sole 24 ore
Giorgio Barba Navaretti – Il Sole 24 Ore
L’impatto di un eventuale deprezzamento dell’euro sulla nostra economia sarebbe piuttosto ambiguo. Non migliorerebbe necessariamente il saldo di bilancia commerciale facendo aumentare la quantità dei beni esportati e riducendo quelli importati; né permetterebbe alle nostre imprese di aumentare i margini di profitto e accrescere gli investimenti. In tutti i paesi industrializzati storicamente le esportazioni reagiscono poco a un deprezzamento del tasso di cambio. La ragione è che una svalutazione pone le imprese di fronte alla scelta di aumentare le quantità vendute a parità di prezzo in valuta nazionale o di lasciare i prezzi in valuta estera e le quantità vendute invariate, aumentando i profitti in valuta nazionale per ogni unità venduta.
Il trasferimento della svalutazione in una riduzione dei prezzi in valuta estera è generalmente limitato. Il che significa che le imprese esportatrici hanno abbastanza potere di mercato per aumentare i margini di profitto. Sono imprese medio grandi che fanno leva su una competitività basata su brand, qualità e tecnologie e riescono a tradurre in maggior prezzi e margini di profitto i benefici di una svalutazione.
Il tasso di cambio dollaro/euro è cambiato molto poco tra l’inizio della crisi e oggi. Le imprese italiane sono da anni abituate a esportare con un euro forte e nonostante ciò sono riuscite ad accrescere le proprie vendite estere anche in volumi. È comunque un numero limitato di aziende medio-grandi che è riuscito a posizionare i propri beni in nicchie poco sensibili alle oscillazioni del cambio.Per quanto l’effetto sulle quantità della svalutazione non fosse rilevante ci sarebbe un effetto positivo sui margini di profitto. Ma l’impatto sarebbe concentrato solo sulle aziende che riescano a sfuggire alla competitività di prezzo e non diffuso a tutto il sistema. Inoltre, la ricaduta della svalutazione sui profitti dipenderebbe anche dalla valuta in cui le imprese acquistano materie prime e componenti. Una svalutazione farebbe aumentare la bolletta energetica per tutti. E la produzione di componenti e semilavorati è oramai molto frammentata tra aree valutarie diverse. I benefici derivanti dai prezzi di vendita potrebbero essere in parte o in tutto compensati da un aumento dei costi di produzione.
In sintesi, una svalutazione significa una perdita di potere di acquisto e un impoverimento relativo nei confronti delle altre aree valutarie. A questo costo certo possono corrispondono benefici incerti che non è semplice quantificare. Sperare dunque che la linfa vitale che manca alla nostra crescita economica possa derivare da una svalutazione dell’euro è fuorviante e ci allontana dai problemi veri del Paese.

Una moratoria legislativa per attrarre capitali esteri
Redazione Edicola - Opinioni economia, gianluca comin, il messaggero, investimenti
Gianluca Comin – Il Messaggero
L’Italia continua ad essere un Paese attrattivo per gli investimenti esteri. Circa un quinto del prodotto interno lordo viene, infatti, da acquisizioni e fondi internazionali ma ancora poco rispetto a Francia, Spagna e Germania. A tirare il freno a mano alle imprese e istituzioni finanziarie straniere sono quei vincoli che, da sempre, denunciamo e che con fatica il governo Renzi cerca di smantellare: una burocrazia barocca e lenta, una giustizia amministrativa imprevedibile ed una civile interminabile, una legislazione faraonica, l’incertezza dei tempi di autorizzazioni e permessi e una moltiplicazione infinita di poteri di approvazioni e di veto. Ma soprattutto una regolazione incerta e mutevole. Basterebbe infatti che ciascun dirigente pubblico, amministratore centrale o locale con responsabilità o politico in carica provasse, almeno una volta nella vita, a spiegare ad un top manager straniero la complessità del nostro sistema per capire il senso di frustrazione di chi intende avviare una impresa nel nostro Paese.
Non sono mancate in questi anni le analisi, i libri bianchi e le riforme. Tuttavia è ancora sorprendente quanto siamo in larga parte inconsapevoli di questo gap che ci distanzia dai principali competitor europei. L’ultimo rapporto è stato presentato qualche giorno fa dall’American Chamber of Commerce in Italy ed ha il titolo alquanto esplicativo di “Il rischio regolatorio in Italia”. Una analisi certo parziale ma significativa perché effettuata su un campione di medie e grandi imprese che operano in Italia in diversi settori industriali, commerciali e dei servizi. Il quadro che emerge non è che la conferma di quanto assistiamo da anni. La regolazione incide profondamente sulla redditività delle imprese. Più di un quarto delle aziende intervistate ritiene, infatti, che oltre la metà del proprio margine operativo, cioè la capacità di fare reddito della propria impresa, dipende dal quadro regolatorio. Per circa un terzo delle aziende questa quota è compresa tra il 20 ed il 50 per cento. La capacità di influenza delle decisioni legislative e regolatorie è addirittura aumentata nel corso degli ultimi anni ed in particolare dall’inizio della Grande Crisi che ha visto una maggiore attitudine dei governi ad intervenire in economia.
Che l’Italia sia un Paese iper-regolato non è nuovo. Un recente rapporto del World Economic Forum poneva l’Italia al 146° posto su 148 economie considerate (davanti solo a Brasile e Venezuela) per peso della regolazione. E sempre secondo Amcham sono le industrie chimiche e farmaceutiche, seguite da quelle dell’energia e dai servizi finanziari quelle che si ritengono operare in un ambiente «altamente regolamentato e con un rischio regolatorio ai diversi livelli amministrativi». Più della metà degli intervistati ritiene infatti che il peso burocratico derivi soprattutto dalle decisioni prese a livello regionale e locale. Gli esempi possono essere molti: leggi che cambiano, anche retroattivamente, le regole del gioco dopo la decisione di investimento (norme sul fotovoltaico, regolazione del farmaco, affitti pubblici, spending review), variazioni alla legislazione fiscale, norme su permessi ed autorizzazioni.
Per i manager stranieri la frustrazione è alta. Spiegare ai loro headquarter dall’altra parte del mondo la particolarità del sistema italiano è spesso impossibile e così il “rischio Paese” diventa la variabile principale nelle scelte di investimento, ancor più della legislazione sul lavoro o il deficit infrastrutturale. Una frustrazione che emerge dalle risposte alla ricerca dell’Amcham quando ben il 54% dei manager intervistati dichiara di «non essere mai riusciti a influenzare la produzione di politiche nel proprio settore di attività», il 16% solo raramente, il 29% qualche volta. Le aziende straniere, ma anche quelle italiane, riscontrano un problema di accesso al policy maker: 7 su 10 dichiarano che è difficile anche solo entrare in contatto con il governo/regolatore. Ma c’è anche un problema di comprensione da parte del decisore pubblico delle istanze poste dalle aziende. Problema di trasparenza del rapporto innanzitutto, come sottolinea ancora il Wef che pone l’Italia al 140° posto su 148 per «trasparenza del processo di produzione delle politiche e del quadro normativo».

Per non fare i conti
Redazione Edicola - Opinioni davide giacalone, economia, libero, Matteo Renzi, senato
Davide Giacalone – Libero
C’è il buon affare del Senato e il cattivo affare dei conti. Il governo spera di usare il primo per affrontare o scansare il secondo. La canoa italiana ha imboccato il ramo delle rapide, senza sapere se e quando ci sono le cascate. C’è chi s’inebria con un futuristico elogio della schiuma e della velocità, chi coglie l’occasione per sbracciarsi e mettersi in mostra, e chi, all’opposto, approfitta della distrazione per nascondere il vuoto d’idee. Tutto in un delirio tatticistico e politicista, senza che ci si curi di quel che viene dopo lo spumeggiare.
Il Senato è un buon affare. Per molti, se non per tutti. Matteo Renzi può far la parte del condottiero che non s’arresta. Gli oppositori più chiassosi possono far la parte dei combattenti senza paura. Finiscono sommersi quelli che vorrebbero correggere un testo mediocre e squilibrato, scompare la voce delle persone serie, a sinistra (con molto dolore) e a destra (con troppa sottomissione). Ma l’impressione è che poco importi, ai duellanti.
Se la campagna del Senato va a buon fine, il governo la utilizzerà per dire: abbiamo cominciato a cambiare l’Italia, adesso non rompeteci troppo l’anima sui conti. Se si dovesse impantanare in guerra di trincea, la utilizzerà per dire: c’impediscono di cambiare l’Italia, meglio tornare alle urne. Nel primo caso ci sarà il tempo per cambiare la legge elettorale, magari usando anche il dialogo con i pentastellati. Nel secondo si accetterà di votare (sempre che il Colle copra l’operazione con lo stesso partecipe trasposto con cui copre i ludi senatoriali) con un sistema meno certo nel risultato, puntando a gruppi parlamentari più direttamente e personalmente controllabili. In ambedue i casi l’obiettivo è quello di non far precedere il voto da un assestamento dei conti, che non gioverebbe alla credibilità e popolarità di Renzi. Questo il panorama tattico. Ma poi c’è la sostanza, coriacea assai.
Intanto perché il cambiamento del Senato non si tradurrà in una più veloce a corriva attività legislativa, se non passando prima per le urne. Ciò per l’inaggirabile motivo che anche in caso di cambiamento costituzionale non è che il Senato sparisca all’istante, ma occorre che sia sciolto quello presente. Poi perché ignorare l’aggiustamento dei conti ci porterà ad avere un debito ancora più alto, quindi a veder crescere la massa tumorale che ci soffoca. La tanto reclamata e declamata elasticità non giova minimamente né all’economia reale né al tenore di vita dei cittadini, aiuta i governi a non prendere atto dei propri insuccessi. Vale per tutti, non solo per l’Italia. Noi, però, siamo i più esposti, proprio perché intestatari del debito più potenzialmente esplosivo.
Varrà la pena di tornare, su questo punto. Che è decisivo, perché deve essere cancellata l’illusione che sia il rigore ad avere provocato la recessione, semmai sono il debito e la spesa pubblica improduttiva ad avere prodotto prima il rallentamento della crescita e poi il precipitare nella decrescita, per, infine, approdare alla stagnazione. Pensare di curare il male con lo stesso male non è una specie di omeopatia politica, è un errore pericolosissimo. Serve a far credere all’opinione pubblica che ci danneggiano i vincoli esterni, non le dilapidazioni interne. Si può anche riuscire in un simile gioco di prestigio, aiutati dagli schiamazzi del loggione qualunquista, ma il teatro crolla prima della fine dello spettacolo.
Sobbalziamo fra i flutti e ci divertiamo fra i gorghi, convinti che non possono lasciarci precipitare senza per questo rompere il convoglio europeo. Attendiamo che ci tirino una cima e ci fermino, facendo finta di non sapere che già in tal senso si è spesa la Banca centrale europea. Ma a nessuno viene in mente di raccontare la verità, nessuno se ne prende l’onere, perché nessuno ha credibilità sufficiente o voglia di rallentare la (presunta) corsa verso il successo. Si crede che la partita rilevante sia quella interna alla canoa. Magari si potrà gridare “vittoria” quando sotto non ci sarà più il fiume, ma il vuoto. Non c’è nulla d’ineluttabile, in questo. Non è una sorte segnata, perché avremmo ancora le forze per invertire la rotta. Solo che chi è in grado di remare tende a sbarcare, chi avverte viene deriso, e l’unico spettacolo che va in onda è quello della campagna senatoriale. In queste condizioni il meglio che possa accadere (per chi governa) è che con i problemi veri si facciano i conti dopo e non prima delle elezioni. Cambia, molto, per chi vuol comandare. Non cambia nulla, per tutti gli altri, se non per il tempo perso.
