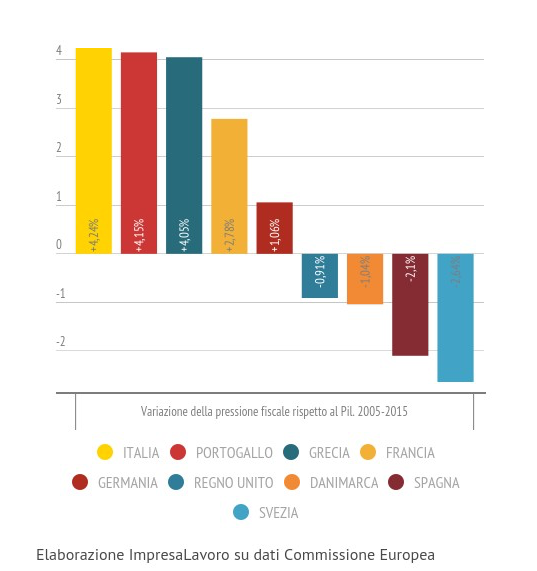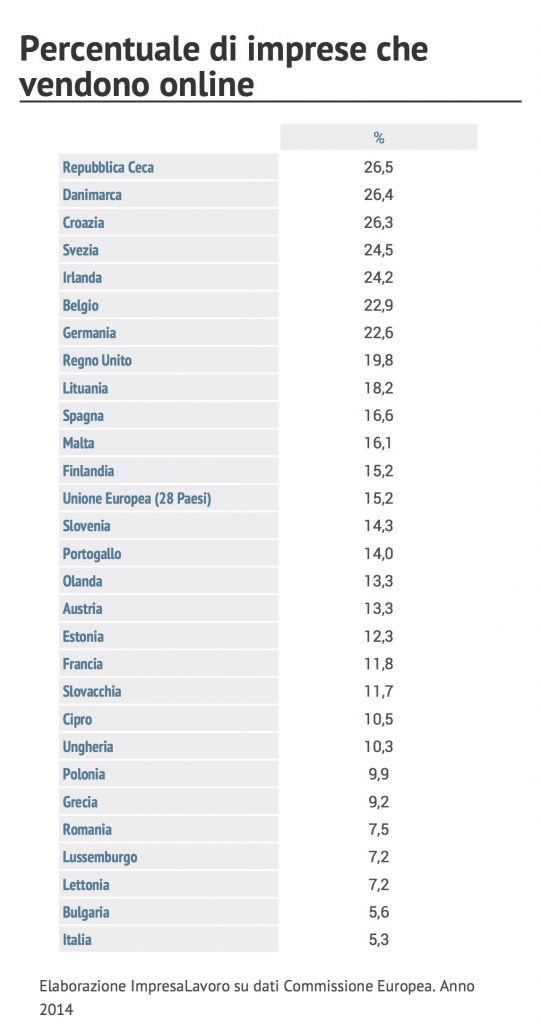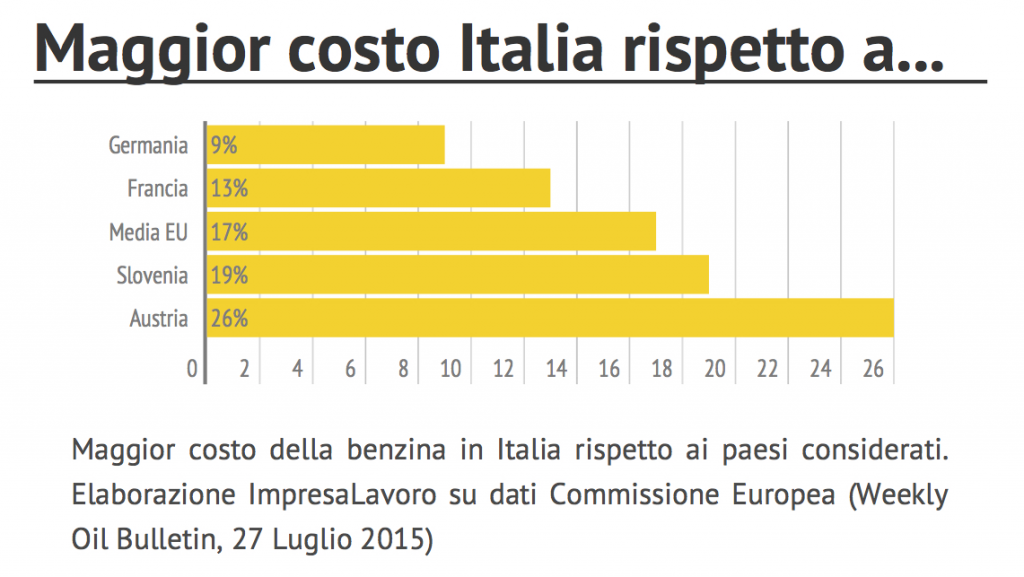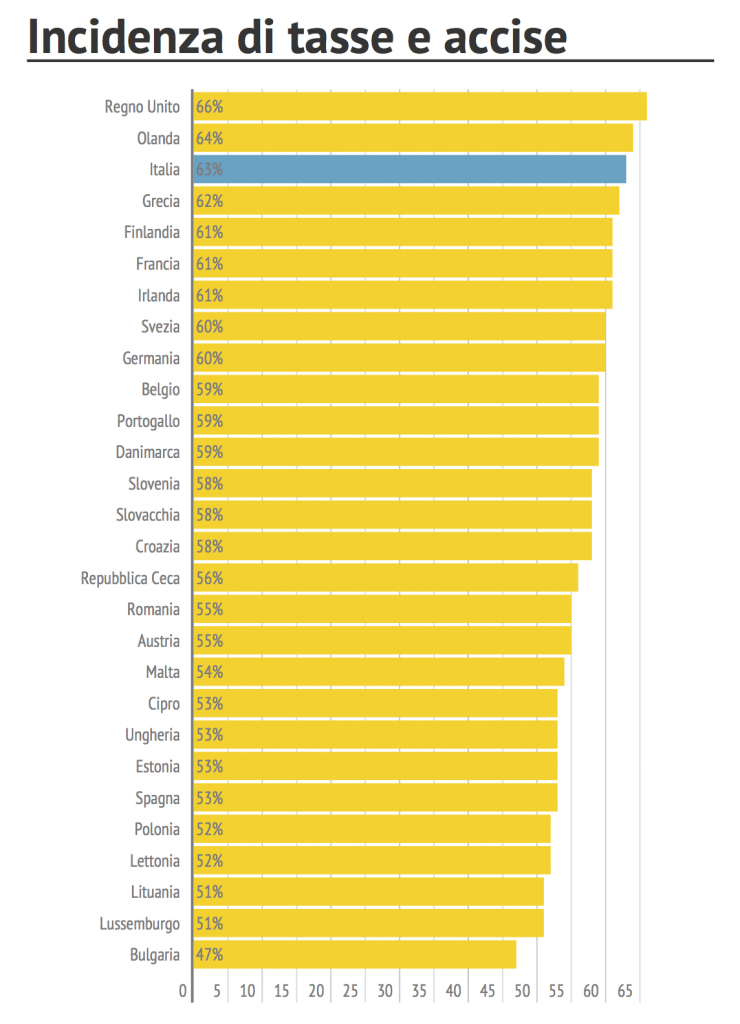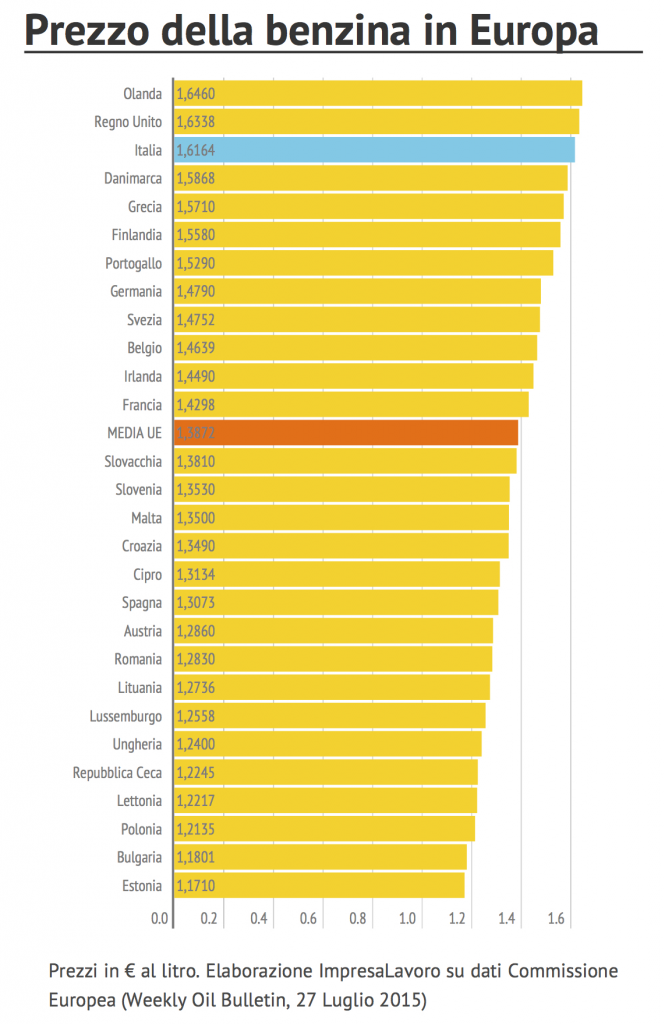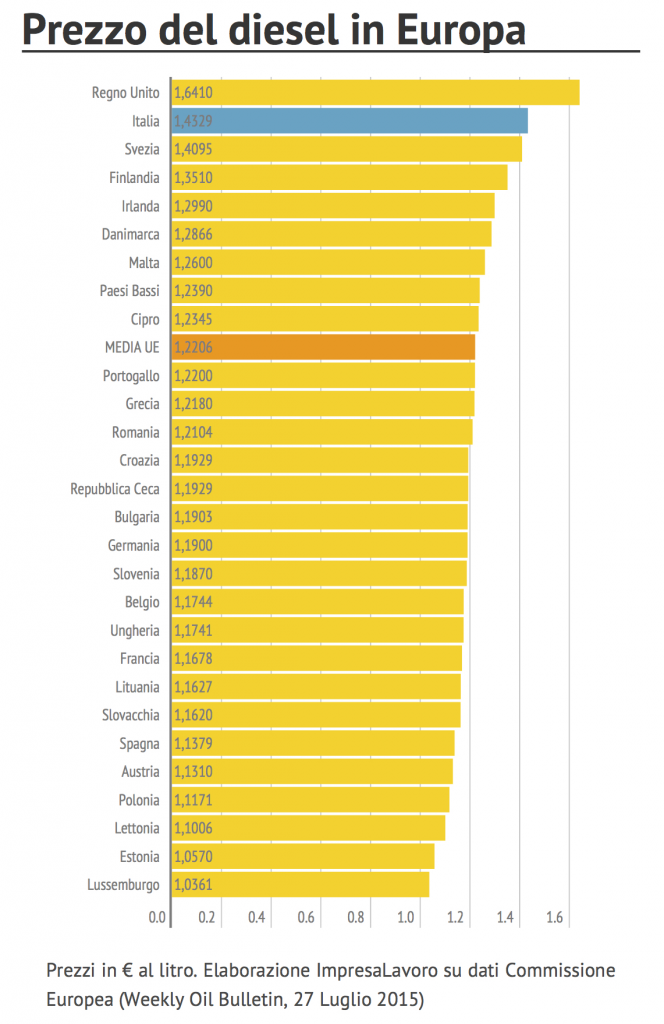Con l’Ue è più dare che avere: 72 miliardi per contare zero
Il Giornale del 22 gennaio 2016
Chiedete a un tedesco mediamente informato (compresi alcuni giornalisti che lavorano nello Stivale) quale è il rapporto tra l’Italia e l’Europa. La risposta in molti casi sarà: prende soldi. Pregiudizio duro a morire. Quando Der Spiegel – autorevole settimanale di target medio alto – provò a dimostrare il contrario, forte dei dati della direzione bilancio della commissione Ue, sul web comparvero commenti poco lusinghieri per l’Italia. Il Centro studi ImpresaLavoro ieri ha messo in fila quattordici anni di rapporti finanziari tra l’ltalia e Bruxelles. Dove nel dare ci stanno i finanziamenti diretti dello Stato all’Ue e la quota di imposte girate alla contabilità europea; nell’avere i contributi arrivati nella penisola attraverso i vari programmi europei. Il risultato è una serie ininterrotta di segni meno, cioè un saldo negativo per l’Italia e positivo per le istituzioni europee. Come se non bastasse lo sbilancio a favore dell’Europa è cresciuto ininterrottamente con il tempo, anche negli anni più difficili per le casse pubbliche italiane.
Dal 2000 al 2014 la somma di tutte le posizioni nette è di 72 miliardi. Ne abbiamo versati 213 e incassati 141. Contributori netti, senza nessun dubbio. Siamo a pieno titolo nel club dei Paesi che pagano un biglietto di prima classe per l’Ue. Anzi, in rapporto al Pil, siamo quelli che fanno maggiori sacrifici. Colpisce la progressione del saldo tra entrate e uscite. Una «tendenza preoccupante», per il Centro studi fondato da Massimo Blasoni. «Se infatti il 2000 si era chiuso con una differenza di poco superiore al miliardo di euro», questa forbice «si è andata progressivamente espandendo, fino a raggiungere i 4,2 miliardi del 2005 e i 7,3 miliardi del 2013 (17,1 in uscita e 9,8 in entrata)». Di 213 miliardi italiani finiti nel budget europeo, quasi 45 vengono dalla quota di Iva che va alle istituzioni Ue. Le risorse proprie dell’Unione, quelle provenienti da dazi, sono appena 22 miliardi, circa 1,4 all’anno. Tutto il resto è contabilizzato sotto la voce «reddito nazionale lordo». Cioè è la somma variabile che viene assegnata a ciascuno Stato membro. Sul fronte delle entrate, ben 74 miliardi sono riferibili al Fondo europeo agricolo di garanzia. Segue il Fondo europeo di sviluppo regionale con 35,7 miliardi, poi il Fondo sociale europeo con 15,4 miliardi.
La progressione dei versamenti è costantemente in crescita. Con la sola eccezione del 2006, 2007 e 2010 quando calarono. Le entrate hanno invece un andamento molto irregolare. La conferma che il problema è anche nazionale, cioè la scarsa capacità di spendere risorse europee. L’Italia è un contributore sempre più importante per l’Europa. Ma «a questo dato di fatto – commenta Blasoni – non corrisponde un ruolo altrettanto importante nelle dinamiche politiche europee. Ogni Paese, infatti, tende ancora a difendere i propri interessi nazionali senza alcuna solidarietà: dalle banche agli immigrati, senza dimenticarci i vincoli di bilancio, sono ancora molti i fronti aperti con Bruxelles. Questo però non può diventare un alibi: il nostro è un Paese ancora lontano dalla ripresa economica, con una pressione fiscale non più sostenibile e il fardello del debito pubblico che continua a crescere». La questione delle risorse resta centrale per l’Europa. La recente crisi italo-europea è stata causata principalmente dai contributi per la Turchia, che l’Italia vuole contabilizzare nel bilancio Ue.
Leggi l’articolo sul sito de “Il Giornale”