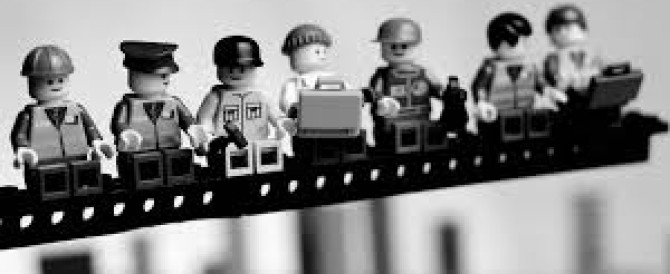Una riforma del lavoro per ripartire. Riduzione dei costi, non del salario
Michele Salvati e Marco Leonardi – Corriere della Sera
Conosceremo presto la formulazione definitiva che il governo intende dare al suo progetto di riforma della legislazione del lavoro, quel Jobs Act che ha nella sua pancia il tormentone dell’articolo 18: i giornali danno per scontata l’ipotesi di un decreto, ma staremo a vedere. Il nostro articolo precedente (Corriere, 7 settembre) poteva aver lasciato l’impressione che l’attivismo riformistico del governo fosse soprattutto indirizzato a ottenere dalla Germania un allentamento delle condizioni di austerità cui siamo sottoposti: come rifiutarsi di allentarle se facciamo i nostri compiti a casa e attuiamo una riforma così importante secondo un modello uguale o molto simile a quello tedesco?
Vorremmo rettificare questa impressione, se c’è stata: il modello tedesco è opportuno nella sostanza e presentarlo presto in Europa sicuramente rafforza la nostra posizione contrattuale, ma dubitiamo che questa o altre riforme convincano i tedeschi a modificare in tempi brevi il loro atteggiamento. I difetti del sistema della moneta unica sono così profondi, e i vantaggi immediati che esso offre alla Germania sono così importanti, che è improbabile che essa voglia mutare le sue politiche interne e il suo atteggiamento nei confronti degli attuali assetti europei, quali che siano le «riforme strutturali» alle quali i Paesi deboli si sottomettono. Se è così, ristagno e dualismo sono destinati a permanere per un lungo periodo.
Ma allora perché il modello tedesco? O addirittura, perché una revisione profonda della legislazione del lavoro? Risposta: perché comunque ci conviene. Perché in ogni caso, sia che l’austerità europea si attenui sia che persista, e persino in presenza di forti turbolenze degli assetti istituzionali dell’Unione, avere un mercato del lavoro che funziona bene è meglio di averne uno che funziona male. In un contesto globalizzato, in cui tutti i Paesi avanzati sono comunque soggetti a forti pressioni competitive, tra i loro sistemi di legislazione del lavoro quello tedesco è un buon compromesso tra flessibilità e garanzie, tipico di un Paese dell’Europa continentale con un welfare sviluppato e con sindacati forti: difficilmente sistemi anglosassoni sarebbero applicabili da noi.
È un sistema che mantiene un filtro giudiziario al licenziamento, che però non interferisce con le motivazioni economiche addotte dall’imprenditore e solo opera, e può condurre al reintegro in casi estremi, se il lavoratore e i sindacati dimostrano che le motivazioni economiche sono un pretesto che nasconde motivazioni incostituzionali. È un sistema dove esiste una indennità automatica: all’atto del licenziamento l’impresa è tenuta a offrire una indennità di un mese di salario per ogni anno di lavoro e, se il lavoratore 1’accetta, perde il diritto di rivolgersi al giudice. Ed è un sistema dove i centri per l’impiego funzionano decentemente e dove all’indennità di disoccupazione – con durata e modalità non molto diverse dalla nostra Aspi – fanno seguito misure assistenziali, molto modeste, ma di durata indefinita. Tutto si tiene nel mercato del lavoro e una riforma del solo articolo 18 serve poco se non è accompagnata da una revisione di altre parti della legislazione del lavoro e del welfare.
Pochi i punti fermi. Il primo è che l’Italia ha un tasso di occupazione, in particolare quello femminile, troppo basso per permettersi un welfare generoso: il numero degli occupati è all’incirca uguale a quello degli inattivi o disoccupati e poi gli occupati hanno i pensionati sulle loro spalle. Il primo obiettivo è dunque quello di aumentare l’occupazione, con ogni mezzo. Il secondo punto fermo è che l’Italia ha un numero abnorme di occupati in lavori autonomi, il 23%, contro un 13% di Francia e Germania: il secondo obiettivo è dunque eliminare gli impedimenti che ostacolano il ricorso al lavoro dipendente. Oggi il problema non sono gli ostacoli contro i contratti a termine, dove siamo più o meno in linea con gli altri grandi Paesi europei, ed è la Spagna il caso abnorme. Da noi il grande problema è quello delle partite Iva fasulle. Sono loro la fonte dei veri precari del XXI secolo, senza diritti né minimi salariali, privi della possibilità di accumulare contributi pensionistici e spesso costretti all’evasione: è una piaga che dev’essere eliminata.
Il terzo punto fermo è che l’occupazione si favorisce più con le politiche salariali che con l’abolizione dell’articolo 18, pur necessaria. Quando arrivò la crisi del 2007-2009 la Germania si ritrovò con un sistema di relazioni industriali in cui la metà delle imprese e dei lavoratori contrattavano i loro salari al di fuori dei contratti nazionali di categoria e con un sistema di ammortizzatori sociali chiaro e ben funzionante. La combinazione di orari e salari flessibili, di un forte legame tra salari e produttività, ha fatto uscire dalla crisi il Paese meglio di come vi era entrato. Dunque, sarebbe opportuno che nella riforma fosse compresa anche la materia contrattuale.
Un’osservazione finale e di natura politica. In via generale i lavoratori non hanno «colpa» del fatto che il loro lavoro è poco produttivo e che l’occupazione scarseggia. Le colpe sono diffuse su altri soggetti: su imprese incapaci di innovare e organizzarsi in modo efficace, su un sistema fiscale che tassa troppo e male il lavoro e l’impresa, su uno Stato e su una pubblica amministrazione inefficienti e bizantini. Che le conseguenze di queste inefficienze altrui ricadano sul lavoro genera reazioni e resistenze, ed è comprensibile che così avvenga. Ma i costi salariali sono la trazione più importante del valore aggiunto e su di essi occorre incidere se si vogliono restaurare rapidamente condizioni di maggiore competitività. Una penosa bisogna, di cui il governo può essere perdonato solo se attacca con eguale determinazione gli altri segmenti del Sistema-Paese dai quali la nostra scarsa capacità di crescita dipende.