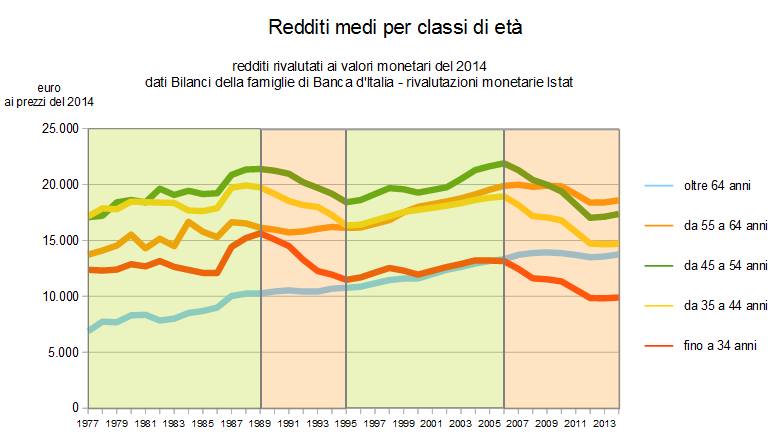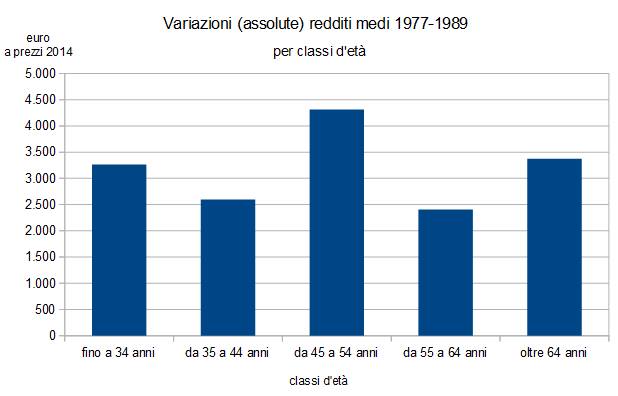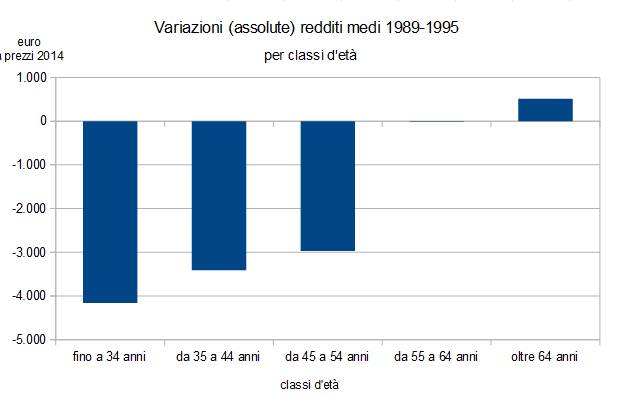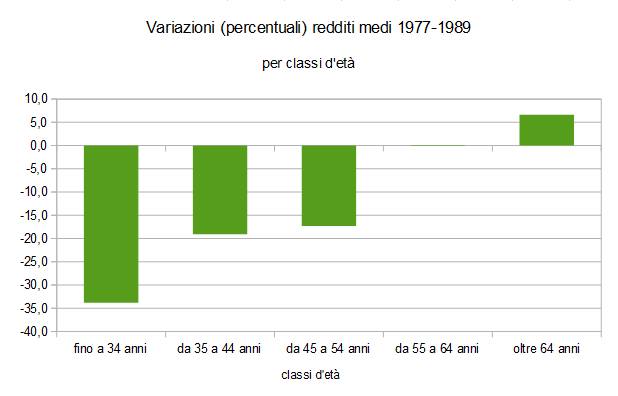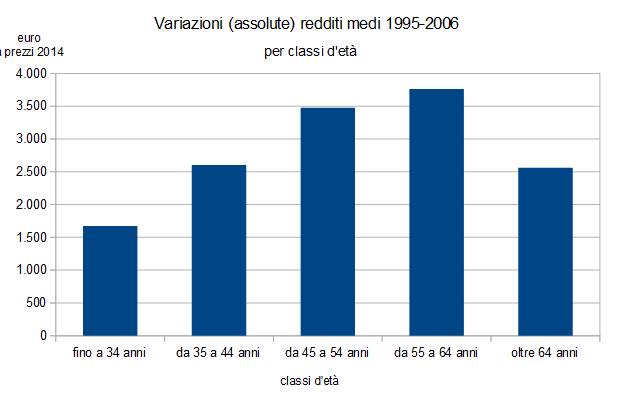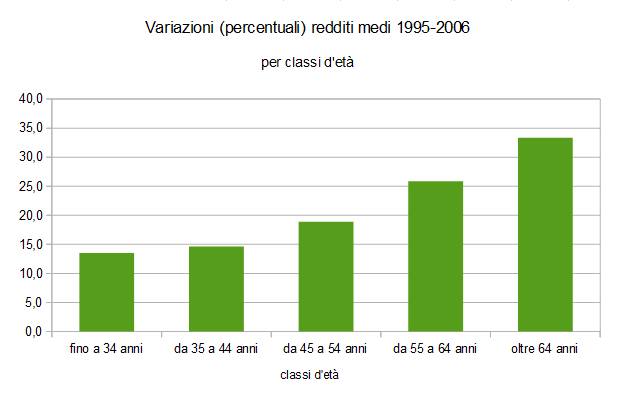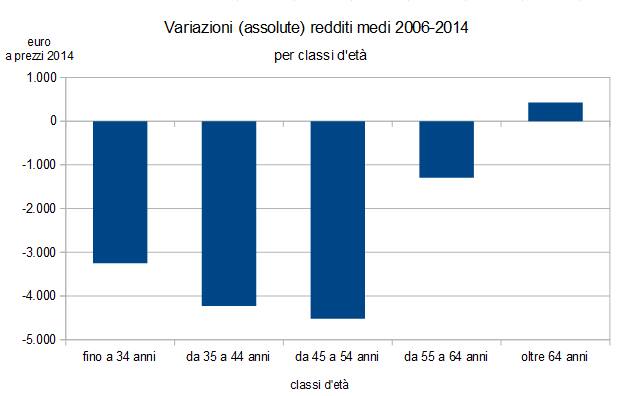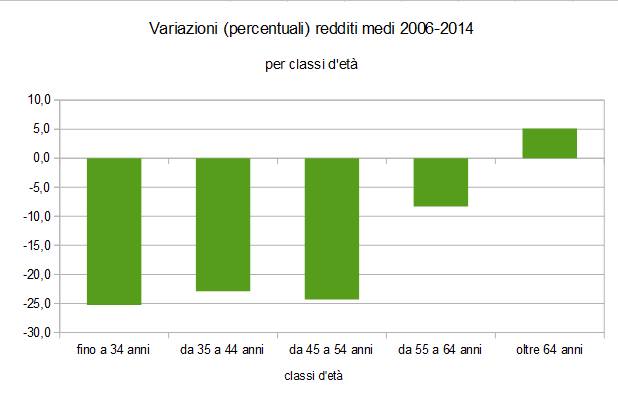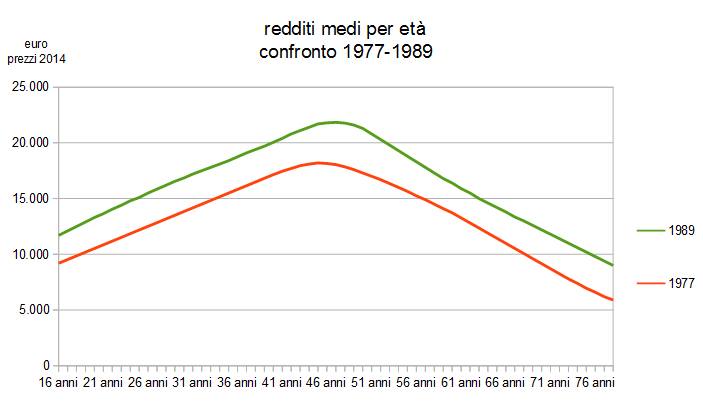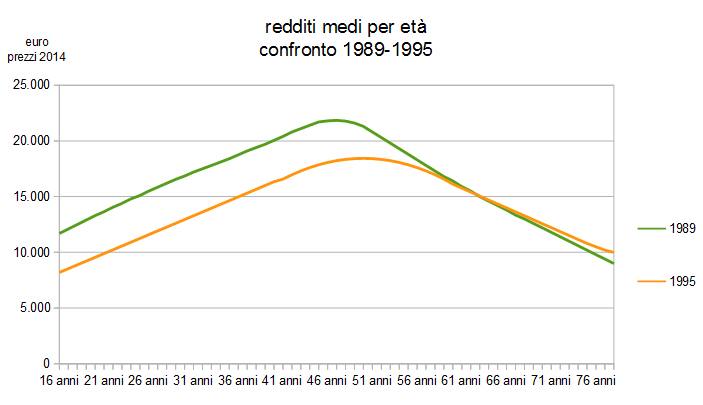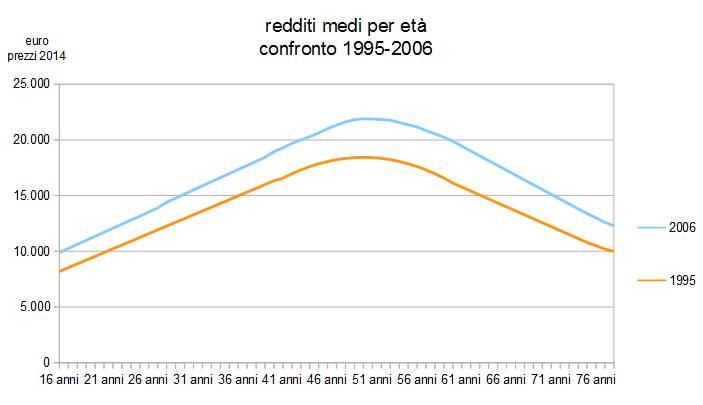Massimo Blasoni a Bianco&Nero (Rai Radio1)
Massimo Blasoni, Presidente del Centro studi ImpresaLavoro, è intervenuto alla trasmissione “Bianco&Nero”, condotta da Giancarlo Loquenzi su Rai Radio1. Ospite, insieme a lui, Luigi Marattin (consigliere economico di Matteo Renzi). Clicca qui per ascoltare la trasmissione.