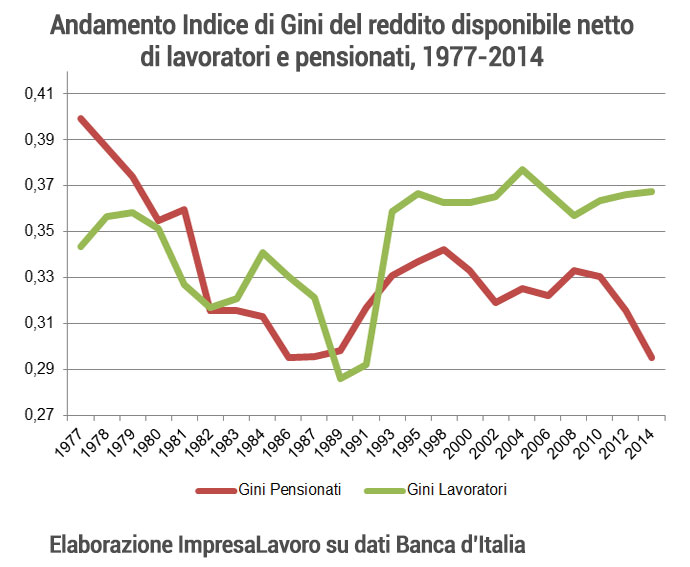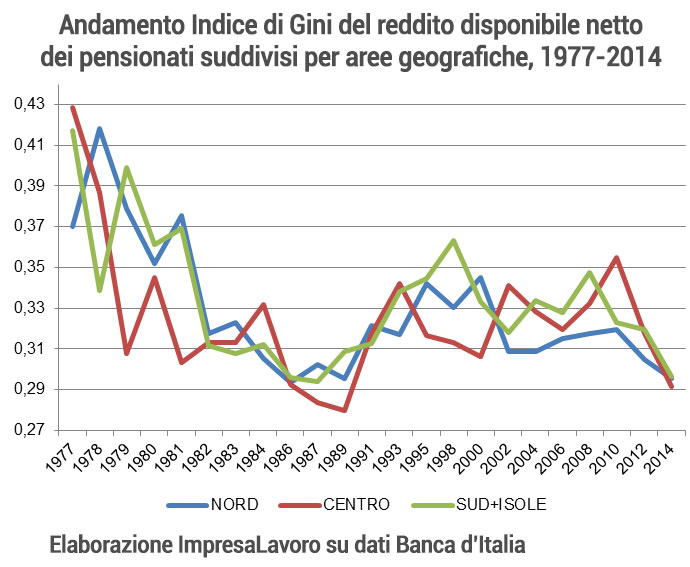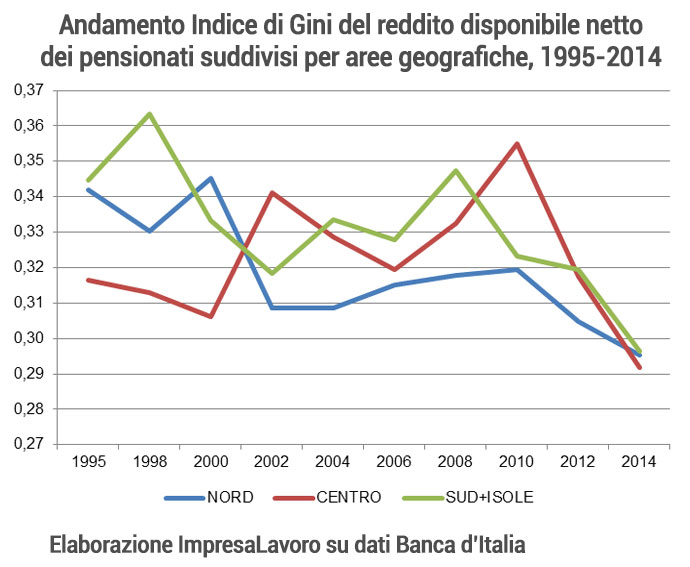Guerra di sigle e di generazioni
di Giuseppe Pennisi*
Una nuova sigla entrata da qualche giorno nella galassia degli acronimi giornalistici e nel dibattito di politica previdenziale (e, quindi, di finanza pubblica): APE, ossia Anticipo Pensione. Pochi si sono accorti che nella galassia esiste già un APE, Attestato di Prestazione Energetica, come sanno tutti coloro che vogliono vendere od acquistare un immobile. Prima o poi, la “guerra” delle APE troverà una soluzione, anche in quanto la flessibilità in uscita, con pensionamento anticipato, pare ancora lontana, quanto meno per coloro che non hanno fatto lavori “usuranti” per diversi anni o che non hanno cominciato a lavorare quando erano molto giovani (nel gergo INPS “i precoci”).
Ma è, poi, realmente in atto una guerra tra vecchi e giovani, ammesso che ci sia piena sostituibilità tra lavoratori più o meno anziani sul posto di lavoro? Non sembra che ci sia. Una quindicina di anni fa, su istanza di associazioni di senior citizen, la Corte Suprema americana ha sentenziato che stabilire un’età legale di pensionamento (allora in numerose aziende USA era a 67 anni) è un’incostituzionale discriminazione contro gli anziani; da allora frotte di americani restano al lavoro quanto vogliono e quanto possono.
Non sono i soli. In questa rubrica abbiamo già ricordato come analisi internazionali dimostrino che andare troppo presto in pensione causa disturbi mentali che spesso accorciano la vita. Un team di economisti delle Università di Londra e di Amburgo (Gabriel H. Ahfelt, Wolfang Maenning, e Malte Steenbeck) ha appena pubblicato un lavoro (Après Nous Le Déluge? Direct Democracy and Intergenerational Conflict in Aeging Societies CESiffo Working Paper Series No. 5779) in cui con un’analisi quantitative in base a procedure quali quelle promosse nel volume del Centro Studi Impresa Lavoro La Buona Spesa – Dalle Opere Pubbliche alla Spending Review – Una Guida Operativa analizza un caso specifico: il maggior progetto infrastrutturale di oggi, i cui costi gravano su questa generazione di tedeschi a benefico delle future. La conclusione è che i conflitti intergenerazionali derivanti dall’invecchiamento della popolazione sono limitati ad un limitato numero di casi in cui il valore attuale netto varia molto significativamente tra classi di età. La proposta è quella di utilizzare in questi casi non lo strumento referendario ma l’analisi costi-benefici economica.
Tornando alle pensioni, di grande interesse di lavoro di Riccardo Calcagno, Flavia Coda Moscarola, Elsa Fornero pubblicato il 27 aprile come Cerp Working Paper 161/16. Eloquente il titolo “Too busy to stay at work. How willing are Italian workers “to pay” to anticipate their retirement?” (‘Troppo occupati per restare al lavoro: quanti italiani sono disposti a ‘pagare’ per anticipare la loro pensione?’). È un’analisi statistica su un campione di lavoratori italiani di almeno 55 anni e la loro ‘disponibilità a pagare’ per anticipare di un anno il pensionamento. La preferenza per una pensione anticipata (ovviamente ridotta) è marcata per le donne e per i lavoratori immediatamente colpiti dalla riforma del 2011 (quali i così detti ‘esodati’). Le donne che curano figli e nipoti, o genitori anziani, sono pronte a pagare anche un prezzo elevato per andare prima in pensione. Ciò indica che il sistema previdenziale può causare “effetti collaterali” se non accompagnato da altre misure di politica sociale, quali quelle per la cura dei congiunti.
*Presidente del board scientifico di ImpresaLavoro