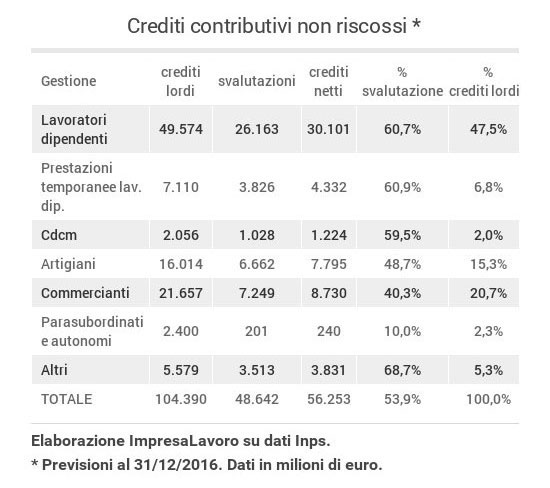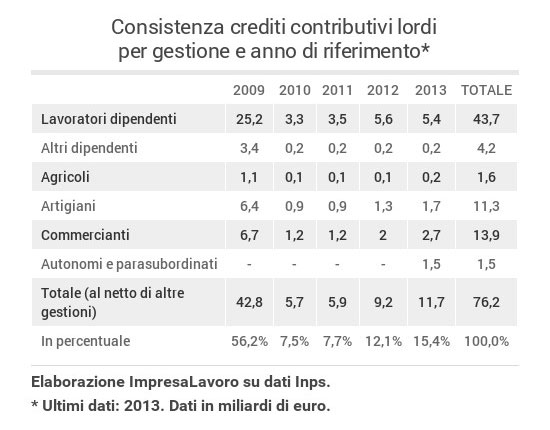Marin: “Al Senato una mozione a tutela di tutti i pensionati”
di Marco Marin*
L’Inps ha evidenziato le condizioni drammatiche in cui vivono i pensionati italiani: 11,5 milioni di loro percepiscono infatti pensioni inferiori a 750 euro al mese. Una cifra, questa, ben al di sotto del livello minimo di sopravvivenza che un Paese civile dovrebbe garantire a chi ha lavorato una vita. Proprio per questo ho provveduto a depositare una mozione al Senato, a mia prima firma, insieme ai senatori del gruppo di Forza Italia, per tutelare i pensionati. Ricordando bene come il governo Renzi non lo abbia invece fatto quando si è trattato di dare la giusta rivalutazione alle loro pensioni. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Marco Marin. La nostra mozione vuole impegnare infatti il Governo a dare piena attuazione alla sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale, prevedendo il rimborso completo di tutti i pensionati. Chiediamo inoltre che le modifiche annunciate per favorire la flessibilità in uscita avvengano senza penalizzare i lavoratori con riduzioni del trattamento pensionistico e l’aumento delle pensioni per i soggetti disagiati. Infine, riteniamo doveroso ridurre il livello di tassazione sulle pensioni, che è tra le più alte d’Europa. A differenza del premier abusivo, noi pensiamo alle cose concrete nell’interesse degli Italiani.
*Senatore di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Istruzione pubblica e Beni culturali