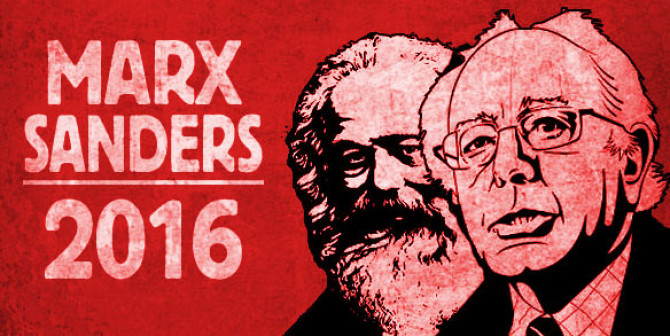Svizzera: prima in Europa perché meno tassata
Carlo Lottieri – Corriere del Ticino
Da sempre il destino delle comunità è legato a quello dell’imposizione fiscale. Come mostrò alcuni anni fa Charles Adams in un formidabile saggio dal titolo “For Good and Evil. L’influsso della tassazione nella storia dell’umanità” (la versione italiana è stata pubblicata da Liberilibri), esperienze che erano state di grandi successo per secoli e secoli sono crollate, nel passato, proprio a seguito di imposizioni tributarie eccessive. Oltre a ciò, hanno spesso avuto una matrice fiscale anche le rivoluzioni moderne: in Inghilterra come in America, come in Francia.
Sotto tanti punti di vista è difficile capire qualcosa della stessa crisi che l’Europa sta conoscendo se non si considera che mai come oggi gli apparati pubblici del Vecchio Continente hanno colpito in maniera tanto massiccia i redditi di lavoratori, imprese e famiglie. Ed è quindi motivo di soddisfazione rilevare, secondo quanto afferma una recente ricerca del centro studi Impresa Lavoro di Udine, che entro il quadro europeo la Svizzera si trova al primo posto in quanto a “libertà fiscale”.
L’indice considera i ventotto Paesi dell’Unione più la Svizzera e prende in esame cinque aspetti: il numero delle procedure necessarie a pagare le imposte; il tempo da destinare a ciò; il tax rate sulle imprese; il miglioramento del livello tributario complessivo nel periodo 2000-2014; e soprattutto (ed è questo il dato che pesa di più, ovviamente) la percentuale complessiva dei tributi in rapporto all’economia. Soprattutto grazie a quest’ultimo dato, la Svizzera si rileva meno oppressiva di ogni altro Paese, superando – anche se non di molto – l’Irlanda.
Va aggiunto che la Svizzera primeggia in questa classifica nonostante due voci che la penalizzano: il numero delle procedure (relativamente alto, com’è inevitabile in un Paese a struttura federale) e il cambiamento rispetto al 2000. In un quindicennio la Svezia ha ridotto del 5,9% la pressione fiscale, ma in Svizzera questo exploit non è stato possibile, considerando l’alta tassazione da cui si partiva.
Tutto bene? Non proprio. Il quadro generale – come si è detto – è quello di un’Europa schiacciata da debiti e alta tassazione al tempo stesso: e in questo quadro è difficile pensare che la piccola Svizzera non paghi conseguenze negative. Quando i tuoi clienti, i tuoi fornitori, i tuoi partner, i tuoi risparmiatori ecc. conoscono difficoltà, anche tu difficilmente avrai prospettive esaltanti.
In questo contesto è importante essere ancora più virtuosi ed evitare la tendenza, che pure è fortissima, a considerarsi tanto bravi solo perché si fa meglio di altri. Essere i primi in una classe di somari non significa necessariamente essere ottimi studenti. Fuor di metafora, è cruciale che si risvegli lo spirito di resistenza che lungo i secoli ha portato le popolazioni elvetiche a resistere di fronte alle pretese di quanto inventano nuove imposte e moltiplicano i tributi. Se si vogliono finanziare spese e progetti, è sempre bene esplorare la strada di tagli di bilancio: riducendo le uscite invece che aumentando le entrate.
Si tratta di avere una visione complessiva in grado di assicurare un futuro di prosperità: evitando ogni “normalizzazione” e scongiurando il rischio di una Svizzera sempre più simile alla Francia o alla Germania. Ma oltre a ciò, quando si assume come proprio principio ispiratore una sana diffidenza di fronte a ogni imposta, si sceglie di essere fedeli all’istituto cardine di ogni società civile: la proprietà.
Rispettare quanto più è possibile la proprietà significa, in poche parole, rispettare l’altro: il suo lavoro, il suo risparmio, quello dei suoi genitori. In questo come in altri casi (si pensi ai contratti), la difesa di solidi principi di giustizia comporta rilevanti conseguenze economiche. Una società che cerca di essere giusta e quindi non consegna una quota crescente delle ricchezze nelle mani dell’apparato politico e burocratico, alla fine è anche una società di successo.
Almeno in parte, questo è quanto la Svizzera ha saputo fare nel corso dei secoli: ha contenuto tassazione e regolazione, ha protetto la proprietà, ha tutelato i contratti, ha limitato (anche grazie alla concorrenza istituzionale e quindi al federalismo) il potere dei governanti, e tutto questo l’ha premiata.
È bene allora che non venga meno questa vigilanza di fronte alle buone ragioni del diritto, che si esprime anche in una resistenza di fronte a imposte eccessive e ingiustificate. E non solo per mantenere quel primo posto in classifica che pure tanti benefici assicura (basti pensare alla limitata disoccupazione) alla popolazione svizzera.