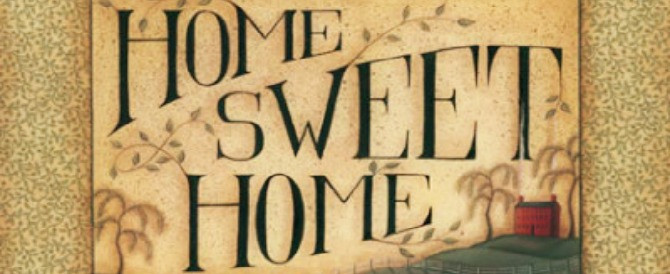La trincea delle lobby
Luigi Guiso – La Repubblica
Con il progetto di riforma delle banche popolari approvato ieri dal Consiglio dei ministri (dieci di esse, le più grandi, dovranno diventare Spa entro un anno e mezzo) Renzi replica il modello di attacco frontale usato per l’articolo 18, questa volta contro una delle più forti e trasversali lobby finanziarie italiane. L’iniziativa, se andrà a buon fine, può avere conseguenze rilevanti per la governance di una parte importante delle banche, migliorare il governo societario e accrescere il grado di concorrenza nel mercato del credito. Un aiuto ai correntisti, al risparmio e alla crescita. La parte centrale della riforma si riduce all’abolizione del voto capitario. Ovvero, della regola vigente per questa tipologia di banche per la quale il diritto di voto degli azionisti (soci) è indipendente dal numero di azioni (quote) detenute. Ogni socio ha diritto a un voto in assemblea, anche se possiede la metà del capitale.
Quale è il problema di un simile assetto di governo? Principalmente la difficoltà del passaggio di mano del controllo. In una società per azioni è sufficiente comprare i titoli sul mercato per scalzare un gruppo di controllo. Chi è disposto a pagare in proprio per comprare azioni che gli consentano di assumere il controllo ha un fondato motivo per ritenere di poter gestire la società meglio di quanto non faccia il management in carica. Il voto per azione garantisce che questo passaggio possa avvenire, quindi che si possa conseguire un vantaggio di efficienza. I potenziali guadagni possono essere notevoli ma saranno altrettanto grandi le perdite se il meccanismo di riallocazione del controllo funziona male.
Nelle banche popolari (e in genere nelle società cooperative) il cambio di controllo richiede che qualcuno metta d’accordo la metà più uno dei soci per scalzare la gestione corrente, se questa non funziona. È semplice capire i limiti del meccanismo. Se un socio è insoddisfatto della gestione, per estromettere il gruppo dirigente deve prima riuscire a convincere la maggioranza dei soci e portarne in assemblea un numero sufficiente. È ragionevole pensare che questa capacità di mobilizzazione e di coordinamento esista se si tratta di piccole cooperative, dove bastano poche telefonate per spiegare le cose e convincere altri soci a partecipare a una azione collettiva contro la dirigenza in carica. Ma per cooperative con migliaia e migliaia di soci, come accade ad esempio nelle grosse banche popolari (la Popolare dell’Emilia ne ha 90mila), chi mai tra i singoli soci sarà disposto a spendere il proprio tempo (e i propri soldi) per radunare altri soci nella speranza di raggiungere una maggioranza che consenta di estromettere il management in carica? Il beneficio, in termini di maggior efficienza della banca, va a tutti i soci, mentre il costo di gestione del dissenso pesa solo sul coordinatore. Inoltre, la capacità di mobilizzazione del gruppo che esercita il controllo è molto maggiore di quella di qualunque socio, rendendo arduo qualsiasi piano per estromettere il vertice. Da questo punto di vista le vicende della Popolare di Milano sono emblematiche.
Di fatto, nelle banche popolari la struttura cooperativa – e il voto capitario che la caratterizza – è servita ai gruppi di controllo di alcune per perseguire le loro ambizioni di costruzione di piccoli imperi, rimanendo al riparo dalla possibilità di un take over, come ad esempio nel caso del gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna. L’abolizione da parte del governo del voto capitario è un passo da giudicare con estremo favore. Non si tratta di un attacco allo spirito mutualistico del movimento cooperativo, come i rappresentanti di queste banche si sono già affrettati a sostenere. Non lo è perché le grandi banche popolari di “mutualistico” hanno ben poco, mentre le piccole – che di cooperativo hanno ancora parecchio (soprattutto le Bcc) – conserveranno le loro caratteristiche. Di più: il provvedimento è una presa d’atto tardiva, perché nessun governo prima d’ora aveva osato opporsi al potere di influenza delle popolari più grandi.
Se il governo riuscirà a portare a termine la riforma saremo di fronte a una svolta molto importante. Ma il fuoco di sbarramento della lobby è già cominciato e i cannoni spareranno dalle trincee di tutti gli schieramenti politici. A destra come a sinistra. La battaglia in Parlamento si annuncia durissima. Prepariamoci a vedere schierata tutta la potenza di interdizione di cui sono capaci le banche popolari, a riprova che di ‘cooperativo’ hanno poco, ma di politico moltissimo.