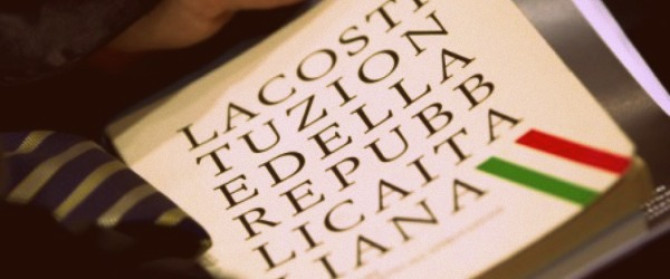Una burocrazia troppo lenta e inefficace. Così il «grimaldello» europeo rischia di lasciare il nostro Paese a bocca asciutta
Giuseppe Pennisi – Avvenire
I documenti ufficiali sul “Piano Juncker” – essenzialmente i quelli all’esame del parlamento europeo – affermano che il programma, ancora in costruzione, è un grimaldello: attivare con una leva di 21 miliardi di “garanzie” (non di finanziamenti diretti) di Commissione europea (Ce) e Banca europea per gli investimenti (Bei) un totale di 315 miliardi di euro. Come tutti i grimaldelli, ha virtù o opportunità – apre le 28 scatole dei piani d’investimento degli Stati Ue – ma anche vizi o rischi: mostra quali scatole sono piene e quali vuote e quali potrebbero essere piene se i vincoli del Fiscal Compact non mettessero a repentaglio fondi di contropartita, a valere sui conti dei singoli Stati per arrivare la finanza privata.
Per l’Italia, da un lato, il “grimaldello” minaccia di mostrare che quasi nessuna amministrazione ha ottemperato ai decreti legislativi 102 e 228 del 2011 di adeguamento alla normativa europea, con i quali si richiedeva una programmazione pluriennale per progetti esecutivi corredati da analisi economica e finanziaria. Di conseguenza, in una gara in cui i progetti non sono allocati per Paese ma scelti da un comitato di investimenti in base alla loro qualità e cantierabilità, rischiamo di restare a bocca asciutta. O quasi. Al tempo stesso, però, il “grimaldello” all’esame del parlamento si pone sul solco di una maggiore “flessibilità” nella lettura dei trattati europei e di accordi intergovernativi quali il Fiscal Compact.
Già a dicembre – a causa del periodo natalizio pochi se ne sono accorti – una comunicazione della commissione chiariva che per investimenti di rilevanza europea i contributi diretti dei paesi al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (il fulcro del Piano Juncker) non saranno “computati” ai fini della procedura per deficit eccessivo e che la commissione terrà conto dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei nel valutare i progressi verso il pareggio strutturale, consentendo “deviazioni temporanee”, ma solo se l’economia è in recessione e sia rispettato il tetto massimo del 3% nel rapporto deficit/Pil. Una nuova “comunicazione” ha iniziato il proprio percorso; potrebbe essere emanata prima dell’estate. È possibile un ulteriore ampliamento dell’interpretazione nell’ambito di un approccio coordinato di Bei (al centro del sistema) e banche nazionale di sviluppo e di promozione degli investimenti. In particolare, le “deviazioni” potrebbero diventare pluriennali (dato che tali sono gli investimenti), il tetto del 3% ammorbidito e con esso anche la clausola che ora richiede un “economia in recessione”. È un’opportunità importante per l’Italia, sempre che si sia in grado di allestire un adeguata platea di progetti. Altrimenti l’opportunità verrà colta principalmente da Germania ed Austria che hanno disperato bisogno di infrastrutture (principalmente nel comparto dei trasporti) e progetti pronti. Come ben sa chi si avventura sulle loro autobahn e sui loro treni.