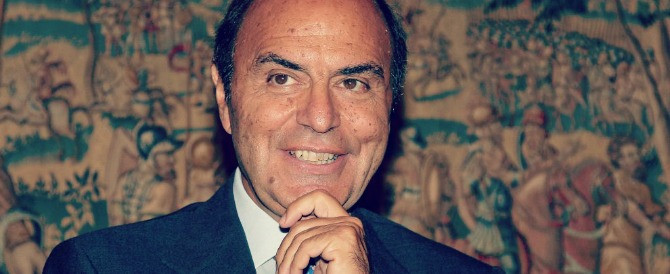Piccole misure senza ambizioni
Alberto Alesina e Francesco Giavazzi – Corriere della Sera
Il governo sta compiendo un errore che potrebbe costarci un altro anno (sarebbe il quarto consecutivo) di crescita negativa con conseguente, ulteriore aumento della disoccupazione. Nessun Paese industriale, almeno negli ultimi 70 anni, ha avuto una recessione tanto lunga. Se non cresciamo, il debito (già al 131,6% del Pil ) rischia di diventare insostenibile, almeno nella percezione degli investitori internazionali, che ne detengono oltre 600 miliardi. Se non ricominciamo rapidamente a crescere rischiamo una crisi finanziaria.
La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza pubblicata dal governo la scorsa settimana assume che la crescita miracolosamente aumenti di quasi un punto: dal -0,3 previsto per il 2014 a +0,6 nel 2015. L’Ocse invece prevede un misero +0,1. Da dove verrà quel mezzo punto di crescita in più? Previsioni ottimistiche sono un vecchio trucco per fare apparire più roseo il bilancio. Se la crescita non dovesse raggiungere il livello previsto dal governo anche l’obiettivo di un deficit inferiore al 3% verrebbe mancato, salvo una correzione dei conti in corso d’anno che in parole semplici vuol dire un aumento di imposte. E comunque il ministro Padoan ha detto che già nella legge di Stabilità gli ammortizzatori sociali «saranno coperti dalla spending review e da alcune misure di efficientamento delle entrate». Ecco come si sta sotto il 3%: con un aumento della pressione fiscale!
Deve essere chiaro che c’è un solo modo per sperare di poter riprendere a crescere: ridurre la pressione fiscale. Abbassare le tasse sul lavoro pagate dalle imprese italiane al livello di quelle tedesche significa tagliarle di 40 miliardi. Tagliare immediatamente le spese di una cifra corrispondente non è possibile perché per ridurre la spesa serve tempo. Se solo si fosse cominciato prima! Nei prossimi due, tre anni quindi supereremmo la soglia del 3%. Se sforiamo, entreremmo nella procedura prevista per chi viola le regole europee, ma senza effetti significativi se già avessimo approvato un programma vincolante di tagli alla spesa e varato per decreto una riforma seria del mercato del lavoro. È ciò che fece la Germania nel 2003 quando Schröder varò la sua riforma del lavoro. La Francia ha annunciato per il 2015 un deficit del 4,3%, ma finora Hollande non ha fatto alcuna riforma significativa.
Certo, è più facile per il ministro dell’Economia fare poco o nulla cercando di resistere sotto il 3%, magari con un aumento mascherato della pressione fiscale, e farsi applaudire nei consigli europei. Un piano complesso e innovativo di tagli di tasse, riduzioni di spesa e riforme richiederebbe un massiccio investimento di credibilità politica. Ma è l’unica via per salvare il governo di Matteo Renzi e, ciò che è più importante, l’Italia.