
il mattino


Regioni spendaccione: niente tagli, più costi
Redazione », Scrivono di noi il mattino, rassegna stampa, regioni, spesa pubblica
Sergio Governale – Il Mattino
I tagli piovono a ogni manovra, ma la macchina statale costa ogni anno sempre di più. In particolare quella delle Regioni. Dopo la «Relazione sugli andamenti della finanza territoriale per il 2014» della Corte dei Conti, diffusa poco prima di Ferragosto, è ImpresaLavoro a calcolare che la spesa corrente delle Regioni continua a crescere, «nonostante gli annunci di spending review più volte fatti dai vari governi». Rielaborando i dati della magistratura contabile, il Centro Studi di ispirazione liberale nato su iniziativa dell’imprenditore Massimo Blasoni ha notato «come la spesa pubblica corrente delle Regioni nel periodo 2011-2014 sia cresciuta di 3,9 miliardi di euro, passando da 141,7 a 145,6 miliardi». Più virtuose nel periodo le Regioni a statuto speciale, che hanno diminuito le uscite in media del 2,5%, creando un «tesoretto», come lo ha definito ImpresaLavoro, pari a 700 milioni, «interamente vanificato dall’incremento delle uscite delle Regioni a statuto ordinario», dove la spesa è aumentata di quasi 5 miliardi, «passando da 110,4 a 115 miliardi». Tra queste ultime, spiccano il Lazio e la Calabria, dove le uscite sono cresciute nel quadriennio di oltre il 30%: più 33,33% nel primo e più 31,06% nella seconda.
Non va meglio se si guarda soltanto alla variazione dal 2013 al 2014. In un anno, infatti, le spese correnti degli stessi enti hanno registrato un incremento rispettivamente del 31,45% e del 21,95%. «Medaglia di bronzo» all’Umbria: più 11,11% nel quadriennio e più 8,3% nell’ultimo anno. In fondo alla classifica la Lombardia, che ha effettuato i maggiori tagli ai costi correnti, scesi dell’11,63%. Seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano (meno 6,33%), da Abruzzo (meno 6,09%), Sardegna (meno 5,94%) e Sicilia (meno 2,18%). Si è comportata bene anche la Campania: meno 1,96% dal 2001 al 2014, che però ha visto salire le spese correnti nell’esercizio 2014 del 3,57%.
Nel complesso, si legge nello studio, «l’incremento della spesa corrente nel quadriennio per il totale delle Regioni è stato contenuto: più 2,76%». Gli enti a statuto ordinario hanno invece aumentato la propria spesa del 4,25% mentre, come detto, quelle a statuto speciale l’hanno ridotta del 2,46%». Guardando alla spesa corrente pro-capite del 2014, la lombardia è rimasta la Regione più virtuosa. L’ente che ha sede a Milano ha speso infatti l’anno scorso 1.739 euro per ogni residente, meno della metà di quanto è uscito dalle casse del Lazio, che con i suoi 3.129 euro ha fatto segnare l’esborso più elevato tra le Regioni a statuto ordinario, seguito ancora una volta dalla Calabria con 2.638 euro. Per Palazzo Santa Lucia l’uscita per abitante è stata pari a quasi 2.160 euro.
Tra le autonomie speciali, invece, è la Valle d’Aosta ad aver avuto una spesa corrente pro-capite decisamente superiore al resto d’Italia. «Ogni cittadino valdostano è costato l’anno scorso quasi 9.000 euro», ha spiegato ImpresaLavoro. Mentre «chi spende di meno» nella stessa tipologia di ente «è comunque la Sicilia con i suoi 2.529 euro». Secondo il Centro Studi, la spesa di larga parte delle autonomie, benché più elevata della media delle Regioni a statuto ordinario, «si è sensibilmente ridotta in questi anni di spending review, mentre appaiono incomprimibili larga parte delle uscite sostenute dalle Regioni a statuto ordinario, che rappresentano quasi l’80% della spesa totale».
Il lavoro dei responsabili della revisione della spesa pubblica Yoram Gutgeld e Roberto Perotti, che mirano a ottenere risparmi per almeno 10 miliardi per la manovra 2016 da 25-30 miliardi, è comunque arduo. Secondo Unimpresa, la spesa dello Stato nel primo semestre del 2015, in base ai dati di Bankitalia, è aumentata infatti di quasi 18 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una crescita superiore al 7%. Sono «in dubbio gli effetti della spending review, alla base del piano di tagli alle tasse da 45 miliardi annunciato dal governo Renzi», ha avvertito nei giorni scorsi il Centro Studi dell’associazione presieduta da Paolo Longobardi.

La condanna di Maastricht
Redazione Edicola - Opinioni europa, giorgio la malfa, il mattino, istat
Giorgio La Malfa – Il Mattino
I dati dell’Istat indicano che nell’ultimo trimestre del 2014 il reddito nazionale italiano non è diminuito. È la prima volta negli ultimi anni. Quanto al 2015, trova conferma nelle previsioni la stima del governo di un aumento del reddito dell’ordine dello 0,5%. Che il Ministro dell’Economia possa trarre un sospiro di sollievo dopo un flusso ininterrotto di dati negativi che dura da anni è comprensibile. Ma sostenere che la crisi è finita e che si apre per l’Italia una specie dell’età dell’oro, come si sente dire negli alti livelli del governo, appare francamente eccessivo. Questi dati non giustificano né l’esultanza, né tanto meno l’inerzia. Con una crescita di questo ordine non si mette a posto ne la disoccupazione, né il debito pubblico.
Per quello che riguarda il passato, rimane il giudizio negativo sulla inutilità della cura “tedesca” imposta a noi (ma non soltanto a noi) dall’Europa, in materia di deficit. La cura ha avuto effetti devastanti sulla domanda interna, sulla produzione industriale e sulla disoccupazione. Anche se le cifre della disoccupazione sono meno drammatiche che in Grecia e in Spagna, l’Italia ha contratto il proprio patrimonio industriale di quasi il 25% nel corso di questi anni, come testimoniano le migliaia di capannoni e di opifici chiusi in tutte le aree del Nord. E rimane anche il profondo rammarico per la sostanziale rassegnazione dei quattro governi che si sono succeduti dal 2011 in avanti – Berlusconi, Monti, Letta e Renzi – rispetto a una politica che aveva conseguenze visibili.
Quanto al presente e, soprattutto, al futuro, deve essere detto con chiarezza ed a scanso di ogni possibile equivoco, che una crescita dello 0,5 o anche dell’1%, cui forse si potrebbe giungere quest’anno per effetto della flessione dell’euro e della caduta dei prezzi del petrolio, non è l’inizio della fine dei nostri problemi. Una crescita a tassi inferiori al 2-3% è insufficiente a incidere sulla disoccupazione, perché contemporaneamente i guadagni di produttività che si verificano nel sistema tendono a fare crescere la disoccupazione. E nello stesso tempo, se il reddito nazionale cresce dello 0,5-1%, mentre i prezzi sono sostanzialmente stabili, il problema del debito pubblico tende ad aggravarsi, a meno che il governo non intenda compiere un’ulteriore stretta fiscale con il rischio di distruggere anche quei piccoli segni di ripresa che si colgono nelle statistiche e nelle previsioni di questi giorni.
Il punto che il mondo della politica non ha voluto e saputo cogliere in questi anni è che c’è una contraddizione inevitabile nella nostra situazione fra il rispetto delle regole di Maastricht e la possibilità di sostenere una ripresa economica più solida e consistente. Non vale illudersi che questa contraddizione si possa evitare: il rispetto delle regole di Maastricht rende impossibile sostenere la ripresa e dunque lascia il Paese nella crisi e in prospettiva aggrava le condizioni stesse del debito pubblico (la Grecia, all’inizio della cura durissima che le è stata imposta dalla Troika, aveva un rapporto fra debito pubblico e Prodotto Interno dell’ordine del 110%. Dopo 4 anni di deflazione, con un reddito nazionale di un quarto più basso e una disoccupazione triplicata dall’8 al 27% ha un rapporto fra debito e Pil del 170%).
Una politica di sostegno alla ripresa richiede ed impone il superamento del deficit del 3%. Nessuno dei governi succedutisi in questi anni ha avuto il coraggio di farlo. Anche il governo attuale si è limitato ad auspicare che sia l’Europa a cambiare idea, ma non se la è sentita di prendere con coraggio la strada del sostegno della ripresa. Questo è stato in questi anni e rimane oggi il nodo gordiano da tagliare. È certamente positivo che i dati economici abbiamo cessato di peggiorare. A una condizione: che questa schiarita non illuda il governo di illudersi e non lo convinca a cercare di illudere gli italiani che l’inerzia sia una politica.

Doccia fredda sulla crescita 2015, Italia bloccata dalle tasse locali
Redazione Edicola - Opinioni bce, crescita, il mattino, jobs act, Oscar Giannino, pil, quantitative easing
Oscar Giannino – Il Mattino
Le stime economiche sul 2015 diramate ieri sono una bella secchiata di ghiaccio sui recenti entusiasmi italiani. In sintesi, nel 2014 nell’euroarea solo Cipro, col suo Pil che ha segnato -2,8%, ha fatto peggio dell’Italia che ha chiuso a -0,5%. Nel 2015 l’Italia e Cipro restano i fanalini di coda, con previsioni di crescita ferme a +0,6% nel nostro caso e a +0,4% per i ciprioti. E nel 2016 Cipro ci spera, con un +1,6% rispetto al nostro +1,3%. La nostra disoccupazione non scende dal 12,8% nel 2015 e scende solo al 12,6% nel 2016. Certo, il 12,6% dell’Italia non è paragonabile al 26,6% della Grecia o al 24% della Spagna, ma in due anni in questi paesi è previsto che scenda di 4 punti. Se volete, consolatevi con fatto che la Commissione crede che il deficit italiano resterà al 2,6% del Pil, sotto il livello di guardia del 3%.
Perché restiamo in coda?
La scheda riservata all’Italia spiega esaurientemente perché Bruxelles non sia affatto convinta delle stime di crescita 2015 fino al 2% recentemente rilasciate nel nostro paese (ma attenti che Bankitalia prudentemente non si è ancora discostata dal +0,4% che risale a novembre scorso). Quel misero +0,6% attribuitoci nel 2015 dipende da consumi interni che non possono contribuire per più dello 0,3%, e per un traino dell’export che vale +0,4%, mentre le scorte hanno un effetto negativo del -0, 1%. La propensione al risparmio dovrebbe salire invece dal 12,2% del reddito disponibile al 13,1%, continuando a far arrabbiare il presidente del Consiglio e i suoi consiglieri che la considerano un «arricchimento» degli italiani. Non è cosi. Trovandosi ad aver perso il 10% del valore reale della loro ricchezza netta e con un reddito reale procapite diminuito per effetto della disoccupazione e dell’innalzamento di tasse locali e tariffe pubbliche, gli italiani mettono da parte e non consumano, perché non si fidano di aumenti ancora maggiori fiscali – previsti in legge di stabilità per decine di miliardi negli anni 2016-2018 – contributivi – scattati da inizio gennaio per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata Inps – e di tariffe delle municipalizzate.Ma il Jobs Act e gli incentivi all’assunzione?
In effetti, Bruxelles non dà il peso a questi due fattori che molti stimano invece come considerevole in Italia. L’occupazione totale dovrebbe salire solo dello 0,4% nel 2015, per la Commissione. L’impressione in Italia è che soprattutto i rilevanti incentivi monetari all’assunzione votato in legge di stabilità, a fronte di imprese che da 10 mesi tenevano il piede sul fre- no aspettando che venissero deliberati, dovrebbe portare a molti più occupati. I 94 mila aggiuntivi a sorpresa dello scorso dicembre – senza incentivi – compensavano a mala pena i 106 mila persi tra ottobre e novembre ma hanno fatto ben sperare. Vedremo. L’intera scommessa di Renzi si gioca su questo tavolo.E il bonus petrolifero?
È vero, il barile è sceso dai 114 dollari di giugno 2014 ai 51-53 attuali. Ma primo nessuno si sente di scommettere che resti davvero a questa soglia (nelle ultime 2 settimane è salito da 41 a 50). E secondo l’Italia può prendersela solo con se stessa: nel nostro caso si trasferisce solo una minima parte del minor costo industriale alla tasca di famiglie e imprese, perché lo Stato si piglia per se più del 60% del costo finale tra accisa e Iva.E il Qe della Bce?
Anche il minor costo del credito per effetto degli acquisti di titoli – per 1,1 trilioni di euro tra marzo 2015 e autunno 2016 – decisi dalla Bce si trasferirà in minima parte ad aziende nostrane e italiani, se non si risolve in qualche modo l’ostacolo di 180 miliardi di sofferenze e 150 miliardi di incagli in pancia alle banche italiane. Dopo 3 anni di ritardo, finalmente il governo Renzi sta pensando a una bad bank di sistema per sgravarne le banche almeno di una metà a condizioni vantaggiose. Ma siamo ancora a caro amico, perché i problemi tecnici da risolvere sono tanti, per evitare l’accusa di aiuti di Stato e tentare di coinvolgere capitali privati oltre alla garanzia di Cdp. Siccome i tempi sono lunghi, per il momento l’unico a beneficare di Francoforte sarà sempre lui, lo Stato italiano che risparmierà interessi sul debito pubblico.Ma se il deficil risale?
Questo è l’unico aspetto da non temere più. Non solo Bruxelles stima molto generosamente un deficit pubblico italiano in discesa, mentre molti osservatori italiani – vista la legge di stabilità approvata dal Parlamento sforbiciando i tagli di spesa inizialmente previsti – sono disposti a scommettere che anche nel 2015 rischiamo di sforare il 3%. In realtà, con i recenti nuovi criteri di interpretazione del Patto di stabilità e crescita europeo diramati dalla Commissione, non rischiamo certo anche nel caso di sforamento del 3% niente di particolarmente grave, si aggiusterebbe tutto con 4 miliardi di aggiustamento da decidere a dicembre.Conclusione
Sono tutte previsioni che non tengono in considerazione né un trauma sistemico all’eurozona se la situazione greca sfugge di mano, né una fiammata d’instabilità internazionale dovuta alla drammatica guerra alla svalutazione delle valute in atto in tre quarti del mondo, che espone molti paesi non più velocemente emergenti a trovarsi impiccati a debiti in dollari che salgono di valore. Ma detto questo, inutile illudersi. Se cresciamo così poco, è perché un paese impiccato ad alte tasse, a credito asfittico per la condizione delle sue banche, e a così forte disomogeneità tra Sud desertificato e Nord quasi-europeo, ha dentro di sé, nei propri errori e nel proprio modello distorto, le ragioni e le colpe dei propri guai.

Perché la Grecia può farci male
Redazione Edicola - Opinioni emiliano brancaccio, europa, gennaro zezza, grecia, il mattino
Emiliano Brancaccio e Gennaro Zezza – Il Mattino
Non si può dire che tra il 2010 e il 2014 la Grecia non abbia «fatto i compiti» assegnati dalla Troika. La pressione fiscale è cresciuta di cinque punti percentuali rispetto al Pil, la spesa pubblica è diminuita di un quarto e i salari monetari sono caduti di venti punti percentuali. La Commissione europea ha sempre sostenuto che queste politiche non avrebbero depresso l’economia e avrebbero rilanciato la competitività. Ma le sue previsioni sull’andamento del Pil greco sono state ripetutamente smentite: in Grecia il crollo della produzione ha fatto registrare un divario rispetto alle stime di Bruxelles che talvolta ha oltrepassato l’imbarazzante cifra di sette punti di Pil. Anche sul versante della competitività, nonostante l’abbattimento dei salari e dei costi, i risultati sono stati diversi dalle attese: il saldo verso l’estero è migliorato, ma molto più per il tonfo del reddito e delle importazioni che per una ripresa dell’export. Né si può dire che le politiche indicate dalla Troika abbiano stabilizzato i bilanci: il deficit pubblico è stato faticosamente ridotto ma la caduta della produzione ha implicato un’esplosione del rapporto tra debito pubblico e Pil di trenta punti percentuali.
Il caso greco, si badi bene, è estremo ma non costituisce affatto un’eccezione. Esso rappresenta la più chiara conferma della previsione del «monito degli economisti» (www.theeconomistswarning.com) pubblicato nel settembre 2013 sul Financial Times: anziché stabilizzare l’eurozona, le attuali politiche europee alimentano una deflazione da debiti, accentuano i divari tra paesi del Nord e del Sud Europa e in prospettiva affossano le probabilità di sopravvivenza dell’Unione monetaria. Molti commentatori ritengono però che un ritorno alla dracma avrebbe ripercussioni ancor più pesanti sull’economia greca. L’ implicazione che ne traggono è che il nuovo governo guidato da Alexis Tsipras non ha alternative: dopo la passerella in Europa e gli incontri con Renzi e Juncker, alla fine il premier greco dovrà accontentarsi delle modeste concessioni sul debito che Bruxelles sarà disposta a offrire.
Ma è proprio vero che la Grecia non ha carte da giocare? In realtà la letteratura scientifica sui costi e benefici di un eventuale abbandono dell’euro fornisce risultati controversi. Il punto su cui gli economisti concordano è che il successo o il fallimento di un ritorno alla moneta nazionale dipenderebbero in ultima istanza dalla capacità o meno della Grecia di rilanciare la domanda e la produzione interna tenendo in equilibrio il saldo delle importazioni e delle esportazioni verso l’estero. Se riuscisse a controllare il saldo estero, la Grecia ridurrebbe la sua dipendenza dai prestiti internazionali e avrebbe quindi una chance in più per gestire la difficile transizione. Il problema è che la crisi ha distrutto una parte importante della base produttiva del paese, per cui un eventuale stimolo alla domanda di beni rischia di determinare un forte aumento delle importazioni e del deficit estero. Spunti interessanti, a tale riguardo, si possono trarre dal modello per l’economia greca elaborato dal Levy Economics Institute (www.levy.org), che ha dato prova di buone capacità di previsione rispetto alle stime delle principali istituzioni internazionali. Il modello mostra che l’attuale miglioramento del conto estero già fornisce spazi di manovra per una politica espansiva. Entro i vincoli di bilancio europei, tuttavia, lo stimolo sarebbe insufficiente a risollevare il Pil e l’occupazione in modo apprezzabile.
Si consideri allora l’ipotesi che in assenza di un sostegno europeo al rilancio dell’economia ellenica, nel 2015 la Grecia attui un default del debito e un ritorno alla dracma, e adotti una politica di bilancio espansiva fino a 10 miliardi. Con assunzioni pessimistiche sulla svalutazione della dracma e sul suo impatto sui prezzi dei beni importati, il modello prevede un consistente aumento del Pil ma anche un miglioramento delle esportazioni modesto, e nel breve periodo un peggioramento sul versante delle importazioni. La conseguenza sarebbe un deficit verso l’estero fino a cinque miliardi di euro – circa il tre percento del Pil – che andrebbe a ridursi lentamente negli anni successivi. Come si potrebbe gestire la fase di aumento del disavanzo estero? In che modo si potrebbe contenerlo? Ed esisterebbero paesi disposti a finanziario? Si tratta di interrogativi cruciali, per Tsipras ma anche per l’intera Europa. Chi si illude che il caso della Grecia possa essere isolato, è stato già seccamente smentito dall’effetto domino degli anni passati. Se il governo greco venisse messo all’angolo e a quel punto ritenesse di poter gestire una eventuale uscita dall’euro, inevitabili sarebbero le ricadute sull’Italia, sul Sud Europa e sulla tenuta complessiva dell’Unione monetaria.

Ue e conti pubblici, cosa rischia l’Italia
Redazione Edicola - Opinioni conti pubblici, europa, il mattino, Oscar Giannino
Oscar Giannino – Il Mattino
Si chiama Excessive Imbalance Procedure, procedura contro gli squilibri eccessivi, ed è il rischio che concretamente corre l’Italia di Renzi. Si era capito già all’esordio del neo presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker, quando ruvidamente aveva risposto a Renzi «io non sono a capo di una banda di burocrati, forse lui sì». In Italia ormai va di moda sui media e nei dibattiti pubblici ostentare indifferenza e battutacce all’Europa e alle sue richieste, considerate da tanti assurde, o addirittura braccio armato di una Germania da Quarto Reich. In realtà, da anni siamo noi italiani a prendere in giro noi stessi – visto quel che paghiamo, sempre di più – ed è un abile gioco di ruolo dei politici farci credere chela colpa sia degli altri. Vediamo perché, in tre punti.
È una sorpresa, la nuova richiesta europea? No, non lo è affatto, a meno di fare i fìnti tonti. Renzi è bravo a giocare sul tavolo della comunicazione, ma sui numeri meglio stare attenti. La Commissione Europea aveva chiesto già al governo Letta una correzione pari allo 0,2 prima e poi allo 0,4% di Pil della manovra per il 2014, e l’Italia ha fatto finta di non sentire. La Commissione ce l’ha richiesto quando il governo Renzi ha approvato il Def di aprile. E l’Italia ha fatto finta di non sentire. I mesi son passati senza corposi interventi sulla spesa pubblica (ricordate che il bonus 80 euro è un aumento di spesa da quasi 10 miliardi, non un taglio alle tasse).
Il ministro dell’Economia Padoan nel corso dell’estate ha maturato un’idea alla quale ancorare la giustificazione del rinvio degli impegni italiani: la contestazione del metodo con cui la Commissione Ue valuta il Pil potenziale. Maggiore è la diminuzione, peggio è persino rispetto alla recessione del Pil reale, perché significa che si faticherà di più a riprendere il sentiero della crescita. Un’idea forse giusta. Che però doveva essere messa apertamente al centro del confronto sul tavolo europeo, presentandola a maggio-giugno alla vecchia Commissione Barroso. Invece no, l’Italia ha fatto la furba, ha tirato fuori questa sua autogiustificazione solo con la nota di aggiornamento del Def di aprile, approvata lo scorso 30 settembre. Ed è a quella nota, e a questa maniera tutta italiana di fingersi vittime dell’incomprensione altrui e di inventarsi da soli un criterio che non è stato prima condiviso con altri, che la vecchia Commissione Barroso e la nuova Juncker reagiscono dicendo «non ci siamo». Ora restiamo in attesa dell’esame che la Commissione sta facendo della legge di stabilità in quanto tale, e il responso è atteso per il prossimo 24 novembre.
Che cosa rischiamo? Non una procedura d’infrazione vera e propria, quella che scatterebbe con un avviso a modificare la legge di stabilità, che se non fosse ascoltato potrebbe tradursi in una vera e propria messa in mora con tanto di accantonamento di una sanzione pari fino allo 0,5% del Pil, deposito infruttifero che entro un biennio potrebbe andare perduto se il paese in violazione persistesse nel far orecchio da mercante. La procedura contro gli squilibri eccessivi si riferisce ai rischi sistemici che dalle condizioni di un paese europeo possono venire a tutti gli altri. Noi abbiamo semplicemente troppo debito pubblico per giocare col fuoco.
Da una parte insieme alla Germania siamo il paese in cui i contribuenti, troppo proni al volere della politica, hanno fatto il maggior sforzo europeo, pagando di tasca propria avanzi primari superiori all’equivalente attuale di 600 miliardi dal 1992 a oggi. Dall’altra però la politica ha accelerato fino a pochissimo tempo fa sulla spesa pubblica, e il debito sale, sale, continua a salire anche adesso che l’Italia rinvia al 2016-2018 il più dello sforzo necessario a farne iniziare la discesa. E quando si dice il più dello sforzo, si tratta della bellezza di 30 miliardi di nuove entrate aggiuntive. Che questo governo prevede come clausola di salvaguardia negli anni 2016-2018, con l’aumento delle accise e dell’IVA fino al 25%.
La Commissione fin qui non ha aggiornato le stime dell’ulteriore saldo pubblico migliorato che potrebbe chiederci (dopo i 6 miliardi che il governo ha già dovuto modificare di minor deficit, rispetto alla prima versione della legge di stabilità), anche se è facile fare il conto. Col criterio del Pil potenziale europeo, invece di quello autoctono forgiato al Tesoro, ci potrebbero chiedere quasi un punto di Pil di nuove tasse o tagli di spesa, per il 2015. Non avverrà. Il punto è un altro. La Commissione fa osservazioni puntute proprio sulla richiesta venuta da Renzi. È stato il premier italiano a dire sin dall’inizio del suo governo: cara Europa, io mi impegno su riforme energiche, e in cambio di queste, che produrranno stabili miglioramenti della crescita potenziale prima e di quella reale poi, tu fammi uno sconto. Bruxelles e Berlino, a differenza di quanto scrivono molti ciechi, hanno sposato tale richiesta. Solo che la Commissione osserva che le tante riforme annunciate stentano, quella sul lavoro dalla legge delega senza ancora decreti delegati non si capisce che cosa sarà davvero. Il Semplifica-Italia del 2012 non è ancora attuato. Le privatizzazioni promesse semplicemente non ci sono state, anzi sia in Poste che in Ferrovie la partita è molto più complessa di quanto il governo avesse detto all’inizio. Fatevi una domanda. Sono fatti, o ha torto la Commissione?
Alternative possibili? Il punto non sono i 3-5 miliardi ulteriori che la Commissione potrebbe chiedere il 24 novembre, e che il governo non è affatto detto – come già avvenne con Letta – che decida di accettare. Le instabilità italiane – in Europa non piace neanche un po’ la fibrillazione evidente all’annuncio ufficioso delle dimissioni di Napolitano senza accordo sulla riforma elettorale, il rischio di nuove elezioni anticipate nel caos – si riaccendono in un quadro internazionale oscurato dall’irritazione della Russia, in recessione per le sanzioni relative alla vicenda ucraina e col rublo a picco insieme alle entrate energetiche col petrolio sotto gli 80 dollari. E poi dalla crisi mediorientale e dal rallentamento di Cina e Brasile. Il termometro è l’esposizione delle banche tedesche verso l’Italia, ferma allo stesso dato – 125 miliardi – della primavera 2012: nessun segno di ripresa di fiducia verso l’Italia.
Inutile girarci intorno: c’è solo da sperare che la politica non tiri troppo la corda. Altrimenti sappiatelo: quei 30 miliardi di nuove entrate che la politica rinvia al 2016-2018, inizieranno a manifestarsi anzitempo. Sarebbe una mazzata veramente esiziale. Ma guardate che tra local tax sicuramente al di sopra dei 31,2 miliardi oggi previsti sommando tutte le imposte esistenti sul mattone, e nuovo catasto in teoria assicurato a parità di gettito ma che i tecnici privati di settore stimano con aumenti molto considerevoli, già oggi la presunta e popolare rivolta contro le regole europee si presenta nascondendo dietro la schiena una marea di nuove tasse. Né la differenza la può fare san Mario Draghi. Certo, possiamo sempre credere di spaventare l’Europa e la Germania minacciando lo sfracello dell’euro. Che è come credere di far paura ad altri facendoci scoppiare una bomba atomica sulla testa.
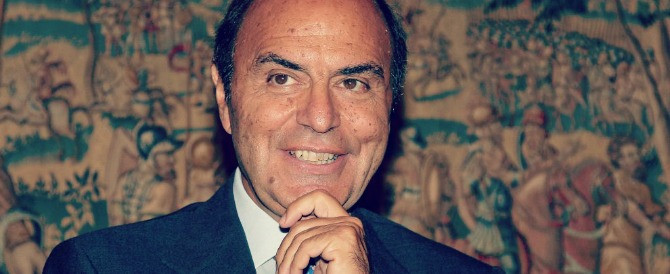
Renzi, il premier carro armato
Redazione Edicola - Opinioni bruno vespa, il mattino, legge di stabilità, manovra, Matteo Renzi, regioni, spending review
Bruno Vespa – Il Mattino
Sempre contro le istituzioni, sempre con l’opinione pubblica. Matteo Renzi è fatto così. Per istituzioni qui si intendono i poteri pubblici e privati costituiti e riconosciuti. Il vecchio Pd, il seminario economico di Cernobbio, l’assemblea di Confindustria, la Cgil. E adesso le regioni e le province. Ieri mattina ho provato a chiedere alla radio se avesse ragione Renzi a chiedere tagli alle regioni o le regioni a protestare. Un diluvio (quasi) a favore del presidente del Consiglio. «Quando il mio capo ha scoperto che cercavo su internet un fornitore di apparati sanitari più conveniente dei soliti mi ha bloccato». «Ho fatto uno stage in un Comune e ho visto tanti sprechi che lei non può immaginare». «Lavoro nell’edilizia e per fissare a terra tre panchine sono venuti tre operai comunali per tre giorni». «Giro per conto di un’azienda farmaceutica e non le dico quel che vedo». E così via.
Matteo Renzi ha sotto il letto due fantasmi pronti a venir fuori. Uno si chiama Franco Fiorito, il Batman di Anagni, già potentissimo capogruppo del PdL al consiglio regionale del Lazio. L’altro è Filippo Penati, potentissimo presidente della provincia di Milano, poi assistente a Roma di Pierluigi Bersani: esempio classico, con il «sistema Sesto», della continuazione nelle relazioni oblique tra costruttori e politici, anche «rossi»›, dai tempi di Tangentopoli alla Seconda Repubblica. Condannato a tre anni e quattro mesi e a restituire un milione 90mila euro, Fiorito disse in una memorabile trasmissione di «Porta a porta» poco prima che l’arrestassero (e continua a dire tuttora): «Non ho rubato nulla, quei soldi mi sono stati assegnati con regolari delibere». Nel senso che i capigruppo in consiglio regionale potevano amministrare, diciamo così, discrezionalmente, i fondi ad essi assegnati. Penati se l’è cavata con la prescrizione: era accusato di concussione perché il «sistema Sesto» che ruotava intorno al risanamento dell’area Falk-Marelli di Sesto San Giovanni era il modo esemplare di gestione affaristica del Pci-Pds-Ds. Renzi ha eliminato i consiglieri provinciali elettivi: da 2600 li ha portati a poco meno di mille, senza retribuzione aggiuntiva perché sono consiglieri regionali o comunali. Ma la corsa avvenuta tra il 26 settembre e domenica scorsa per accaparrarsi posti in cui si lavora gratis è stata così forte che il governo ha chiuso i rubinetti togliendo un miliardo alle province contro i quattro chiesti alle regioni.
È evidente che queste misure vanno amministrare con saggezza: qualcuno dovrà pur provvedere le scuole e le strade in carico alle province, mentre sarebbe grave se i tagli alle regioni si ripercuotessero su sanità e servizi. Quattro miliardi sono meno del 3 per cento della spesa regionale, assorbita in larghissima parte da stipendi e sanità. Quanto si può tagliare sulla sanità senza penalizzare uno dei migliori servizi del mondo? Basterebbe imporre sul serio i costi standard ed eliminare le anomalie ancora visibili nel Sud, ma non solo. Resta incomprensibile perché dal rispetto dei costi standard sono escluse le cinque regioni a statuto speciale per un patto del febbraio 2011. Non credo che l’autonomia etnica verrebbe compromessa da un adeguamento alla linea nazionale di risparmio. La Lega, che pure era al governo, non protestò. Se Matteo Renzi riuscisse a togliere anche questa anomalia, farebbe cosa buona e giusta.

Il Paese dei prestiti negati
Redazione Edicola - Argomenti crisi, gigi di fiore, il mattino, prestiti, reddito
Gigi Di Fiore – Il Mattino
Un commerciante suicida per i debiti, un pensionato che rischia di perdere la casa, il Sud nella morsa dell’usura: schegge di conseguenze indirette scatenate dal calo dei prestiti bancari, diminuiti dello 0,8 per cento alle famiglie e del 3,8 per cento alle imprese. Dati dell’ultimo mese, calcolati dalla Banca d’Italia. Sono lontani i tempi in cui non ci restavano che le banche per coronare un sogno. Una casa, un’auto, un viaggio: bastava chiedere un prestito, anche piccolo, per conquistarsi l’oggetto del desiderio. A garanzia, un immobile, la propria busta paga di lavoratore a tempo indeterminato, un parente pronto a metterci la faccia per il sì al denaro chiesto. Capi famiglia, artigiani, commercianti hanno alimentato l’esercito dei piccoli risparmiatori che si rivolgevano alle banche per esigenze improvvise. Fino al 2000, secondo i dati dell’ufficio studi della Banca d’Italia, il mercato del credito alle famiglie era di dimensioni ancora limitate rispetto al resto d’Europa: un terzo del reddito disponibile in un anno. Poi, da allora, 14 anni fa, in coincidenza con il calo dei tassi d’interesse, i prestiti bancari sono aumentati fino all’inversione di tendenza esplosa nel 2008.
La crisi, i redditi in diminuzione, la stretta della tasse sempre più numerose hanno spinto la chiusura dei rubinetti. Negli ultimi tre anni, il tramonto del periodo di vacche grasse è diventato fisiologico. Con storie che si fanno dramma, in una spirale sempre più preoccupante. A Ginosa Marina, in provincia di Taranto, un commerciante di 60 anni si è suicidato. Ha lasciato un piccolo quadernetto, dove ha registrato l’abisso della sua sofferenza. Nelle pagine scritte, quasi un testamento: «Mi sono trovato in grandi difficoltà economiche e avevo urgente bisogno di 1300 euro per coprire un assegno consegnato ad un fornitore. Rischiavo il protesto, mi sono rivolto alla mia banca per un fido. Me l’hanno rifiutato e sono piombato nella disperazione». Una moglie e tre figli, il no della piccola banca locale motivato da una «rilevante esposizione debitoria», ha spiegato l’avvocato Giuseppe Lecce, incaricato dalla famiglia di denunciare la banca per «istigazione al suicidio»: «Dagli estratti conto, abbiamo rilevato addebiti sproporzionati per le transazioni scaturite dall’uso del Pos sui pagamenti con carte di credito. Probabilmente, si trattava di errori e il commerciante lo ha fatto presente, nella richiesta di fido. Non l’hanno ascoltato, addebitandogli invece debiti rilevanti».
Casi limite, certo. Ma spia di situazioni difficili. Al Sud come al Nord. A Santa Vittoria di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, un artigiano di 42 anni ha denunciato la banca per usura. Dopo aver pagato per otto anni le rate di un mutuo decennale a tasso variabile, ha dovuto smettere perché si era trovato in difficoltà per il calo di guadagni nella sua attività. Stop alla rata di 800 euro, per poi rivolgersi ad un avvocato attraverso l’associazione antiusura Federitalia a Parma. E arriva una scoperta, attraverso il calcolo dell’associazione: i tassi applicati avrebbero sforato quelli regolari, diventando usurai.
Lo stop ai prestiti si concentra soprattutto sui mutui per l’acquisto della prima casa. Non è un caso, quindi, che il ministero del Tesoro abbia sentito il bisogno, nelle ultime ore, di firmare un protocollo d’intesa con l’Abi, l’associazione delle banche italiane. Prevede un fondo di garanzia, con dotazione di 650 milioni di euro, che dovrebbe consentire lo sblocco di una ventina di miliardi per l’acquisto della prima casa non di lusso. Spiegano Abi e ministero del Tesoro: «Si tratta di un’importante strumento di accesso al credito per la casa a favore dei cittadini, oltre che un immediato impulso alla crescita attraverso il rilancio del settore immobiliare». Beneficiati principali dovrebbero essere le giovani coppie, o un genitore separa-to con figli minorenni. Basterà? Di certo, i rubinetti a secco o totalmente chiusi del prestito bancario toccano le famiglie, come le piccole imprese. Colpa delle crisi, colpa di un sistema finanziario stritolato dalle sofferenze di crediti concessi a grossi gruppi imprenditoriali. Se i soldi vanno ai più grandi, che riescono a offrire più garanzie ma poi non pagano nei tempi fissati, a farne le spese sono i più piccoli e le famiglie. Un paradosso.
Per ristrutturazioni aziendali, o tamponare crisi, occorrono soldi. E le banche ne hanno sborsati cosi tanti che, negli ultimi mesi i 12 primi istituti creditizi italiani si incontrano con sempre maggiore frequenza per trovare soluzioni alle «sofferenze» scaturite da grossi gruppi imprenditoriali in difficoltà: 170 miliardi di euro. I nomi sono circolati da tempo, con Sorgenia, Risanamento e Tassara in cima alla lista. E scrive la Banca d’Italia, riferendosi agli ultimi mesi del 2014: «I criteri di offerta dei prestiti alle imprese sono divenuti lievemente espansivi, beneficiando del miglioramento delle attese riguardo l’attività economica in generale». Più sotto, però, il ma che complica la situazione di chi deve fare i conti con le bollette della luce, il fitto, il mutuo: «I criteri di offerta dei prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni hanno registrato un ulteriore allentamento».
I piccoli alle prese con la finanza che stritola. Giuseppe è stato a lungo in cassa integrazione alla Fiat di Pomigliano. Racconta: «Se non mi avessero aiutato i suoceri, avrei perso la casa che avevo comprato con un mutuo. Provate voi a onorare una rata di prestito, sottoscritta quando avevo un contratto di lavoro, con 700 euro al mese di cassa integrazione». La stretta alimenta il mercato delle società finanziarie private, che pretendono minori garanzie per concedere prestiti. Molte sono boarder line, strutture improvvisate, che si pubblicizzano con volantini e offrono interessi da favola e prestiti che poi si rivelano usurai. Ci sono però società finanziarie consolidate, con strutture nazionali, che finanziano acquisti di auto, computer, elettrodomestici vari. Nomi ricorrenti: Findomestic, Compass, Agos. Hanno gioco facile se, negli ultimi tre anni, secondo Unimpresa, il valore dei prestiti alle famiglie si è ridotto di 14 miliardi di euro. E per le imprese la contrazione è arrivata, sempre negli ultimi tre anni, alla somma di 70 miliardi di euro. I calcoli, dal luglio 2011 al luglio 2014, sono presto fatti: ai privati sono stati concessi dalle banche 83,1 miliardi di prestiti in meno, che significano il meno 5,49 per cento. Un’impresa fornisce la sua lettura di queste cifre: «La causa sono le sofferenze bancarie, l’insolvenza, il ritardo dei pagamenti. L’effetto diventa però la ripercussione negativa sull’economia reale».
E, a questo scenario da pianto, si aggiungono clausole e interessi applicati dalle banche, che scatenano denunce. Adusbef e Federconsumatori hanno presentato diffide contro 13 banche che, nel concedere mutui, avrebbero inserito «condizioni in grado di determinare un significativo squilibrio di diritti ed obblighi contrattuali, lesivi dei diritti degli utenti». L’elenco comprende gli interessi calcolati per scoperture momentanee dell’utente. Due giorni fa, un pensionato torinese, Vittorio Giari, si è rivolto al programma televisivo «Le Iene», per denunciare il suo caso. Ad una banca torinese aveva chiesto un prestito di 14mila euro, cedendo un quinto della pensione. Ha scoperto di aver restituito addirittura 40mila euro, con un tasso del 29 per cento, oltre il limite del 14,9 per cento fissato dalla legge per non sconfinare in usura. L’inghippo è stato scoperto: il contratto prevedeva anche un’assicurazione obbligatoria, per coprire l’eventuale morte o difficoltà del cliente a restituire il prestito. L’assicurazione è costata 10mila euro, che si è aggiunta alla restituzione con interesse. La banca, portata in tribunale, ha dovuto restituire 7500 euro. Il giudice ha dato ragione al pensionato.
Ma su quali elementi le banche rifiutano prestiti alle famiglie? Influiscono le garanzie e, negli ultimi anni, con l’incremento dei contratti a tempo determinato, gli istituti di credito sono diventati più restii a concedere mutui. Poi, ci si mettono le cosiddette «referenze creditizie». Sono i dati, raccolti da società private o pubbliche costituite da gruppi di banche e finanziarie, sui precedenti dell’utente che chiede un prestito. È l’archivio sui pagamenti in ritardo, i prestiti richiesti, gli eventuali scoperti e tutte le altre informazioni che le banche utilizzano per valutare l’attendibilità di chi chiede denaro e decidere. È il Sic (Sistema informazioni creditizie) a fornire quelle notizie. In Italia, ne esistono quattro: Experian, Consorzio tutela credito, Crif e Assilea. Sono una specie di grande fratello su chiunque si rivolga ad una banca per chiedere denaro. Un sistema invadente, che impone alle banche il segreto sui dati acquisiti. Riguarda finanziamenti inferiori ai 30mila euro. Sono proprio quelli che, inmaggior numero, richiedono le famiglie. L’invadenza nella privacy corre sul filo. Sono le banche e le finanziarie a fornire al Sic i dati personali di chi chiede un prestito. E, bisogna starne attenti, queste informazioni possono essere custodite non oltre sei mesi. Il tempo, di solito, di rispondere si o no alla richiesta. Spiegano all’Aduc, l’associazione per i diritti di utenti e consumatori: «Se il prestito è negato, o il cliente vi rinuncia, le informazioni possono restare in custodia al Sic non oltre 30 giorni. Attenzione, le notizie sui mancati pagamenti, o pagamenti in ritardo, non possono essere conservate oltre 12 mesi dalla regolarizzazione del debito. Sul Sic e i dati personali custoditi, valgono le norme sulla privacy e ci si può rivolgere al Garante per ottenere tutela». Se le richieste di prestiti sono superiori ai 75mila euro, esiste una Centrale rischi pubblica, gestita dalla Banca d’Italia. Riguarda essenzialmente le grosse imprese, i gruppi imprenditoriali di rilievo.
Denuncia Carlo Rienzi, presidente del Codacons: «È un vicolo cieco. La riduzione dei prestiti a famiglie e alle imprese strozza la ripresa. Che fine hanno fatto i miliardi di euro concessi dalla Bce agli istituti di credito, per aumentare i finanziamenti nel nostro Paese?». Domanda lecita, ma la risposta non appare semplice. Salvatore Rossi, attuale direttore generale della Banca d’Italia, ha analizzato l’andamento del credito concesso alle famiglie, partendo dal 2000. Spiega: «Le famiglie italiane hanno assistito alla progressiva riduzione del loro reddito reale, a partire dal 2008. La conseguenza è stato il ridimensionamento dell’acquisto di beni di consumo e la riduzione anche di domande di finanziamento bancario». Secondo quest’analisi, le famiglie a basso reddito sono progressivamente sparite dalla clientela bancaria. Nel 2012, le banche hanno concesso 30 miliardi di mutui e aggiunge ancora il direttore Rossi: «È cresciuta la selettività nell’offerta di credito, condizionando le scelte delle famiglie. Il tasso di sofferenza dei prestiti, così, è aumentato. Nel 2009 era passato dall’l all’1,4 per cento del totale dei prestiti esistenti».
Sono allarmanti i calcoli dell’ufficio studi della Banca d’Italia: almeno il 3, 6 per cento delle famiglie si è trovato con debiti bancari elevati. Le più vulnerabili, quelle con reddito più basso o inesistente, sono calcolate nell’1,4 per cento. Dice ancora il direttore Rossi: «Le progressive contrazioni del reddito reale e il deterioramento del mercato del lavoro hanno mutato le prospettive delle famiglie e ne hanno ridimensionato la propensione a chiedere finanziamenti». Sul no al prestito influiscono gli ostacoli della vita reale: cassa integrazione, famiglie monoreddito, contratti a tempo parziale. Le banche catalogano i «cattivi pagatori» e, in maniera indiretta, soprattutto al Sud, si alimenta il mercato illecito dell’usura. Secondo l’ultimo studio della Cgia di Mestre, la Campania sarebbe al primo posto in Italia per il ricorso agli usurai. Cresce la richiesta del piccolo prestito, trai mille e cinquemila euro a restituzioni da favola. Ma chi ha bisogno di denaro, anche per spese sanitarie non previste, non ha alternative. Soprattutto se non possiede garanzie da fornire alle banche. Dopo la Campania, ci sarebbero, nel ricorso all’usura, Calabria, Abruzzo, Puglia, Sicilia, Molise.
L’ultimo studio dell’Unioncamere, in collaborazione con Libera contro le mafie, lancia l’allarme. Vi si legge: «Un rapporto usurario nasce dalla necessità stringente di denaro, ma anche da un’offerta che può apparire di facile e rapida soluzione a chi si trova in difficoltà». Tassi d’interesse che schizzano dal 120 al 1500 per cento, accompagnati da metodi spicci per ottenere la restituzione del prestito. Confesercenti denuncia che circa 200mila commercianti hanno dovuto ricorrere all’usura. Al primo posto, anche stavolta, la Campania con 32mila commercianti. Racconta Giovanni, che ha dovuto chiudere un suo piccolo negozio di abbigliamento in provincia di Napoli, rimanendo per ora privo di lavoro: «Ero insolvente con più fornitori, che, sperando di recuperare i loro soldi, non mi facevano fallire. La banca non mi concedeva più prestiti, quando mi hanno presentato un’ingiunzione ho dovuto ricorrere agli usurai. Da lì è stata una spirale inarrestabile, che mi ha portato alla chiusura».
Secondo Eurispes, almeno il 35,7 per cento degli italiani ha chiesto nell’ultimo anno un prestito alle banche. Tra i più bisognosi di aiuti finanziari, i lavoratori con partite Iva (44,2 per cento) e il 35,2 lavoratori subordinati. La stessa analisi spiega la richiesta con la necessità di pagare debiti accumulati nel tempo (il 62,3 per cento) e il bisogno di saldare prestiti ricevuti da altre banche o da finanziarie (il 44,4 per cento). In tutti i casi, nella stretta del denaro che non basta mai e che le banche concedono sempre di meno, bene non siamo di certo messi. Speriamo che passi.
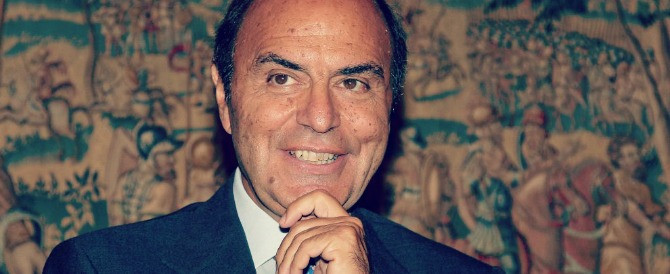
I compiti a casa dell’Italia
Redazione Edicola - Opinioni bruno vespa, deficit, europa, francia, francois hollande, germania, il mattino, Matteo Renzi
Bruno Vespa – Il Mattino
A scuola i primi della classe non sono mai stati troppo popolari, a meno di una visibile generosità nei confronti dei compagni. Angela Merkel non ha questa fama. Perciò la risposta piccata («Fate i compiti a casa») all’annuncio che la Francia sarebbe rientrata soltanto nel 2017 nel limite del 3 per cento tra deficit annuale e prodotto interno lordo non è stata gradevole. Non siamo sicuri peraltro che l’invito – apparentemente senza destinatario – non riguardasse anche l’Italia, che resta sotto il 3 per cento, ma non scende vicino al 2 come avrebbe dovuto e soprattutto ha rinviato al 2017 l’applicazione del pareggio di bilancio. (La lettera inviata dalla Banca centrale europea a Berlusconi il 5 agosto 2011 anticipava al 2013 questo vincolo previsto inizialmente per il 2014). A parte un debito pubblico elevatissimo (ma di cui abbiamo sempre pagato le rate degli interessi), l’Italia ha i conti più in ordine della Francia, a cominciare dall’avanzo di bilancio pubblico positivo, (più entrate che spese, al netto degli interessi) che la mette in testa alla classifica del G7 insieme proprio con la Germania. Sulla Francia pesa inoltre il tabù delle 35 ore, del tutto anacronistico nel mondo globalizzato, la mancata riduzione della spesa pubblica di 50 miliardi, un mercato del lavoro senza i vincoli del nostro articolo 18, ma complessivamente ancora ingessato.
Matteo Renzi ha subito espresso la propria solidarietà a Hollande ricordando di guidare il più votato partito europeo e di rispettare il vincolo del 3 per cento. Questa mossa lascia intendere che i due paesi nelle prossime settimane rammenteranno alla prima della classe che compiti a casa pesanti come quelli assegnati alle nazioni in difficoltà, se non svolti un poco alla volta, rischiano di ammazzare anche lo studente più volenteroso. (E l’Italia lo è più della Francia). Ma proprio perché ha il debito così alto, l’Italia deve presentarsi al confronto con i compiti fatti meglio della Francia, più forte di noi per ragioni storiche, politiche, strategiche e perché l’euro è nato da un accordo tra Mitterrand e Kohl per dimenticare il sangue procuratosi a vicenda negli ultimi due secoli.
Qui casca l’asino della riforma del lavoro. Per chetare la sinistra del suo partito, Renzi ha promesso che nel nuovo statuto del lavoro si potranno reintegrare, oltre ai lavoratori discriminati, anche quelli licenziati per ragioni `disciplinari’. Questa normativa può essere scritta in tanti modi diversi,da quella che non lascia margini interpretativi a quella che consente di vanificare l’intera riforma dell’articolo 18. Il Nuovo centrodestra ha già fatto sapere al presidente del Consiglio che su questo punto sarà inflessibile, anche perché sente il fiato sul collo di Forza Italia, a sua volta costretta ad irrigidirsi da una rivolta interna antigovernativa che va ben al di là del caso Fitto (basta leggere in controluce i franchi tiratori nelle elezioni alla Corte costituzionale). Se vuole presentarsi al vertice sul lavoro dell’8 ottobre con un testo non ancora votato, ma radicalmente diverso dal passato, Renzi sarà costretto stavolta ad ascoltare più Alfano che Bersani. Guai a sedersi al tavolo in cui ciascuno presenterà i compiti a casa con un tema scritto con calligrafia cattiva e incomprensibile.
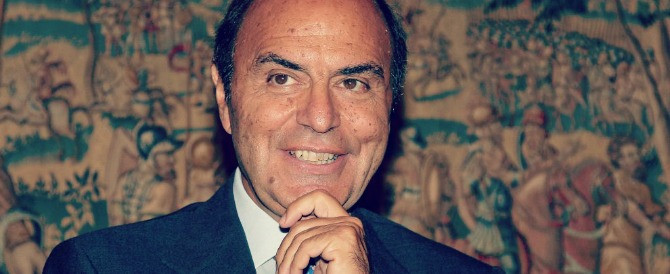
Cosa paralizza il Made in Italy
Redazione Edicola - Opinioni articolo 18, bruno vespa, economia, il mattino, lavoro, made in italy, susanna camusso
Bruno Vespa – Il Mattino
La mia generazione si è formata nella convinzione che il lavoro subordinato sarebbe durato dal giorno dell’assunzione a quello del pensionamento e per poi congedarsi «col massimo», cioè con un assegno sostanzialmente equivalente all’ultimo stipendio. Nessuno pensava che il mondo sarebbe radicalmente cambiato e che anche in Italia si sarebbe dovuto affrontare un giorno il mutamento epocale, altrove avvenuto da tempo: si potrà essere licenziati con la garanzia che lo Stato si impegna a fornire un forte paracadute. E ad attivare efficienti meccanismi di assistenza e di formazione in modo che chi ha perso il lavoro abbia modo di trovarne un altro. È quanto è avvenuto in Germania dove nel 2003 la disoccupazione era maggiore dell’Italia e ora è la metà, i redditi sono più alti e l’economia è la più forte d’Europa.
Abbiamo perduto dodici anni da quando Silvio Berlusconi stipulò il 4 luglio 2002 un Patto per l’Italia con Cisl e Uil per fare qualcosa di simile, ma fu sconfitto sul campo dalla Cgil. E ne sono trascorsi quindici da quando ci provò Massimo D’Alema: sia pure con minor clamore fece la stessa fine. La condizione di paralisi in cui si trova l’economia italiana ha indotto Matteo Renzi a giocare la carta proibita: salvo ripensamenti dell’ultima ora, lunedì prossimo la direzione del Pd approverà la cornice della legge delega con la previsione di sostituire il reintegro per i nuovi assunti di qualunque età che fossero un giorno licenziati con un adeguato risarcimento economico e con tutti gli ammortizzatori sociali necessari. «Il mio impegno è chiaro», ha detto il premier al Wall Street Journal. «Realizzare le riforme indipendentemente dalle reazioni».
Le reazioni della Cgil e della minoranza del Pd saranno forti. Per la prima volta mercoledì a «Porta a porta» Susanna Camusso ha aperto alla possibilità che per un ridotto numero di anni i nuovi assunti possano rinunciare all’articolo 18, mettendosi sulla scia della minoranza democratica. Una svolta a suo modo epocale, ma insufficiente a far arretrare il presidente del Consiglio. Il richiamo di ieri della Conferenza episcopale italiana («Bisogna guardare con più realismo alle persone che non hanno lavoro e che cercano lavoro») invitando ad ammainare la bandiere sventolate intorno all’articolo 18 può essere interpretato come un freno a Renzi e quasi come un contraltare all’incoraggiamento che gli viene invece dal capo dello Stato. Ma è un contraltare ambiguo: qual è il modo migliore di preoccuparsi della sorte dei disoccupati? Blindare gli occupati del futuro al punto che restino senza lavoro nel presente?
Ha ragione la Camusso quando dice che l’articolo 18 è lo scalpo che Renzi deve portare al vertice europeo dell’8 ottobre. Sono fondate le preoccupazioni della minoranza Pd a proposito dei soldi che servono per finanziare nuovi e adeguati ammortizzatori sociali. Ma se è vero che la nostra legislazione sul lavoro è la più paralizzante in tutti i 35 paesi dell’Ocse, occorre renderla «normale». È essenziale, al tempo stesso, che Renzi si faccia pagare lo «scalpo» con una immediata flessibilità che gli consenta non solo di prevedere già nella legge di stabilità i nuovi ammortizzatori sociali, ma gli dia modo di distribuire soldi alle fasce meno protette e di ridurre ulteriormente l’Irap alle imprese. Bisogna insomma attivare un circuito virtuoso di cui la rimozione dell’articolo 18 per i nuovi assunti sia soltanto l’ingranaggio iniziale di un meccanismo del tutto nuovo e assai più efficiente della giungla attuale.
