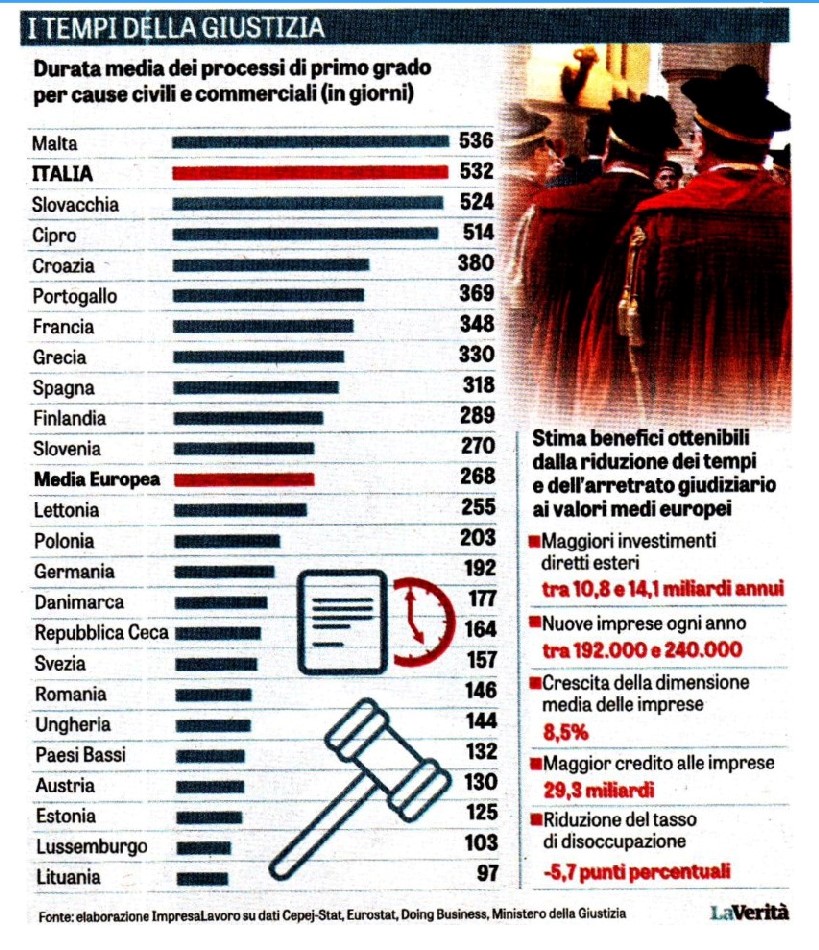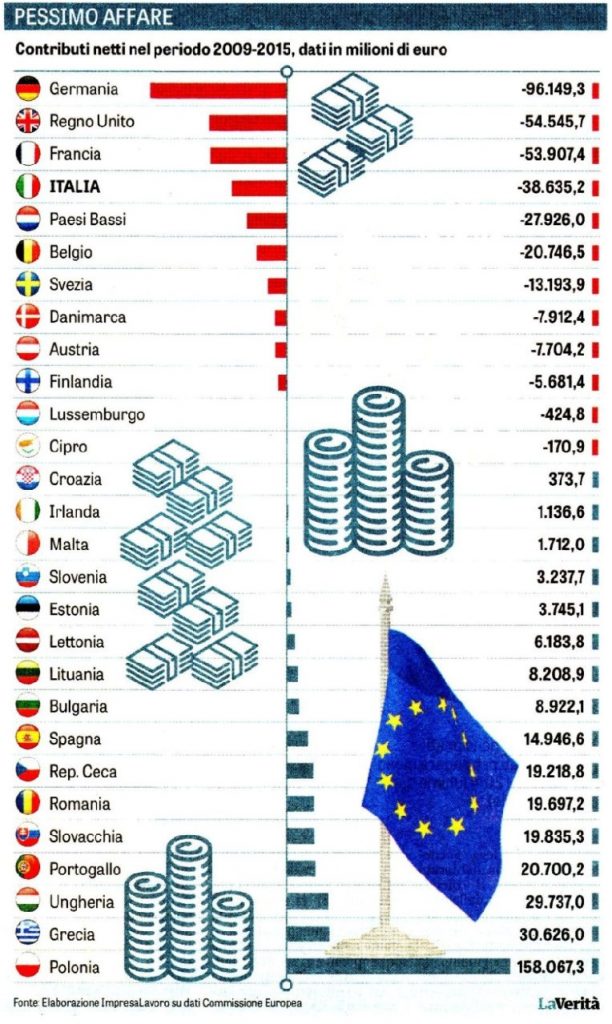In Italia gli stranieri trovano lavoro più di noi
La Verità
I cittadini stranieri collocati, sul mercato del lavoro, di più e meglio rispetto agli autoctoni: uno scenario bizzarro, che tuttavia è realtà in una manciata di nazioni europee. L’Italia è una di esse. Secondo una ricerca realizzata dal Centro Studi ImpresaLavoro – su elaborazione dei dati Eurostat 2016 – il tasso di occupazione dei cittadini italiani tra i 15 e i 64 anni (residenti in patria) è del 57,0%, dato che ci appaia alla Croazia e che risulta nettamente inferiore alla media sia dell’Unione a 28 membri (67,1%) sia dell’area Euro (66,1%). In tutto il Vecchio Continente soltanto la Grecia – con il 52% degli occupati – ha un mercato del lavoro meno efficiente del nostro. In questa particolare classifica siamo quindi nettamente superati da tutti i nostri principali competitor: Svizzera (82,5%), Germania (76,5%), Olanda (75,6%), Regno Unito (73,8%), Portogallo (65,3%), Francia (65,2%), Irlanda (64,7%) e Spagna (59,9%).
Se si prende in considerazione la percentuale di occupati tra i lavoratori extra-Ue residenti in Italia, la posizione in classifica del nostro Paese vola invece verso l’alto, dal penultimo al sedicesimo posto: il nostro 57,8% risulta infatti largamente superiore alla media sia dell’Unione a 28 membri (53,7%) sia dell’area Euro (52,5%). Si tratta di un dato in netta controtendenza rispetto a quanto avviene abitualmente negli altri Paesi e soprattutto nelle altre economie avanzate del continente. Oltre all’Italia, solo altri tre Paesi europei hanno tassi di occupazione più bassi tra i propri connazionali rispetto a quelli fatti registrare tra i lavoratori extracomunitari: si tratta di Repubblica Ceca (-3,8 punti percentuali), Slovenia (-0,9) e Grecia (-0,3).
Un dato che stride con la media sia dell’Unione a 28 membri (+13,4 punti percentuali) sia dell’area Euro (+13,6). In tutto il resto d’Europa la differenza, espressa sempre in punti percentuali, risulta infatti a favore dei cittadini dei Paesi presi in esame: Portogallo (+1,0), Spagna (+6,2), Irlanda (+7,2), Regno Unito (+12,5), Svizzera (+17,8), Francia (+20,9), Germania (+24,8) e Olanda (+26,3).
«Ancora una volta siamo costretti a osservare l’Italia in fondo alla classifica europea che registra il tasso di occupazione dei cittadini di ciascun Paese», commenta l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «Si tratta di un dato ormai stabile, che non può non allarmare una grande potenza economico-industriale come la nostra. Mentre nel resto d’Europa la crisi sembra essere in via di superamento, da noi la crescita continua a ristagnare ai livelli di 10 anni fa. Anche per questo non può che sorprendere il fatto che in Italia i residenti extracomunitari trovino lavoro con maggiore facilità dei nostri connazionali. È pur vero che si tratta di un’anomalia dovuta al fatto che i primi sono disponibili a svolgere mansioni che gli italiani ormai riliutano di prendere in considerazione. Questo però non può essere una giustificazione sufficiente: il nostro mercato del lavoro resta ancora troppo rigido».