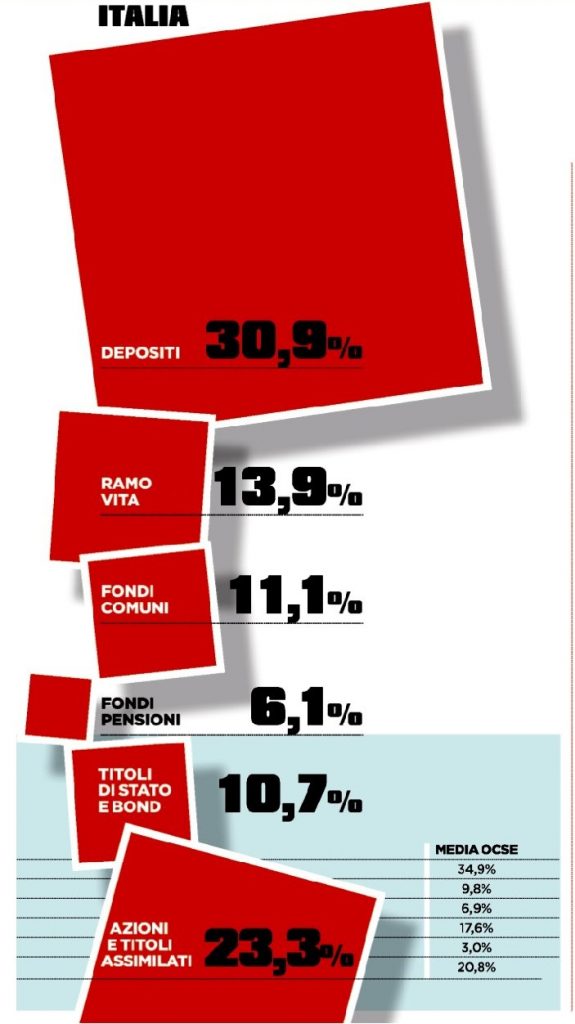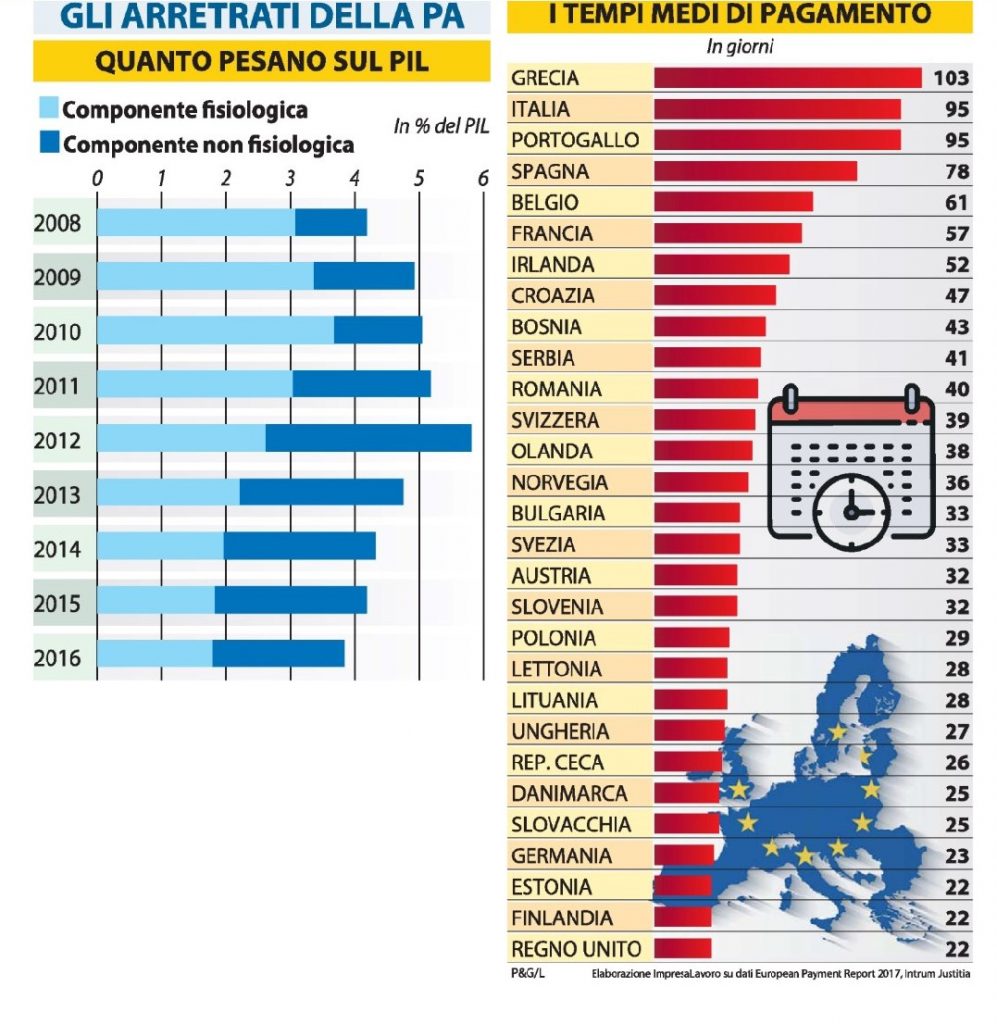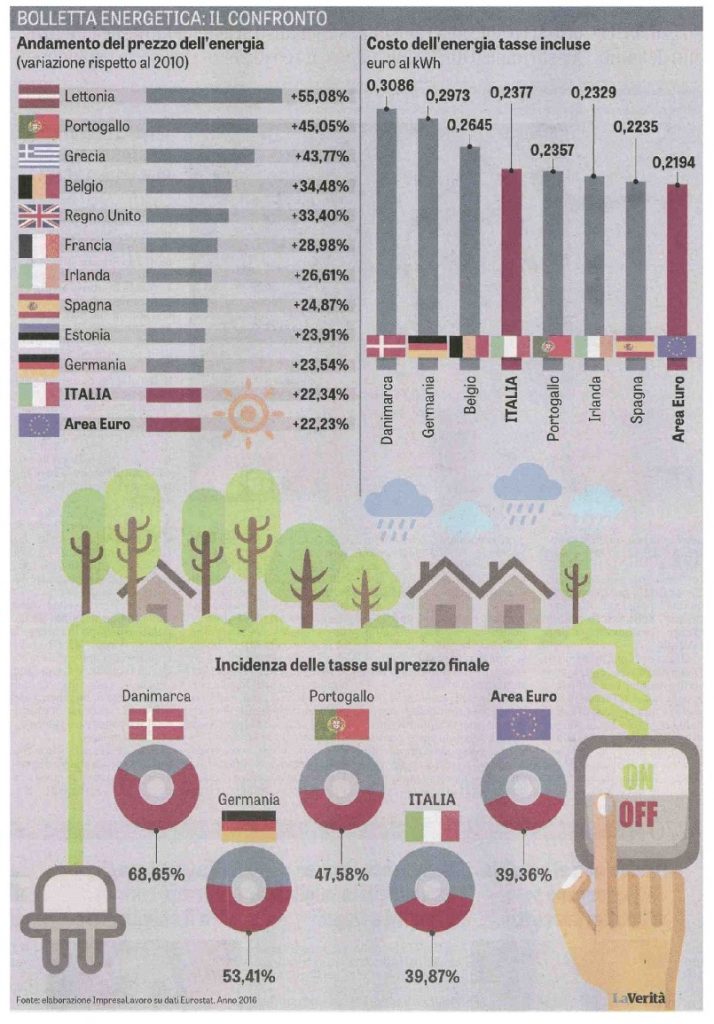Le Regioni che spendono di più
di Vittorio Pezzuto – Italia Oggi
Restano tuttora vistose le differenze nella spesa pubblica pro capite sostenuta nelle singole regioni italiane. Valutando la media degli ultimi tre anni disponibili (dal 2012 al 2014) si scorge infatti quasi un abisso tra gli 8.647 euro annui pro capite spesi in Lombardia e i 15mila spesi in Valle d’Aosta o gli oltre 13mila spesi nel Lazio. Lo sottolinea il Centro studi ImpresaLavoro, che ha rielaborato i dati contenuti nel rapporto annuale in cui la Ragioneria Generale dello Stato analizza la dimensione e l’andamento della spesa consolidata nelle regioni italiane.
Occorre precisare che il perimetro considerato nella costruzione di questi dati non coincide con le competenze di queste ultime ma si allarga a ogni importo sostenuto nelle singole regioni da qualsivoglia organismo pubblico: tiene insomma conto delle spese dello Stato (ad esempio quelle relative al pagamento delle pensioni, degli ammortizzatori sociali o gli oneri relativi alla sicurezza o al controllo dei confini), della Regione, degli altri enti locali e di ogni fondo alimentato con risorse nazionali o comunitarie. A restare esclusi dal calcolo sono invece gli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico.
Osservando la classifica stilata da ImpresaLavoro, la regione con la spesa pubblica pro-capite più elevata risulta così essere la Valle d’Aosta, con 15.731 euro all’anno. Seguono il Lazio con 13.684 euro, il Trentino Alto Adige con 13.278 euro e il Friuli Venezia Giulia con 12.975 euro. In coda si collocano le regioni più grandi: la Lombardia è ultima per spesa pubblica pro-capite (8.647 euro), preceduta dal Veneto (8.734 euro) e dalla Campania (9.082 euro). La classifica cambia se si raffronta la spesa pubblica al Prodotto Interno Lordo che ogni singola regione produce. In questo caso le regioni con percentuale di spesa pubblica più elevata rispetto al Pil risultano la Calabria (66,15%), la Sardegna (59,9%) e la Sicilia (56,55%). In coda alla graduatoria troviamo invece le regioni più ricche del Nord: la Lombardia (dove la spesa pubblica pesa per meno del 25%), il Veneto (29%) e l’Emilia Romagna (30%).
«L’enorme differenza della quantità di spesa tra regioni non è semplicisticamente riconducibile alla loro collocazione geografica: si spende tanto al nord quanto al sud. Va però considerata la sua qualità» osserva Massimo Blasoni, imprenditore e presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «Prendiamo ad esempio la sanità. Il livello dei servizi resi in Lombardia è nettamente migliore di quello calabrese anche se il costo pro capite è di poco superiore; per l’Istat di soli 130 euro annuali a cittadino: un’inezia. È solo un esempio che riafferma però un concetto ineludibile. Si tratta di spendere di meno ma anche e soprattutto di spendere meglio. Dal trasporto pubblico ai servizi postali troppo spesso i nostri servizi pubblici sono lontani dagli standard che ci potremmo aspettare visto il loro costo, condizionati come sono da inefficienze ed eccesso di intermediazione politica. Un esempio? Nell’area di Napoli, forse la peggio servita quanto a raccolta e smaltimento rifiuti, si paga una delle tasse sui rifiuti più alte d’Italia. Anche i costi della politica non sono uguali per tutti. Agli oltre 42 euro pro capite per il funzionamento degli organi istituzionali della Sardegna o ai quasi 32 euro della Sicilia fanno da contraltare Piemonte ed Emilia Romagna che si attestano attorno ai 5 euro annui».