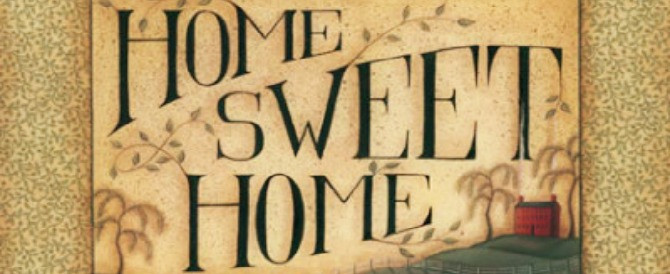Gli statali si ammalano di più, il lunedì il giorno preferito
di Filippo Caleri – Il Tempo
Statali più cagionevoli di salute. Forse perché il loro posto di lavoro è più sicuro rispetto al privato. Dove infatti ci si ammala di meno nel corso dell’anno. In ogni caso in entrambi i settori se proprio si deve stare a casa con il termometro sul comodino si preferisce il lunedì. Il primo giorno della settimana è scelto per comunicare la malattia al datore di lavoro nel 30% dei casi. I dati sono stati elaborati dall’osservatorio statistico dell’Inps che ha contabilizzato tutte le giornate di malattia nel 2014 sia nel pubblico sia nel privato. In tutto si tratta di oltre 109 milioni di giorni (77.195.793 giornate nel privato e 31.525.329 nella pubblica amministrazione). La conferma della fragilità della salute dei ministeriali è confermata anche nei dati percentuali. L’Istituto guidato da Tito Boeri ha registrato lo scorso anno un aumento dello 0,8% (6.031.362) dei certificati di malattia presentati dai lavoratori pubblici e un calo del 3,2% (11.494.805) di quelli dei dipendenti privati.
A confermare che la salute è più debole tra i dipendenti pubblici si è aggiunto ieri il Centro Studi ImpresaLavoro, che ha rielaborato i dati Inps, giungendo alla conclusione che i circa 3,2 milioni di dipendenti pubblici si ammalano in media quasi il doppio delle volte rispetto ai circa 14 milioni di dipendenti privati registrati presso l’Inps. La base di calcolo sono stati i 71,5 milioni di certificati che dal 2010 (anno della riforma che impone l’invio via web della malattia da parte dei medici di famiglia) sono arrivati all’Istituto di previdenza: 2,6 milioni nel 2010 (periodo in cui il sistema telematico non era ancora entrato a regime), 16,4 milioni nel 2011, 17,2 milioni nel 2012, 17,8 milioni nel 2013 e 17,5 milioni nel 2014. Ebbene dal 2011 al 2014 le giornate di malattia nel settore privato sono state circa 312 milioni 134 mila, mantenendosi stabili ogni anno dopo aver registrato un calo iniziale di 2,4 milioni dal 2011 al 2012 (79,8 milioni nel 2011, 77,4 milioni nel 2012, 77,6 nel 2013 e 77,1 milioni nel 2014). Nello stesso periodo di tempo sono invece costantemente aumentate le giornate di malattia nel settore pubblico, per un totale di oltre 116 milioni 770 mila (25,8 milioni nel 2011, 28,5 milioni nel 2012, 30,7 milioni nel 2013 e 31,5 milioni nel 2014).
L’Inps osserva pure che i lavoratori con almeno un episodio di malattia sono per la maggior parte maschi (56,l%) nel privato e femmine (69%) nella Pubblica amministrazione. E per quanto riguarda poi il numero di assenze per malattia, nel pubblico risultano esser doppie rispetto al privato: i 3 milioni di lavoratori della Pubblica amministrazione, infatti, hanno fatto in media 10,5 giorni di malattia mentre i 13,6 milioni di dipendenti del settore privato sono stati malati in media per 5,67 giorni.