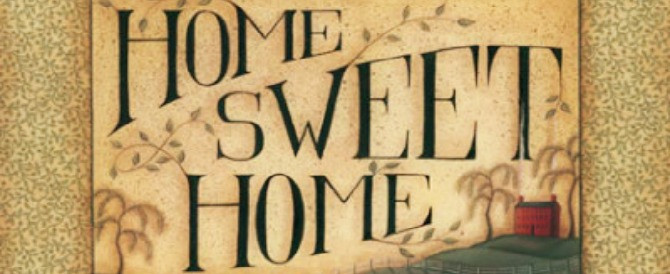In Italia il problema non è aver fatto austerity, ma aver fatto l’austerity peggiore d’Europa
Luciano Capone – Il Foglio.it
Nei giorni di SwissLeaks e della diffusione dei dati bancari della sede ginevrina della Hsbc sottratti dal dipendente infedele Hervé Falciani, si ha la sensazione che la Svizzera sia un “paradiso fiscale”, il più grande paradiso fiscale d’Europa. L’idea trova conferma nell’“Indice della libertà fiscale in Europa” realizzato dal centro studi di ispirazione liberale ImpresaLavoro, che verrà diffuso nei prossimi giorni e che il Foglio ha potuto vedere in anteprima. L’indice analizza i sistemi fiscali di 10 paesi europei (Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lituania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Svizzera) che vengono valutati su una scala in centesimi sulla base di quattro parametri utilizzando i dati confrontabili di Eurostat e della Banca mondiale: struttura e peso della tassazione rispetto al pil, Implicit tax rate sul reddito da lavoro, capitale e consumo, complessità fiscale e livello di decentramento fiscale. Se nella classifica che va da 0 a 100 è la Svizzera ad essere il “paradiso fiscale” europeo con un punteggio di 76 (forte di una pressione fiscale al 28 per cento, di un sistema semplificato e decentralizzato), l’”inferno fiscale” dista pochi chilometri, ci si arriva con l’autostrada del San Gottardo, è proprio l’Italia che ha un punteggio di 42, uno in meno della Francia.