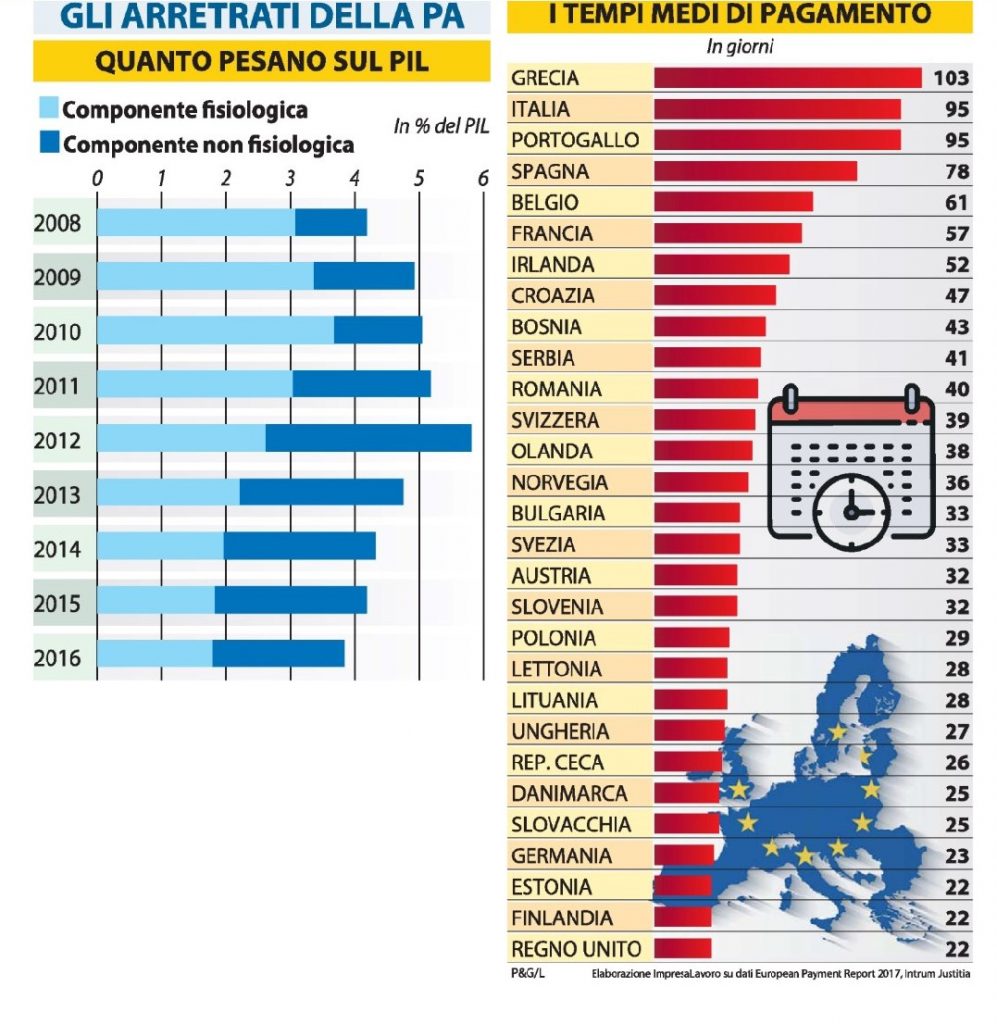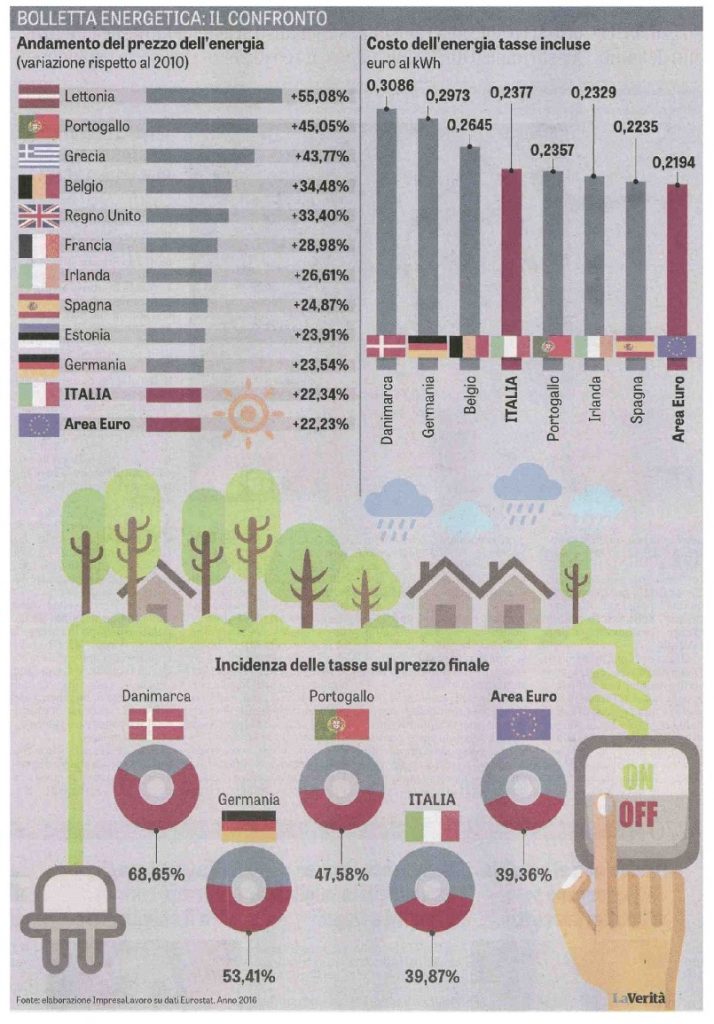Domani si versa l’acconto Imu-Tasi. Nel 2016 tasse sugli immobili a 49,1 miliardi (+30,2% rispetto al 2011)
Domani circa 25 milioni di italiani saranno chiamati a versare l’acconto dell’Imu e della Tasi. Nonostante l’abolizione delle tasse sulla prima casa, resta infatti ancora in vigore il prelievo sulle seconde case e sugli immobili diversi dall’abitazione principale.
Dopo il livello record raggiunto nel 2015 (52,3 miliardi di euro), in Italia il gettito complessivo sugli immobili si è ridotto nel 2016 a 49,1 miliardi di euro (-6,1%). L’anno scorso la pressione fiscale ha toccato comunque valori decisamente più consistenti di quelli registrati nel 2011, con un incremento di 11,4 miliardi di euro su base annua (+30,2%). Lo rileva una ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro su elaborazione di dati della Corte dei Conti e di Confcommercio.
Nel periodo 2011-2016 il maggiore incremento registrato ha riguardato la quota patrimoniale del prelievo – più che raddoppiata (+173%) – a differenza delle entrate attribuibili agli atti di trasferimento (-29%) e a quelle sul reddito immobiliare, rimaste sostanzialmente inalterate nonostante la crescita del gettito da locazioni favorita dall’introduzione della cedolare secca sugli affitti.
Il calo di 3,5 miliardi di euro registrato tra il 2015 e il 2016 è interamente attribuibile al taglio della TASI per le abitazioni principali licenziato dal governo nella Legge di stabilità e che ha fatto passare il gettito della misura da 4,7 a 1,1 miliardi di euro. Le entrate derivanti dall’IMU restano invece stabili a 20,4 miliardi su base anna: la componente esplicitamente patrimoniale dell’imposizione sugli immobili è comunque più che raddoppiata rispetto al 2011 quando valeva “solo” 9,2 miliardi di euro. In crescita rispetto a cinque anni or sono risulta in crescita anche il gettito derivante dalle tasse sui rifiuti, che sono passate da 5,6 a 8,4 miliardi di euro.
«Nonostante l’abolizione della Tasi sulla prima casa – osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro Studi ImpresaLavoro – la tassazione sugli immobili nel nostro Paese continua ad essere del 30% più elevata rispetto al 2011. Si tratta di una patrimoniale operata a danno di quello che molte famiglie consideravano un vero e proprio bene rifugio. Una misura che ci venne richiesta a gran voce dall’Europa e che ha prodotto effetti negativi su molti versanti: un impoverimento del patrimonio delle famiglie, la messa in ginocchio del settore dell’edilizia e una depressione dei consumi e della domanda interna. Motivi più che sufficienti per rispedire al mittente le raccomandazioni del Fondo monetario internazionale, che in questi giorni insiste per un aggravio in Italia della tassazione patrimoniale degli immobili».