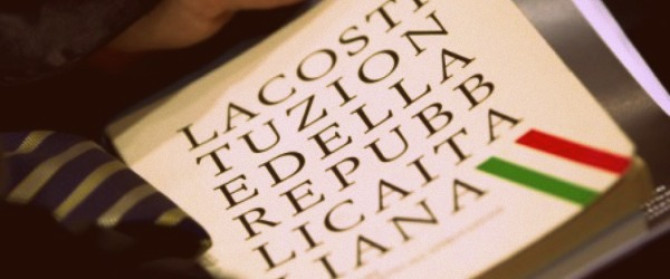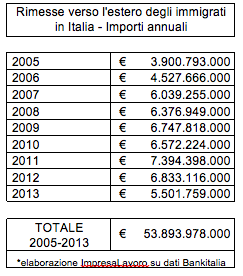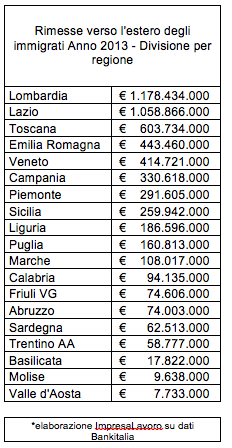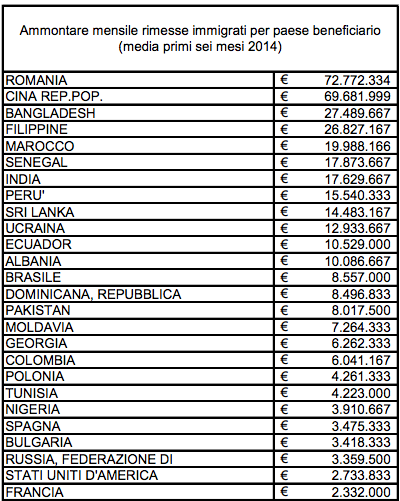Quanto ci costa la fuga di quei ragazzi che abbiamo formato
Gianna Fregonara – Corriere della Sera
È come se l’intera città di Alessandria o se tutta Lecce si fossero trasferite all’estero nel corso del 2013. Sono partiti quasi in centomila. Non è solo segno di una crescente mobilità degli italiani: sono soprattutto le regioni del Nord, con la Lombardia in testa, e il Lazio quelle da cui se ne vanno i nostri connazionali, che in maggioranza peraltro si spostano dentro i confini dell’Europa: Gran Bretagna, Germania e Svizzera.
Scorrendo i dati e l’identikit che «Migrantes» ha fatto del nuovi emigrati italiani risulta che si tratta soprattutto di giovani (circa 35 mila hanno tra i 18 e i 24 anni), con diploma di scuola superiore o laurea. Due su tre sono diretti in Inghilterra, chi per studiare, chi per lavorare e insieme imparare l’inglese, chi per restare. Si sa che con il 44,2 per cento di disoccupazione giovanile accertato e con il miraggio di uno stipendio più alto all’estero dove la laurea – dati dell’Isfol – può valere fino al 50 per cento di retribuzione in più, la spinta all’emigrazione aumenta. E del resto se si considera la tendenza degli ultimi anni, i dati non sono così stupefacenti: nel 2012 era partito il 30 per cento in più dell’anno prima. Tra i nuovi emigrati di questi anni ci sono sempre di più ricercatori, studenti, talenti vari, «cervelli» in cerca di occupazione.
Il vero problema diventa che molti, forse quasi tutti, non riescono più a rientrare in Italia o non lo trovano conveniente, e finora i tentativi di richiamarli con sconti fiscali e opportunità varie non hanno funzionato a sufficienza. Ma crescere un cittadino educato e col diploma costa, contando i tredici anni di scuola dalle elementari alle superiori, circa 130 mila euro. E il conto presentato ieri da «Migrantes» così non torna.