
Editoriali


Digital Tax? Per favore no
Redazione », Editoriali, Scrivono di noi digital tax, editoriale, impresalavoro, massimo blasoni, metro
di Massimo Blasoni – Metro
Questo governo continua ad aumentare le tasse sostenendo di averle diminuite. E non ancora soddisfatto, nei giorni scorsi ha annunciato in tempi brevi una Digital Tax in grado di colpire l’elusione fiscale dei giganti della Rete. Al di là delle polemiche politiche (quando governava Letta lo stesso Renzi bocciò una proposta identica, che però aveva il difetto di chiamarsi Web Tax), resta il fatto che il suo costo verrà subito fatto ricadere dalle aziende sui consumatori italiani, contribuendo così a deprimere ulteriormente un settore che da noi stenta a decollare.
Continua a leggere su Metro

Ridurre la spesa si può: chiedete a Maroni
Redazione », Editoriali, Scrivono di noi editoriale, massimo blasoni, panorama, spesa, tasse
Massimo Blasoni – Panorama
Nei primi anni Settanta il peso di tasse e imposte sul Pil italiano non arrivava al 25%. Oggi supera il 50% in termini reali. È necessaria una significativa riduzione di questo carico che grava sui consumi degli italiani e frena la possibilità di fare impresa e di attirare investimenti esteri. Ciò è possibile solo a patto di comprimere il perimetro di attività dello Stato: Regioni, Province e Comuni hanno moltissimo,incrementando costantemente costi e attività svolte anche quando, con vantaggio, potevano essere lasciate al mercato. Oggi si ipotizza di abolire la Tasi, ma ogni annuncio di minori tasse che non parta da una precisa elencazione delle spese che si vogliono tagliare, rischia di risultare poi disatteso. Ovvero di produrre nuove imposte in luogo di quelle abolite: è già successo.
Nelle intenzioni del Governo il minor gettito derivante dall’abolizione della tassa sulla prima casa e altro dovrebbe essere compensato da tagli per almeno 10 miliardi di euro. Operazione non facile se pensiamo che negli ultimi anni la spesa è sempre cresciuta malgrado tutti i propositi di razionalizzarla. I dati del DEF sono impietosi: nel 2012 la spesa corrente al netto degli interessi sul debito era pari a più di 671 miliardi, cresciuti nel 2013 a 684 e poi a 692,3 miliardi nel 2014. Non è ovunque così, tanto che il governo di David Cameron in Inghilterra è riuscito a ridurre tra il 2010 e il 2013 la spesa di quasi 50 miliardi e oggi l’economia britannica, nonostante sia stata colpita da una crisi finanziaria più grave di quella che investito l’Italia, cresce tra il 2 e il 3% annui. In Italia invece, diversamente dagli altri partner europei, si riduce la spesa per investimenti anziché quella corrente. Lo Stato ha tagliato tra il 2009 e il 2013 15,9 miliardi di euro di investimenti – dato Eurostat – ma malgrado ciò la spesa complessiva è salita.
Quanto a incremento di spesa corrente negli ultimi anni, meritano un richiamo le Regioni. Dai dati resi noti dalla Corte dei Conti sui flussi di cassa necessari a sostenere la loro spesa, si rileva che dal 2011 al 2014, in pieno periodo di spending review, questa è cresciuta da 141,7 a 145,6 miliardi. Non tutte le Regioni si comportano ugualmente, però. Nello stesso arco temporale la virtuosa Lombardia ha ridotto del 11,6% le proprie spese, mentre il Lazio le ha accresciute del 33%. In termini assoluti per ogni cittadino la Lombardia spende 1.739 euro, poco più della metà del Lazio, la Regione che, con i suoi 3.129 euro di spesa corrente procapite, fa segnare l’esborso più alto tra tutte quelle a statuto ordinario. Questa rilevante differenza, a parità di competenze, fa riflettere e, se proiettata a livello nazionale, ci convince ancor di più che ridurre la spesa pubblica è possibile. In questo caso la Lombardia insegna.

Tasse e burocrazia, l’Italia soffoca le imprese
Redazione », Editoriali, Scrivono di noi burocrazia, editoriale, il giornale, imprese, massimo blasoni, tasse
Massimo Blasoni – Il Giornale
Il dibattito politico viene da mesi monopolizzato da numeri, percentuali, tendenze del Pil e andamento dell’occupazione. Cresciamo dello 0,7%, l’inflazione cresce dello 0,2%: si ha spesso l’impressione di parlare di qualcosa di etereo e poco concreto. Le tasse, la burocrazia, le difficoltà di accesso al credito sono invece aspetti quotidiani e molto concreti con cui le imprese si confrontano ogni giorno.
La difficoltà di fare impresa in Italia è evidente dal confronto con gli altri partner europei: ipotizziamo una sfida Italia-Inghilterra. Prendiamo due aziende manifatturiere che producono esattamente la stessa cosa. Una ha sede nell’hinterland milanese e l’altra nella periferia di Londra. Partiamo da uno dei principali fattori produttivi: il lavoro. Anche lasciando da parte per un attimo i difficili rapporti sindacali, il tasso di assenteismo e di sciopero, lo scarso aiuto che i servizi pubblici di collocamento offrono alle imprese ci rendiamo subito conto che il costo che le due aziende sostengono per retribuire i propri dipendenti penalizza nettamente l’impresa italiana. Questa avrà, secondo i dati Eurostat, un costo medio orario di 28,3 euro, contro i 22,3 euro dell’azienda inglese. Purtroppo i nostri lavoratori non sono pagati meglio, piuttosto subiscono un cuneo fiscale (tasse e contributi) che pesa per il 44,9% in Italia e per il 26,8% in Inghilterra.
Non va meglio se guardiamo ai costi dell’energia. Una media impresa italiana paga le proprie forniture energetiche il 30% in più di un’azienda britannica evidenziando tutti gli errori di prospettiva che si sono commessi negli ultimi vent’anni in materia, dall’aprioristico rifiuto del nucleare ai cronici ritardi infrastrutturali.
La burocrazia rende il divario ancora maggiore. Per costruire un nuovo capannone l’imprenditore italiano attenderà 233 giorni per ricevere dalle autorità competenti il permesso di costruzione. L’imprenditore londinese avrà già iniziato a far lavorare l’impresa edile da ben 4 mesi, dovendo aspettare 105 giorni, meno della metà. E a Londra si attende meno della metà anche per l’esito di una causa in sede civile: 407 giorni contro i 1.185 giorni necessari per i nostri tre gradi di giudizio. I dati sono tutti tratti dal rapporto annuale della Banca Mondiale.
Se poi la nostra impresa si trova nella sfortunata condizione di essere fornitrice di una Pubblica Amministrazione dovrà sopportare un’attesa media di 144 giorni. Un tempo sei volte superiore a quello medio nel Regno Unito, dove con 24 giorni trascorsi tra l’emissione della fattura e il pagamento il settore pubblico si dimostra addirittura più celere di quanto richiesto dalla direttiva comunitaria in materia. Questi ritardi nei pagamenti hanno un costo assai rilevante per le nostre imprese: i crediti vanno anticipati presso il sistema bancario e il nostro sistema creditizio è tra i più costosi d’Europa.
Infine ci sono le tasse. Al cuneo fiscale cui si è accennato poco sopra vanno aggiunte le tasse sugli utili d’impresa, con un Total Tax Rate –lo dice sempre la Banca Mondiale – che raggiunge nel nostro paese il livello record del 65.4% dei profitti. Più di 30 punti percentuali sopra il Tax Rate dei sudditi di Sua Maestà che si ferma al 33,7%. Non basta: per noi è anche difficile essere in regola con il fisco. Una media impresa britannica impiega ogni anno 110 ore per gli otto appuntamenti fiscali previsti dal governo. In Italia la cifra raddoppia: 15 pagamenti ogni anno per un impiego di 269 ore e un costo per l’azienda di 7.600 euro. Una specie di tassa sulle tasse.
Un solo accenno alla spesa pubblica, che indirettamente molto incide sulla vita delle aziende. L’esecutivo di David Cameron, dal 2010 al 2013, ha tagliando 2,6 punti percentuali di Pil di spesa facendo scendere i costi statali dal 47% al 44,4%. Una sforbiciata che vale in termini reali 57 miliardi. Nello stesso periodo, nonostante i molti annunci di spending review e i tanti Commissari per la revisione della spesa, l’Italia ha visto crescere la spese pubblica. Ovviamente finanziandosi con le sempre crescenti tasse di cittadini e imprese.
Davanti a questi numeri è davvero difficile stupirsi nel vedere il Pil del Regno Unito crescere del 2,6% su base annua e non capire perché è davvero difficile fare impresa in Italia. Un ultima considerazione. Abbiamo evitato di confrontare la difficoltà del nostro imprenditore dell’hinterland milanese con quelle di un imprenditore bavarese: il confronto sarebbe diventato davvero impietoso.
Massimo Blasoni
Imprenditore, Presidente Centro Studi ImpresaLavoro

Sono diritti o privilegi?
Redazione », Editoriali carlo lottieri, diritti acquisiti, editoriali, pensioni
di Carlo Lottieri
Quando si tenta di riformare in senso liberale le istituzioni, in Italia come altrove, spesso ci si scontra con l’idea che una serie di cambiamenti verrebbero a ledere diritti acquisiti. Quei cambiamenti sarebbero, per tale motivo, illegittimi e andrebbero rigettati.
In tutto questo c’è qualcosa di illogico e anche linguisticamente discutibile. I diritti individuali non sono “acquisibili”, perché sono in realtà originari o, come si dice con una terminologia classica, “naturali”. Ogni uomo ha un diritto naturale su di sé e per questo motivo la schiavitù è ingiusta. Per lo stesso motivo ognuno ha diritto a essere proprietario. Di cosa? Ecco: qui entra in campo la titolarità, perché ognuno ha diritto a essere proprietario di quei titoli che ha acquisito in maniera legittima grazie a doni, scambi, retribuzioni, ecc.
I diritti sono insomma connaturati all’uomo, mentre i titoli si acquisiscono. E come si acquisiscono, ovviamente, si possono perdere. Io sono proprietario di una casa (ho un titolo legittimo su di essa) e ovviamente perdo tale titolo nel momento in cui la dono o la vendo. A rigore, allora, non vi sono diritti acquisiti, ma solo titoli. Ed esattamente di titoli che si parla quando – nel linguaggio corrente – si vuole impedire questa o quella riforma.
Un caso classico è quello dei prepensionati o dei vitalizi d’oro assicurati agli uomini politici. In un caso come nell’altro non è di diritti in senso proprio che si parla (non stiamo parlando di prerogative che spettino a ogni uomo in quanto uomo), ma appunto di titoli: e per giunta di titoli ottenuti non in virtù di scambi o contratti tra privati, ma grazie a decisioni politiche del tutto arbitrarie.
In altre parole, se compro un’abitazione ho un titolo di proprietà forte su di essa, quale risultato di un negozio tra privati. Se invece ricevo una pensione di 4 mila euro al mese perché per cinque anni sono stato consigliere regionale, in questo caso è diverso: un atto di volontà politica mi ha attribuito un privilegio o una facoltà. In altre parole, ho la possibilità di esigere ogni mese che ognuno dei miei concittadini destini a me – ad esempio – un centesimo di quanto produce in modo tale che io possa godere di questo vitalizio.
Ho un diritto a tutto ciò? No. Non c’è alcun diritto in gioco.
Ho un titolo che è stato “costruito” politicamente a mio favore. E che ovviamente può essere cancellato da un altro atto politico di segno opposto: dalla decisione, ad esempio, di abolire questi privilegi che i politici si sono auto attribuiti (nel caso dei vitalizi post-elezione) o che hanno attribuito ad altri (nel caso delle pensioni-baby).
Detto questo è egualmente chiaro che non si può mettere esattamente sullo stesso piano molte modeste baby-pensioni e i super-assegni che i politici hanno deciso mensilmente di regalarsi. Per giunta molti tra di coloro che sono andati in pensione prima dei quarant’anni oggi non sono più in condizione di lavorare. Per tale motivo, negare loro la pensione che ricevono significa togliere a queste persone ogni mezzo di assistenza, dopo aver assicurato loro – con un privilegio definito per via legislativa – che avrebbero ricevuto quella pensione vita natural durante.
Sul piano politico la situazione è caotica, socialmente delicata, e non è facile trovare una via d’uscita. Ma stiamo parlando di titoli ottenuti politicamente, insomma: di privilegi, e non già di diritti acquisiti. Sapere che le cose stanno in questi può quanto meno aiutare a mettere la discussione sui giusti binari.

Troppe imprese ancora falliscono
Redazione », Editoriali, Scrivono di noi editoriali, fallimenti, imprese, massimo blasoni, metro
Massimo Blasoni – Metro
La scorsa settimana, a Cernobbio per il Forum Ambrosetti, il premier Matteo Renzi ha esibito un grande ottimismo sulla capacità di ripresa economica del nostro Paese. Vorremmo davvero potergli credere, per il bene di tutti. I numeri che raccontano la crisi di questi anni dipingono però una situazione che rimane di grande incertezza. Prendiamo ad esempio i dati più aggiornati sui fallimenti delle aziende: il nostro Paese resta uno dei pochi che continua ad registrare un fenomeno nettamente superiore ai livelli pre-crisi. Una nostra rielaborazione dei dati forniti dall’OCSE evidenzia infatti come rispetto al 2009 i fallimenti nella nostra penisola siano cresciuti del 66,3%, passando dai 9.383 del 2009 ai 15.605 del 2014.
Continua a leggere su Metro
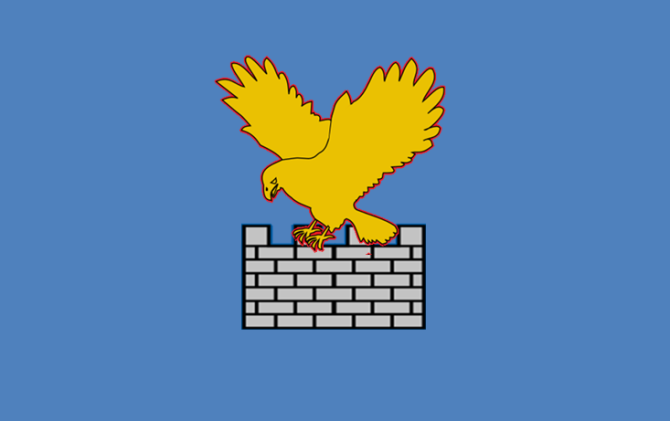
Friuli Venezia Giulia, ripresa tra colpe e progetti
Redazione », Editoriali, Scrivono di noi friuli venezia giulia, friulia, massimo blasoni, messaggero veneto
Massimo Blasoni – Messaggero Veneto
Stando al recente rapporto “L’Economia del Friuli Venezia Giulia” della Banca d’Italia, i segnali di ripresa dell’economia nella nostra regione non mancano. La produzione industriale, per quanto inferiore del 10% rispetto all’ultimo picco del 2008, mostra segni evidenti di ripresa. Si è anche avuto un rallentamento della stretta creditizia che non poco aveva pesato negli ultimi anni. Il dato che dovrebbe far riflettere è che questi indici positivi trovano le loro origini fondamentalmente nel buon andamento dell’export per fattori esogeni (prezzo del petrolio e svalutazione dell’euro) più che nella capacità regionale di fare sistema e innovazione. Colpe d’attribuirsi in primo luogo agli imprenditori, tuttavia occorre anche chiedersi se l’Amministrazione regionale stia agendo efficacemente per sostenere questa timida ripresa.
All’inizio dell’anno si è proposto un piano di sviluppo del settore industriale, Rilancimpresa: non pare però che si siano sortiti effetti significativi. Scorrendo i molti articoli e commi della legge, pare quasi che l’ambizione principale del dispositivo sia il riordino dei Consorzi Industriali, realtà importanti che rappresentano però solo una minima parte dell’economia regionale. Inoltre, con la stessa legge è istituita, sotto la Direzione centrale attività produttive, l’”Agenzia Investimenti FVG” che, in collaborazione anche con Friulia S.p.A. e Finest S.p.A., dovrà svolgere un ruolo fondamentale nelle politiche di programmazione industriale. Al di là del dubbio sull’opportunità di istituire un nuovo ente restano rilevanti le domande sulla capacità effettiva di Friulia e delle altre partecipate regionali di esplicare appieno le loro mission economiche. Una perplessità che si estende anche a Mediocredito – la banca regionale – e che nasce dall’analisi dei bilanci di queste realtà. Per quanto riguarda Friulia il numero di nuove partecipazioni in società del territorio è in discesa (14,2 milioni nel 2013/2014 contro i 24,9 e i 31,4 dei due esercizi precedenti) e gli investimenti attuati sono circa la metà di quelli deliberati. Anche le partecipazioni complessive passano da 214 milioni nel 2012 a 190 nel 2014: anno in cui le imprese partecipate complessivamente erano 117 (e soltanto 72 fra queste operative). Non va dimenticato che i soli costi di struttura della finanziaria regionale nell’ultimo esercizio si sono attestati a circa 6 milioni di euro, comprensivi di costi del personale per ben 3,8 milioni e costi generali di funzionamento pari a 2,3 milioni.
Nata nel 1964, con un’intuizione assolutamente innovativa per quel periodo, Friulia avrebbe dovuto, attraverso la partecipazione al capitale di imprese locali e finanziamenti a medio termine, conseguire l’obiettivo di far crescere realtà regionali e dar luogo a start up, soprattutto se ad alto contenuto innovativo. Negli anni invece (molte colpe sono anche del centro destra) ha finito per svolgere più il ruolo di ammortizzatore per società in difficoltà, sostanzialmente ritardandone il default a spese dei contribuenti. Non sono pochi i dubbi anche su Mediocredito: è utile per la regione controllare una banca che per basso numero di sportelli e dimensioni modeste rischia di essere strutturalmente in passivo? Senza peraltro poter svolgere un peculiare ruolo di supporto al sistema imprenditoriale locale, attese le stringenti regole di Basilea 3 sul merito creditizio.
Alla luce della rapida trasformazione del tessuto economico occorre una revisione strategica dei non pochi strumenti con cui l’Amministrazione regionale può attuare politiche di sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale. La specialità regionale va difesa e assume significato prima che nella contrattazione con lo Stato sulla quantità delle risorse, attraverso la dimostrata capacità di promuovere con la massima efficienza autonome politiche regionali. Vale per la ridefinizione di strumenti come Friulia e Mediocredito. Potrebbe valere – anche se il tema è complesso- anche per ipotesi quali la fiscalità di vantaggio.

Risparmiare con le fusioni
di Gionata Pacor – Associazione Città Comune
Dal riordino degli enti locali possono venire degli utili risparmi di spesa pubblica. Di solito quando si parla di fusione dei comuni ci si riferisce ai centri sotto i 5.000 abitanti, ma sono in corso anche iniziative diverse, che riguardano comuni più grandi. Una di queste è quella di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano, forse il primo caso in Italia in cui un’iniziativa di fusione è partita dalla cittadinanza, che nonostante la contrarietà dei tre sindaci (tutti e tre del PD), si è organizzata ed ha raccolto 6200 firme autenticate per chiedere un referendum sulla fusione di questi tre comuni che, per compenetrazione urbana, economia ed identità, formano già un’unica città di circa 48.000 abitanti. La normativa regionale del Friuli Venezia Giulia prevede che in primavera si tenga il referendum, nonostante le maggioranze al governo nei tre comuni abbiano fatto poco per agevolare la raccolta delle firme (e qualcosa per ostacolarla).
I motivi a favore di una fusione sono di due tipi: da un lato le potenzialità in termini di riorganizzazione e rilancio del territorio sotto una direzione unica e non frammentata, dall’altro lato la possibilità di ristrutturare ed ottimizzare le amministrazioni pubbliche locali. Questi aspetti sono strettamente connessi tra loro perché un unico comune con un’azione politica coerente può sfruttare meglio le risorse e le infrastrutture del territorio distribuite sul territorio delle diverse amministrazioni (nel caso dei tre comuni in questione si parla di un aeroporto, un porto, la rete ferroviaria ed autostradale, il litorale, le diverse zone industriali, i parchi naturali ecc.), e dalla riorganizzazione delle macchine comunali si possono ottenere i risparmi e le risorse economiche per finanziare quel rilancio.
I risparmi dai costi della politica sarebbero importanti non tanto quantitativamente quanto simbolicamente: due sindaci, una dozzina di assessori e circa quaranta consiglieri in meno farebbero risparmiare circa 270.000 euro l’anno. L’associazione Città Comune, promotrice del referendum, è partita da un confronto con altre città di grandezza comparabile, scoprendo che ci sono città come Empoli che hanno circa 250 dipendenti comunali, mentre i tre comuni da fondere messi assieme ne hanno circa 480. La proposta è quindi quella di una graduale riduzione dei dipendenti comunali senza licenziamenti, attuata man mano che quelli con maggiore anzianità vanno in pensione, per arrivare a circa 320 dipendenti. Il processo prevede l’accorpamento della maggior parte degli uffici (ma non quelli che offrono i servizi direttamente ai cittadini, come ad esempio l’anagrafe), l’esternalizzazione di alcune attività a basso valore aggiunto (ad esempio la manutenzione degli immobili) ed il potenziamento di alcuni uffici (ad esempio l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e l’ufficio legale). I risparmi calcolati, solo in termini di minore spesa del personale, sarebbero di quasi 3 milioni all’anno. A ciò si aggiungono altri vantaggi difficilmente quantificabili a priori: minori costi di formazione del personale e per le postazioni di lavoro (arredamento e manutenzione degli uffici, computer, software, riscaldamento, corrente elettrica ecc.) e la possibilità di alienare qualche immobile per abbattere il debito pubblico comunale.
Quello di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano è un progetto che vuol fare da modello e da best practice a livello nazionale e dimostrare i vantaggi dei processi di fusione che, è bene ricordarlo, in Germania sono stati adottati senza nessun referendum consultivo oltre 40 anni fa, tanto che oggi il comune medio tedesco conta 50.000 abitanti, mentre quello italiano ne conta circa 7.500. Di certo non è un processo che da solo potrà risanare le finanze pubbliche ma, se esteso a livello nazionale, potrà fornire un contributo significativo, senza tagliare i servizi ed in certi casi potenziandoli.

La Rai non cambia, l’Italia neppure
di Carlo Lottieri
La rappresentazione più impietosa dell’incapacità riformatrice della maggioranza guidata da Matteo Renzi viene dalle recenti vicende della Rai. Anche in considerazione del fatto che – sotto vari punti di vista – la Rai è l’Italia, e l’Italia è la Rai. In sostanza all’interno dell’azienda di viale Mazzini nulla cambia al di là dei nomi. Ieri si lottizzava e oggi, invece, pure. Ieri si negoziava con le minoranze una quota della loro presenza all’interno degli organismi dirigenti, e adesso avviene esattamente la stessa cosa. Ieri si sceglievano amici e amici degli amici, e ovviamente lo si continua a fare. Ma non è questo il punto.
Il dato cruciale è un altro, e cioè che nel 2015 nessuno sembra scandalizzato dal fatto che il potere statale continua a gestire informazione, cultura e divertimento, esattamente con quando Benito Mussolini parlava alla radio di Stato e il Minculpop si preoccupava di manipolare al meglio le menti degli italiani. La cecità non è solo italiana, ma certo non denota spirito innovativo e capacità rinnovatrice un giovane premier che neppure prende in considerazione di realizzare una vera trasformazione in senso liberale, alzando un muro tra il potere politico e il sistema dei media. Perché certamente non è veramente libera una società in cui i mezzi d’informazione dipendono dagli apparati politico-burocratici.
Per giunta la Rai è un baraccone che costa un’enormità agli italiani. Se volesse dare un segnale di discontinuità rispetto ai governi che l’hanno preceduto, Renzi avrebbe una sola cosa da fare: eliminare il canone (di fatto un’imposta) e mettere in vendita la Rai, con dentro Franco Siddi e Carlo Freccero, Guelfo Guelfi e Arturo Diaconale e tutti gli altri. L’unica soluzione razionale per questo sempiterno ministero della manipolazione delle menti è la sua dimissione. Ma ovviamente Renzi non pensa a nulla di ciò.
Non ci pensa perché il suo potere è costruito attorno a una fitta rete di nomine, favori, incarichi. E la Rai fa parte di questo grande mosaico, ovviamente. Per giunta egli ha bisogno di costruire consenso intorno a sé e quindi ha bisogno che i passacarte dei Tg lo mettano sempre in una buona luce e che lo stesso succeda ai molti miracolati che fanno parte della sua cerchia. Infine, ed è questo forse il punto più drammatico, non è pensabile che Renzi si orienti verso una vera e compiuta privatizzazione della Rai perché egli non ha minimamente il polso della situazione e non comprende la necessità di procedere a tagli massicci della spesa, a una riduzione della presenza dello Stato, a una piena liberalizzazione di vasti settori. Non sa cosa stanno realizzando, con le privatizzazioni, Cameron e Osborne nel Regno Unito e neppure è interessati a saperlo.
Egli continua a vendere la favola di un’Italia che tutto sommato funziona bene e che va solo qua e là un poco aiutata e sostenuta. Sembra insomma non comprendere che il settore produttivo soffre come mai in passato e che solo se si incide con il bisturi sull’Italia parassitaria è forse possibile ridare speranza al mondo degli imprenditori. In questo senso, la grande azienda televisiva di Stato è la rappresentazione più macroscopica di una maniera tutta italiana d’intendere le cose, la quale continua a confidare nel debito, rinviare le scelte, anteporre il privilegio garantito a qualcuno oggi invece che il riconoscimento dei diritti di tutti in un domani da conquistare. In questa Italia il premier attuale ha costruito le sue fortune. Farà di tutto per difenderla.

Se togliere Imu servisse a liberare l’economia…
Redazione », Editoriali carlo lottieri, casa, imu


