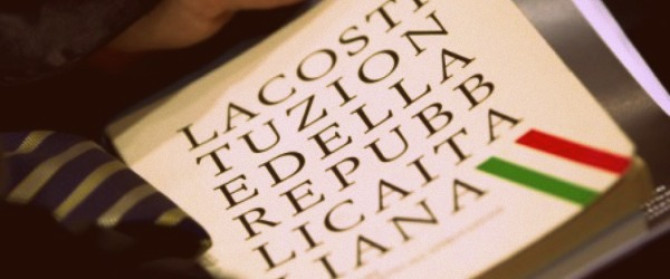La ventunesima prova di forza
Alfonso Celotto – Il Tempo
Con il Jobs act siamo arrivati a 21 voti di fiducia, sono così tanti che non ci facciamo più caso. Il secondo governo Prodi ha avuto una media di una fiducia al mese, in tutto 28. Il successivo esecutivo, guidato da Berlusconi, riuscì addirittura a fare «meglio», con una media di 1,2 al mese (53 in tutto). Record per Mario Monti con un governo che fece ricorso a 51 voti di fiducia, una media di 3 al mese. A seguire l’allora premier Enrico Letta ne ha previsti «solo» 9, in media 0,9 al mese. E arriviamo ai giorni nostri. In poco più di 6 mesi il governo Renzi ha accumulato 21 voti di fiducia. Sul piano statistico siamo tornati ai tempi dell’esecutivo tecnico di Monti allorché si gridò alla morte della democrazia. Eppure la questione della «fiducia» resta un forte strappo alle regole costituzionali di esame e approvazione delle leggi.
Quando il governo ricorre a questa pratica produce due effetti: fa cadere tutti gli emendamenti presentati dai parlamentari, a cui impone di votare sul suo testo, e fa sì che la scelta avvenga per appello nominale, in maniera da evitare possibili «franchi tiratori». Insomma, la questione di fiducia è una «bacchetta magica» (o una clava) in mano al governo. L’hanno usata a destra e a sinistra. Ora tocca a un governo che dovrebbe essere il più forte degli ultimi anni: ha un leader carismatico e una grande prospettiva di crescita. Eppure Renzi ricorre continuamente alla fiducia. Segno di forza, di debolezza o di assenza di democrazia?