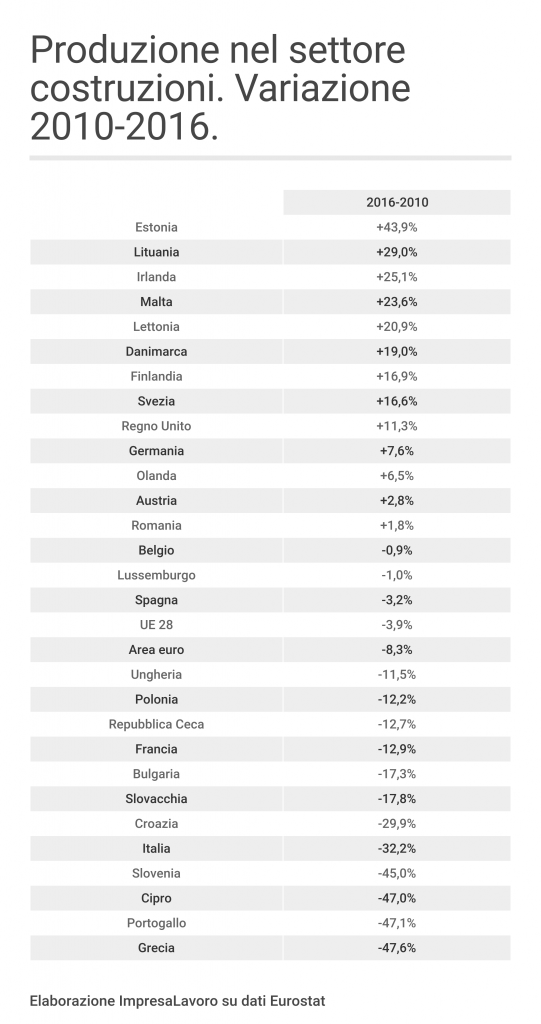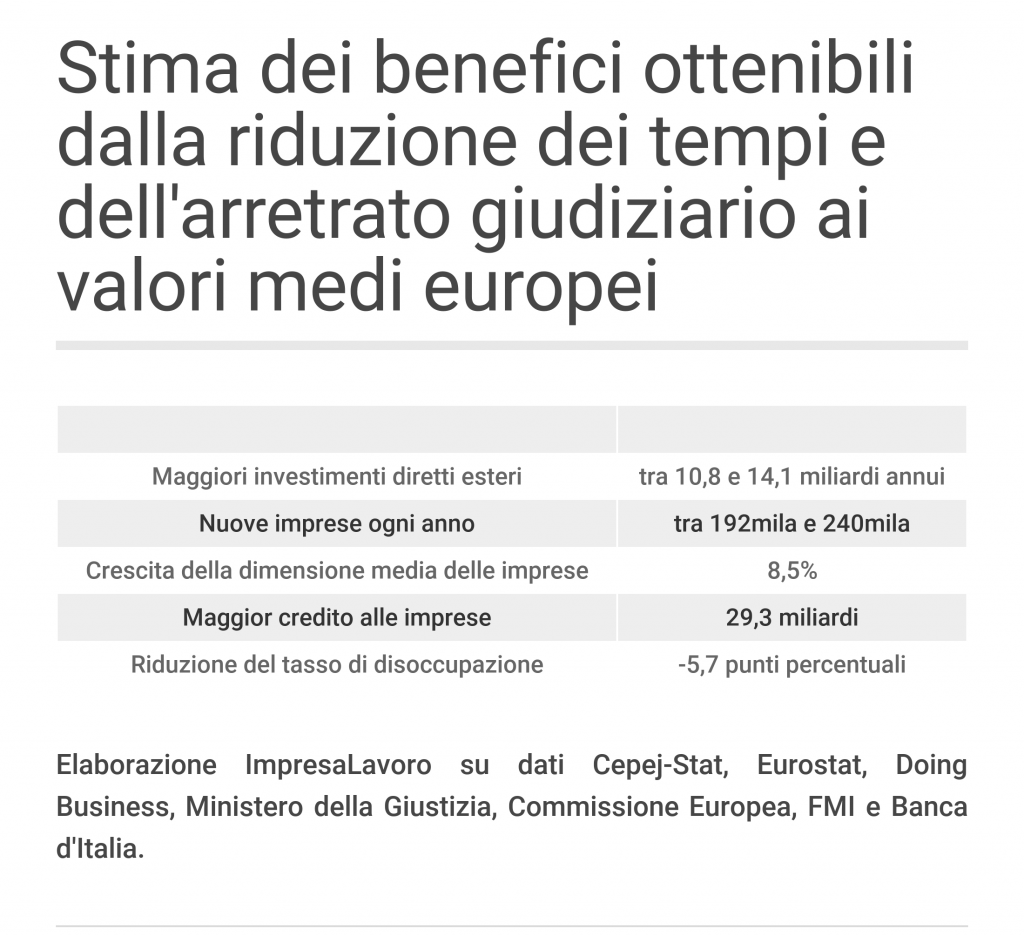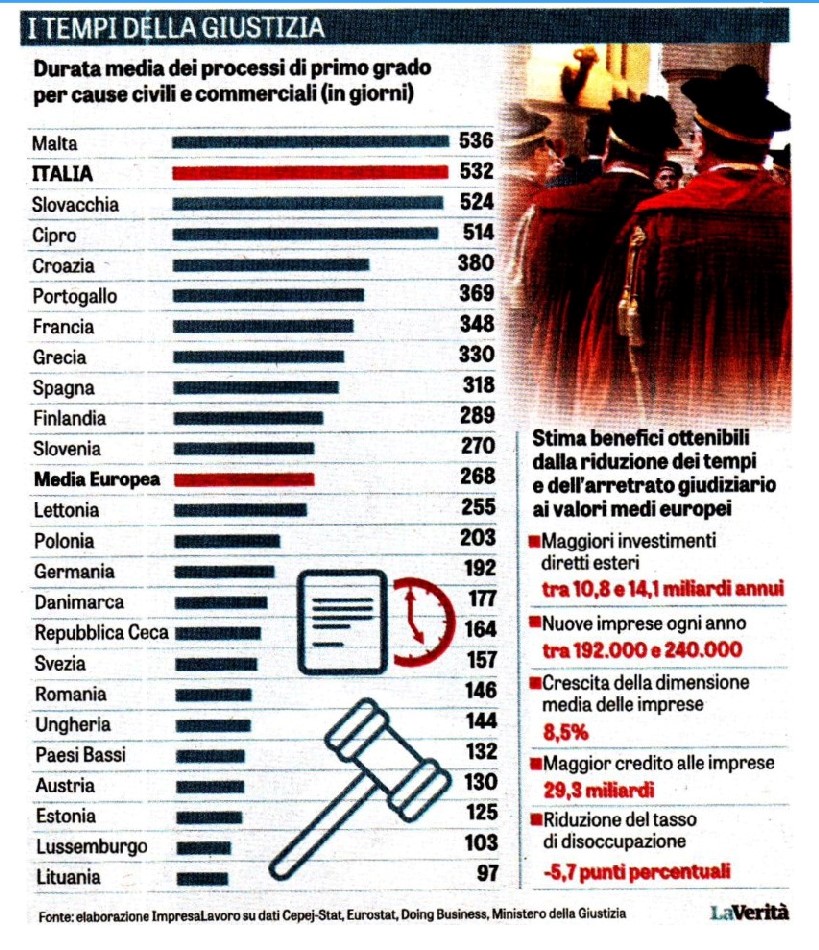Le trappole cinesi della Via della Seta
La nuova Via della Seta – o come preferiscono chiamarla i Cinesi OneBelt OneRoad – è la rete di infrastrutture in via di progettazione per meglio collegare il Celeste Impero con l’Europa e incrementarne il commercio. Gli obiettivi sono, o dovrebbero essere, bilaterali poiché gran parte degli Stati dell’Asia centrale hanno pochissimo intercambio e con la Cina e con l’Europa. Quelli che ne sono dotati esportano principalmente materie prime (soprattutto oli minerali) e, dopo una fase in cui hanno investito moltissimo nell’immobiliare, sono in stagnazione. L’obiettivo principale, ove non unico, è quindi l’aumento degli scambi con l’Europa.
Un paper di Jonathan Holsag, della Vrje Universiteit Brussel, pubblicato sul No. 4 di The International Spectator (l’elegante rivista in inglese dell’Istituto Affari Internazionali, un quadrimestrale italiano che ha 52 anni di vita) esamina gli aspetti economici della Via della Seta sulla base di documenti inediti della Celeste Burocrazia cinese. Prima di inneggiare alle nuove opportunità di esportazioni che si aprono alle imprese europee, vale la pena leggerlo con attenzione. Il lavoro, molto documentato, dimostra che per l’Europa la Via è in realtà una grande trappola
Occorre fare una premessa. La Cina fa parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (il codice di regole per l’interscambio internazionale) solamente dal 1991. Numerosi Stati membri dell’OMC non pensavano che avesse i requisiti minimi per entrare, anche e soprattutto perché un commercio internazionale libero e competitivo è poco compatibile con politiche economiche interne stataliste e autarchiche. In questo ultimo quarto di secolo, il settore dei servizi ha avuto un buon grado di liberalizzazione, gli investimenti esteri sono stati autorizzati, le restrizioni sulla distribuzione all’ingrosso e al dettaglio sono state rimosse e parimenti sono stati un poco aperti i mercati dei servizi finanziari, delle banche, delle assicurazioni e delle telecomunicazioni.
Non facciamoci però illusioni. La Cina resta un Paese fortemente mercantilista e ha capacità di celare i protezionismi nel modo più astuto. Dal 2008 a oggi sulla Via della Seta le esportazioni di beni e servizi cinesi verso l’Europa sono aumentate del 250% mentre quelle di Francia, Germania e Italia diminuite rispettivamente del 14%, del 26% e del 9%.