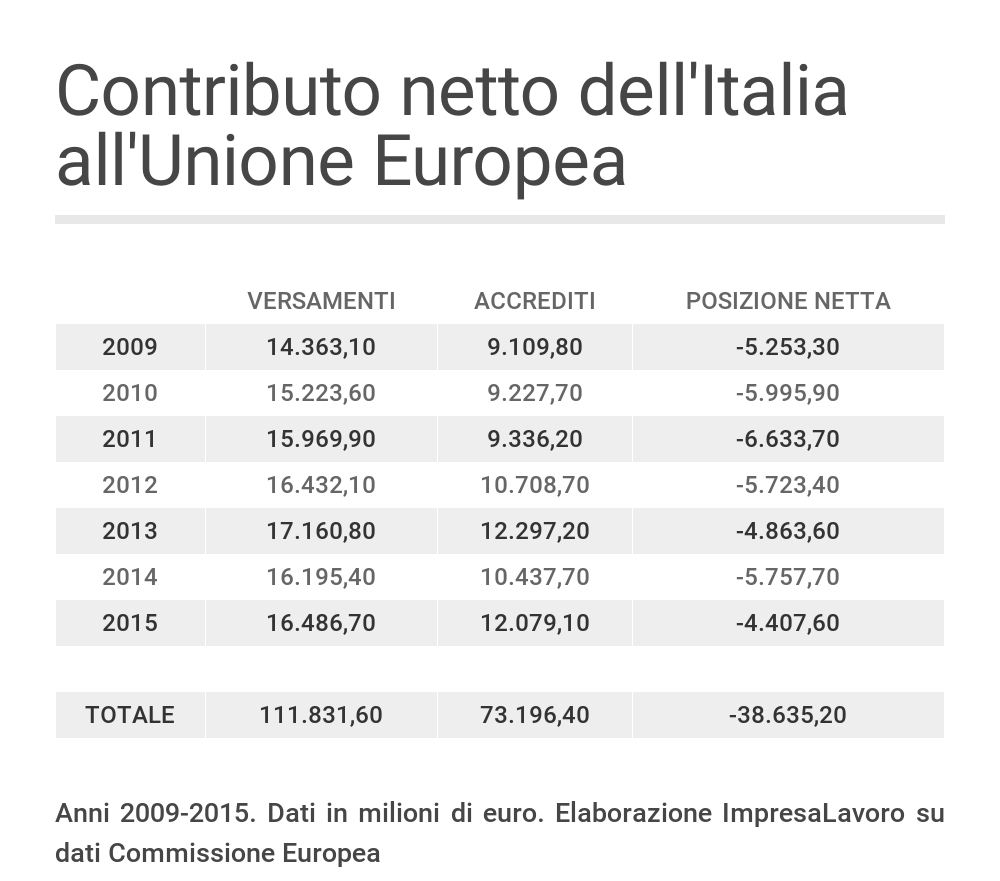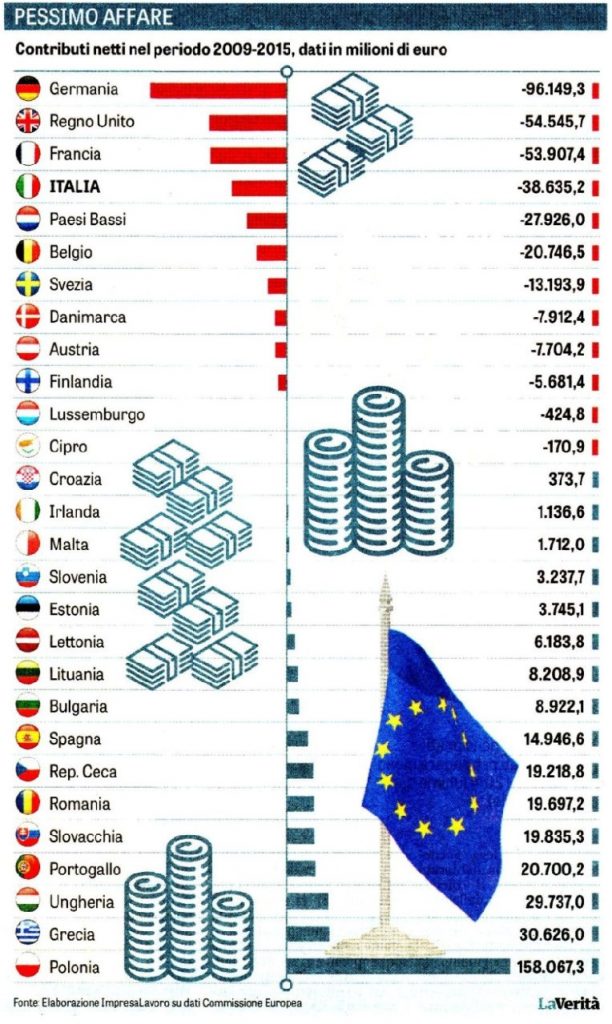Crisi: dal 2007 il Pil pro capite medio degli italiani è sceso del 10,8%, in calo anche il numero degli occupati. Le differenze regione per regione.
Dal 2007 al 2015 (anno di cui sono disponibili i dati più recenti), il Pil pro capite degli italiani è sceso del 10,8%, passando da 28.699 a 25.586 euro (-3.113 euro). Questo calo non si è comunque distribuito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Altrettanto disomogeneo appare il calo degli occupati nel nostro Paese, che restano ancora inferiori ai dati registrati nel 2007, alla vigilia della lunga crisi economica ancora in atto. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati Istat.
Nessuna Regione italiana è riuscita ancora a tornare ai livelli precedenti la crisi economica, ma in alcuni casi il calo del Pil pro capite medio dei suoi cittadini è stato più sensibile. In fondo alla graduatoria, ordinata per variazione percentuale negativa, troviamo Molise (-19,3%), Umbria (-18,3%), Lazio (-17,7%) e Campania (-16%). Restano al di sotto del dato nazionale anche regioni del Nord come Friuli Venezia Giulia (-11,4%), Liguria (-11,6%), Piemonte (-12,3%) e Valle d’Aosta (-12,6%). Meno colpite, anche se sempre in territorio negativo, sono state invece Trentino Altro Adige (-3,2%), Basilicata (-4,5%), Abruzzo (-6,2%) e Lombardia (-7,9%) che fanno registrare performance sensibilmente migliori della media nazionale.
Nel 2016 nel nostro Paese risultano poi occupate 22.757.840 persone, un dato ancora inferiore di 136.107 unità a quello del 2007, quando gli occupati erano 22.893.947. Anche in questo caso i dati regionali si muovono in modo molto disomogeneo. Rispetto al 2007 già oggi risultano occupate più persone nel Lazio (+201.070, +9,42%), in Trentino Alto Adige (+31.645, +7.04%), in Toscana (+35.856, +2,34%), in Emilia Romagna (+42.685, +2,22%) e in Lombardia (+90.958, +2,15%). E se il Veneto è sostanzialmente quasi ritornato agli stessi livelli del periodo pre-crisi (-18.698, -0,89%), ancora lontane dai livelli occupazionali fatti registrare nove anni fa restano regioni del Nord come la Liguria (-23.607, -3,73%), il Friuli Venezia Giulia (-20.384, -3,93%) e la Valle d’Aosta (-2.391, -4,21%). In questo stesso periodo di tempo si registra una contrazione più marcata degli occupati in tutte le regioni del Sud: Campania (-74.139, -4,33%), Molise (-5.539, -4,97%), Puglia (-80.425, -6,31%), Sardegna (-43.816, -7,23%), Sicilia (-129.443, -8,74%) e Calabria (-69.093, -11,67%).
Non mancano comunque timidi segnali di ripresa dell’occupazione. Un confronto tra i dati 2015 e 2016 evidenzia come nell’ultimo anno il nostro Paese abbia complessivamente recuperato 293.088 posti di lavoro. Le tre Regioni che hanno registrato le migliori performace in valori assoluti sono Lombardia (+71.878), Campania (+59.787) ed Emilia Romagna (48.823). In termini percentuali rispetto alla base occupazionale crescono invece più di tutti Campania (+3,79), Molise (+3,75%), Emilia Romagna (+2,55%), Puglia (+1,98%) e Basilicata (+1,95%). Il dato più negativo viene invece fatto registrare dall’Umbria, che nell’ultimo anno ha perso 5.414 posti di lavoro (-1,51%).
«Mentre tutti gli altri nostri principali competitor europei sono da tempo ritornati ai livelli di crescita pre crisi, l’Italia continua a registrare valori di reddito pro capite e occupazione inferiori a quelli del 2007» osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «Purtroppo non si è voluto approfittare di questa crisi decennale per cambiare drasticamente le regole del mercato del lavoro e per allegerire le nostre imprese dal peso esorbitante (e disincentivante) di una tassazione eccessiva nonché di leggine e regolamenti che imbrigliano la loro azione quotidiana. I vari bonus sono pannicelli caldi che non aiutano a rilanciare l’economia e che disperdono risorse. Occorre cambiare passo: rilanciare gli investimenti pubblici e mettere finalmente gli imprenditori nelle condizioni di creare nuovi posti di lavoro e quindi nuova ricchezza».