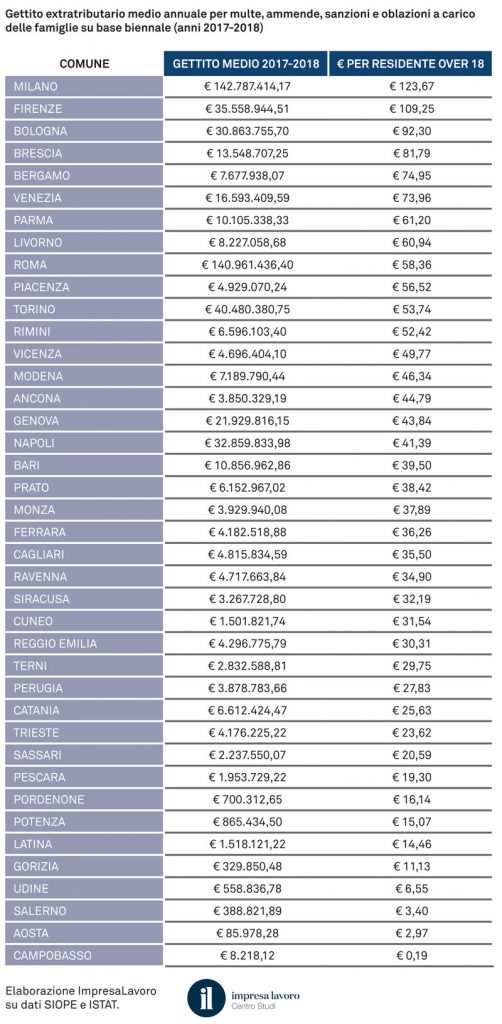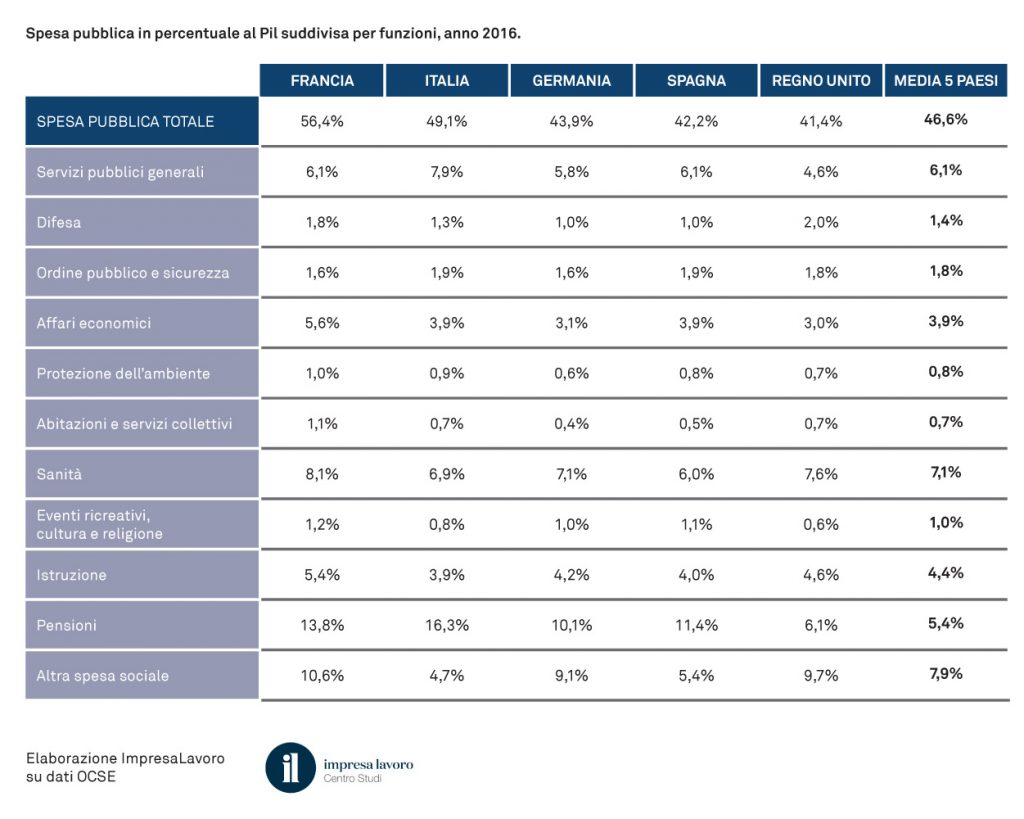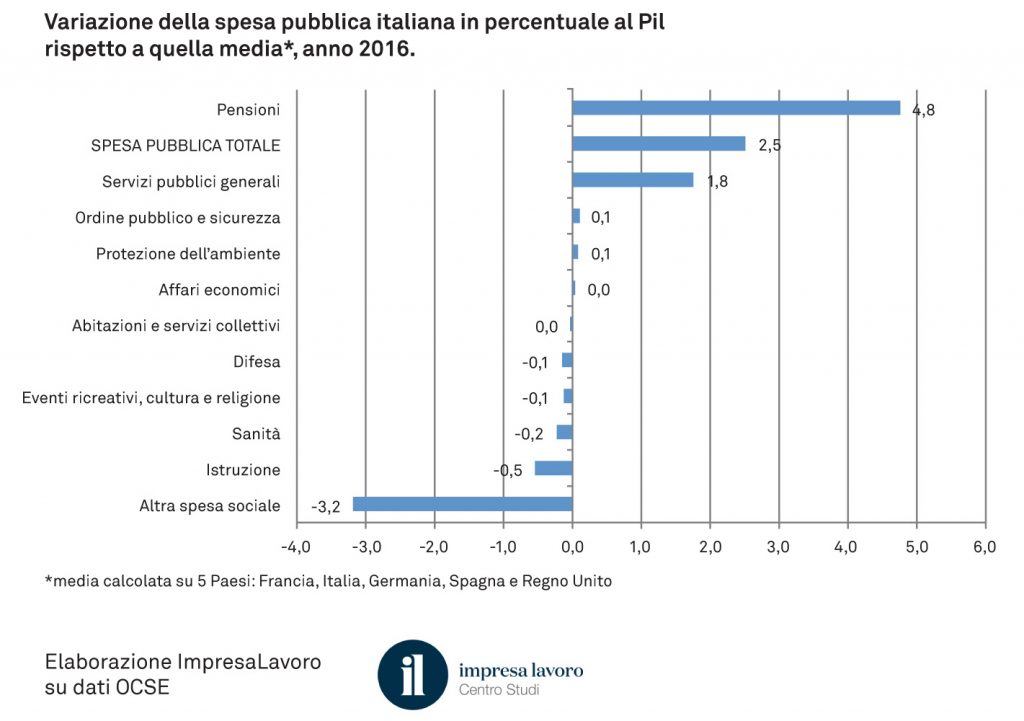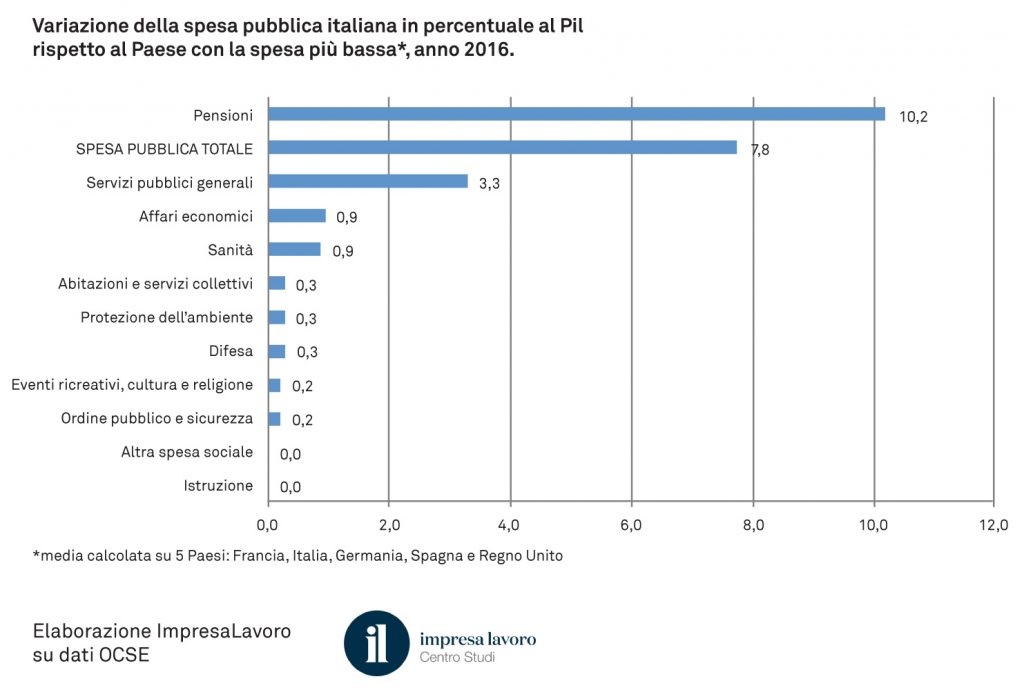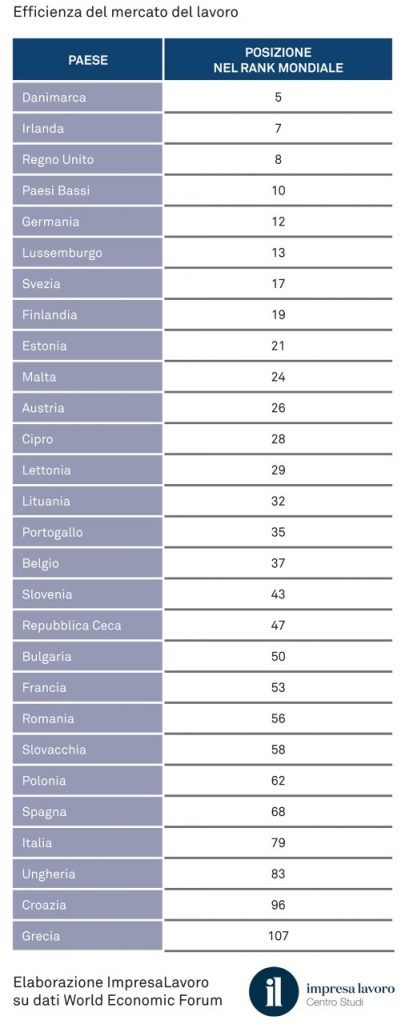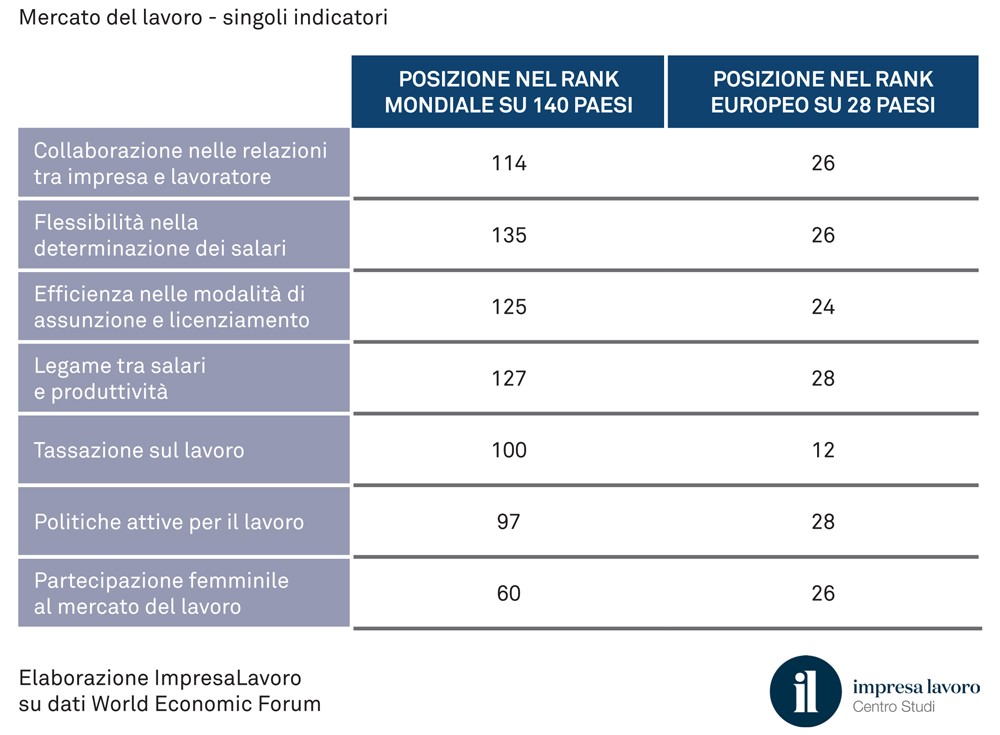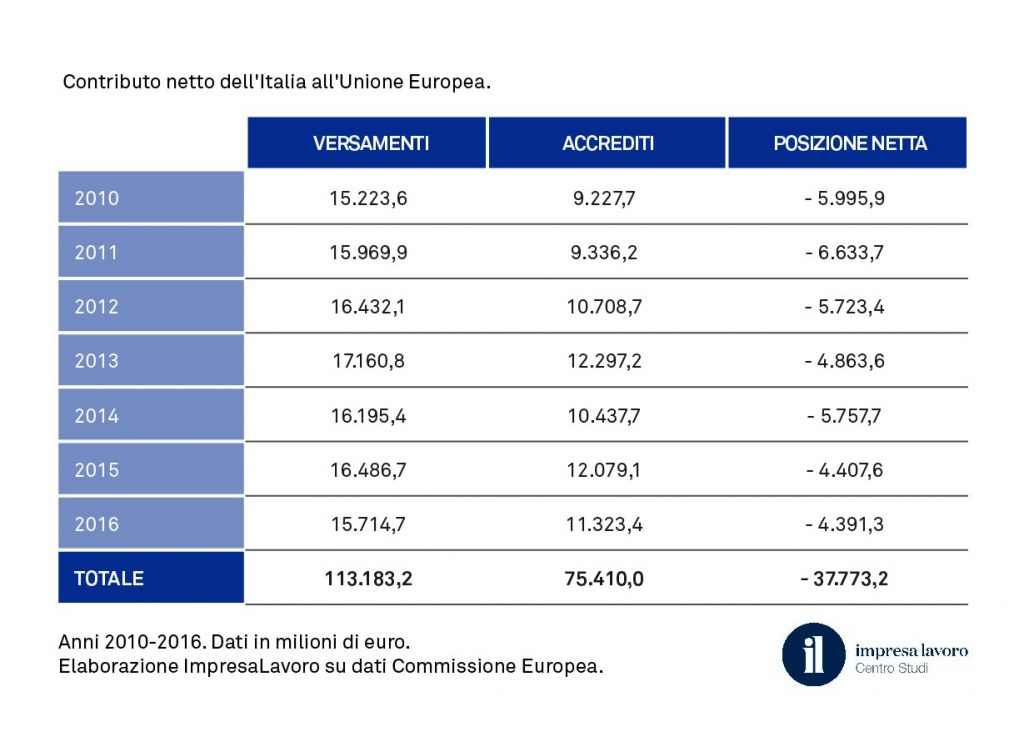Pensioni: in Italia età effettiva è 62,1 anni, tra le più basse in Europa
In Italia l’età effettiva di pensionamento è di 62,1 anni, al momento tra le più basse in Europa: nel nostro Paese si va in pensione 7 anni prima che in Portogallo, 5 prima che in Irlanda e un anno prima rispetto alla media europea. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su dati OCSE (“Ageing and Employment Policies – Statistics on average effective age of retirement”).
Per età “effettiva” di pensionamento s’intende l’età effettiva media di uscita dal mercato del lavoro, beneficiando anche di eventuali anticipi pensionistici/eccezioni (l’OCSE ha considerato i dati tra il 2011 e il 2016). L’età “normale” di pensionamento è invece quella prevista dalla normativa vigente nei vari Paesi europei senza anticipi di alcun tipo, quindi l’età a cui un individuo può uscire dal mercato del lavoro senza subire una riduzione dell’assegno e dopo una carriera lavorativa senza interruzioni a partire dai vent’anni d’età (l’OCSE ha effettuato questa valutazione considerando l’anno 2014).
In Italia l’età effettiva di pensionamento – che come detto è di 62,1 anni – risulta inferiore di 4,5 anni rispetto a quella normale (66,6). Un trend simile si riscontra anche per quanto riguarda le lavoratrici, che vanno in pensione a un’età effettiva di 61,3 anni contro una normale di 65,6. Lo stesso vale per Paesi come la Slovacchia (60,8 effettiva e 66,2 normale), la Polonia (62,6 effettiva e 67 normale) e il Belgio (61,3 effettiva e 65 normale).
Ordinando la classifica per età “effettiva” di pensionamento l’Italia si colloca nella seconda metà della stessa, ossia al 15° posto sul totale di 22 Paesi europei considerati. Si scopre così che da noi si va in pensione molto prima che in Portogallo (69 anni), Irlanda (66,9 anni), Svezia (65,8 anni), Regno Unito (64,6 anni), Paesi Bassi (63,5 anni) e Germania (63,3 anni).
Il risultato si ribalta se invece si prende in considerazione l’età di pensionamento “normale”, ossia quella risultante dalla legislazione vigente senza considerare anticipi pensionistici. L’Italia sale al secondo posto con 66,6 anni, superata solamente dalla Polonia con 67 anni. L’ultimo posto se lo aggiudica invece la Spagna, dove il valore è pari solamente a 59,3.
«L’Italia non è quindi al momento uno dei Paesi in cui si va in pensione più tardi e questo avviene soprattutto perché la maggior parte dei lavoratori utilizza i requisiti stabiliti per la pensione anticipata» osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «In futuro il discorso sarà completamente diverso. I giovani iniziano a lavorare più tardi e in maniera spesso discontinua, così accumulando “vuoti” contributivi. Non soltanto andranno in pensione a un’età più avanzata ma soprattutto godranno di assegni previdenziali più bassi. Secondo il report OCSE Pensions at a Glance 2017 un giovane che ha iniziato a lavorare nel 2016, quando aveva 20 anni, dovrà attendere i 71,2 anni per ottenere la pensione».