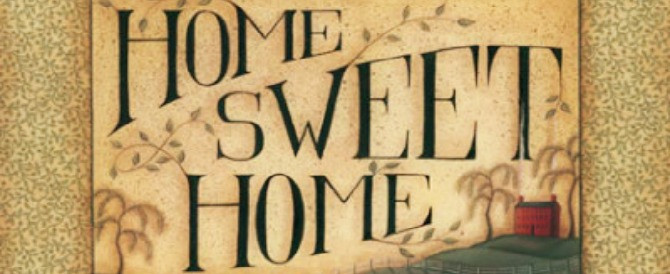Lavoro, tutte le nuove misure (senza articolo 18)
Lorenzo Salvia – Corriere della Sera
Quello a tempo indeterminato e a tutele crescenti sarà il tipo di contratto «privilegiato in termini di oneri diretti e indiretti». Per questo sarà possibile incentivarlo, sotto forma di taglio dei contributi o dell’Irap da quantificare successivamente con le norme attuative, in modo da renderlo più vantaggioso rispetto ai contratti a termine che altrimenti non avrebbero rivali, specie dopo la liberalizzazione di pochi mesi fa. E con l’obiettivo finale di arrivare al «superamento delle tipologie contrattuali più precarizzanti». Nell’emendamento al Jobs act , il disegno di legge delega per la riforma del lavoro sul quale oggi il Senato dovrà votare la fiducia, il governo fa qualche altro passo verso la minoranza del Pd, che però resta critica.
Licenziamenti
Dal pacchetto, otto pagine che ieri sera hanno avuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e stamattina saranno depositate formalmente in Senato, resta però fuori ogni riferimento alle nuove regole sui licenziamenti e all’articolo 18. La questione sarà confinata ad un semplice discorso che il ministro del Lavoro Giuliano Poletti farà in Aula. Dichiarazioni spontanee, nessuna votazione a seguire. Come indicato nel documento votato nella direzione del Pd, il ministro si impegnerà a mantenere il reintegro nel posto di lavoro per i licenziamenti disciplinari, quelli addebitati al comportamento del dipendente, che dovessero essere giudicati ingiustificati dalla magistratura. Ma solo in alcuni casi limite e comunque rimandando i dettagli al 2015, quando il Jobs act sarà stato approvato anche alla Camera e il governo scriverà i decreti attuativi.La tipizzazione
A quel punto, ma solo a quel punto, il governo procederà ad una tipizzazione più stretta dei licenziamenti disciplinari ingiustificati, in modo da ridurre il margine di discrezionalità dei magistrati. E lascerà aperta la possibilità per l’azienda di scegliere comunque l’indennizzo, ma più caro, anche quando il magistrato dispone il reintegro. I decreti attuativi passeranno in Parlamento solo per un parere non vincolante, e il governo avrà gioco più facile rispetto al difficile compromesso che deve cercare adesso. Una semplice dichiarazione del ministro non è una garanzia sufficiente per la minoranza Pd, che con Cesare Damiano avverte: «La battaglia per migliorare la delega continuerà alla Camera». Ma potrebbe funzionare da scudo in futuro, se le norme attuative dovessero essere impugnate davanti alla Corte costituzionale perché vanno al di là della delega, visto che nel Jobs act manca un riferimento proprio all’articolo 18.Mansioni e voucher
Nell’emendamento ci sono altri due passi verso la minoranza Pd. Il primo è sul demansionamento, cioè la possibilità di assegnare al lavoratore mansioni inferiori a quelle della categoria di appartenenza. L’operazione sarà possibile rispettando le «condizioni di vita ed economiche del lavoratore», il che non vuol dire necessariamente conservando lo stesso salario ma quasi. Mentre sui voucher, i buoni lavoro utilizzati per le prestazioni occasionali, resta fermo il principio di un tetto massimo al loro utilizzo, che però sarà definito sempre con le norme attuative.Scioperi e referendum
Non ci saranno invece, salvo sorprese, le norme sulla rappresentanza, sulla contrattazione aziendale e sul salario minimo, delle quali aveva parlato lo stesso Matteo Renzi nel corso dell’incontro con i sindacati avuto in mattinata. L’obiettivo è quello di impedire scioperi e referendum quando un accordo viene firmato dal 50% più uno dei rappresentanti sindacali, limitando il diritto di veto delle sigle più piccole (leggi Fiom). Mentre il salario minimo potrebbe sostituire in parte i contratti nazionali, indebolendo anche i sindacati più grandi. Il progetto resta in piedi ma con tempi più lunghi.