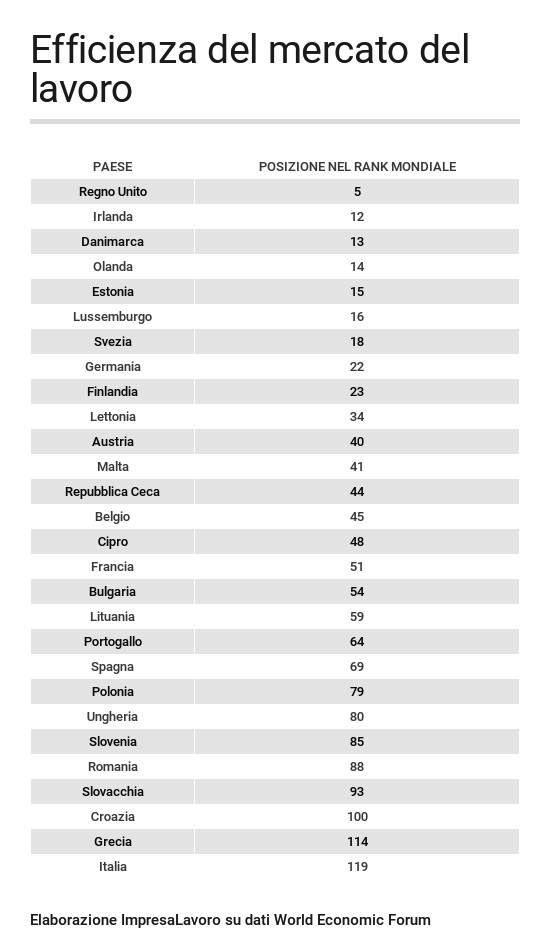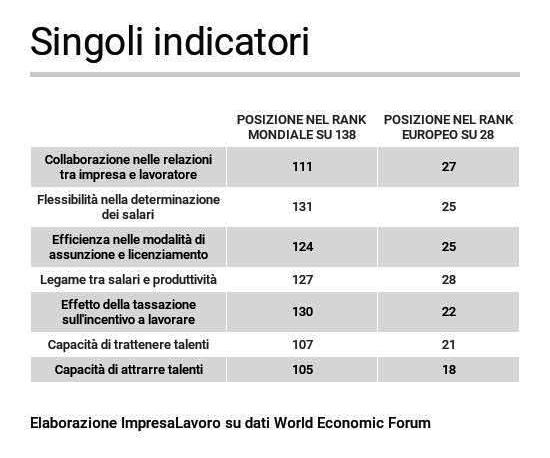Spesa pubblica e risparmi
di Massimo Blasoni – Metro
C’è una sola via per la contrazione drastica e strutturale della spesa pubblica che nemmeno la manovra di quest’anno affronta: occorre che lo Stato riduca il suo campo di azione e, gravati da meno tasse, siano i cittadini e le imprese a occupare quegli spazi. Non è frutto di un ordine necessario che lo Stato gestisca, in via quasi esclusiva, pensioni, scuola, sanità.
I risultati in tema di riduzione della spesa pubblica sono stati in questi anni assai lontani dagli obiettivi che si erano ripromessi i vari commissari alla spending review. Diminuire la spesa è problematico perché significa toccare situazioni di cui molti beneficiano: ridurre privilegi ma anche servizi. Essendo difficile decidere chi scontentare, i tagli di norma sono lineari oppure si tratta di spese differite all’anno successivo. Poco o nulla di strutturale, quindi. Peggio, si tende a tagliare la spesa per investimenti, quella di cui ci sarebbe bisogno in un Paese carente di infrastrutture fisiche e soprattutto digitali, tanto da essere agli ultimi posti in Europa per capacità di innovazione.
La spesa corrente al netto di interessi è passata, in valori assoluti, da 671 a 702 miliardi tra il 2012 e il 2016. Quella per investimenti nell’ultimo quinquennio è scesa di 7,8 miliardi: l’opposto di quello che è successo in Inghilterra. Che ne è stato del taglio delle partecipate? Chi ha novità sulle liberalizzazioni e privatizzazioni per lo più naufragate? Anziché discettare di buona spesa pubblica e di tagli, senza metterli in pratica, occorrerebbe un cambio di prospettiva.
Non è detto che molte delle cose di cui si occupa la pubblica amministrazione non possano essere fatte, e meglio, dai cittadini. Chi spende per se stesso spende con attenzione, diversamente da quello che accade spesso nella PA. Un esempio: il denaro che versiamo per le nostre future pensioni non è ben amministrato dallo Stato. Perché non dovremmo ricorrere al mercato? L’Inps registra passivi pesantissimi anche a causa di evidenti inefficienze e ha uno sterminato patrimonio immobiliare acquistato spesso a prezzi esosi e poi locato per importi magari risibili. Fatta la tara a tutte le indubbie complessità e alle esigenze sociali, qualcuno ha dubbi sul fatto che ognuno di noi gestirebbe meglio quel denaro se potesse farlo, almeno in parte, direttamente?