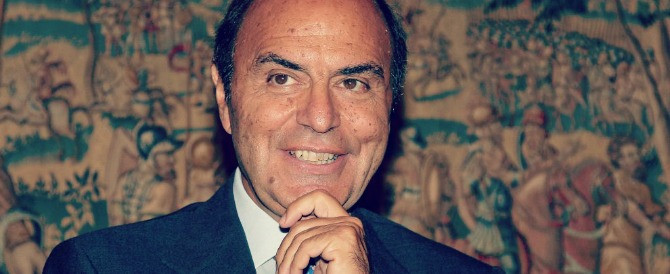I “dettagli” che zavorrano la manovra
Fabrizio Forquet – Il Sole 24 Ore
A quattro giorni dall’approvazione della legge di stabilità in Consiglio dei ministri, ancora nessun testo più o meno ufficiale è disponibile. Non è forse una novità, è però certamente un malcostume che non aiuta la credibilità del modo in cui in Italia si fanno le leggi. Viene da chiedersi, per dirne una, che cosa sia stato mandato a Bruxelles e che testo stiano analizzando i tecnici della Commissione in vista del giudizio di fine mese. Ieri sera da Palazzo Chigi si è fatto trapelare che per domani un testo sarà pronto per il Quirinale, non rimane che attendere. Intanto dalle bozze che stanno circolando si possono cominciare ad analizzare alcuni aspetti tecnici che dalle prime slide non erano emersi. Resta, allora, confermato il giudizio complessivamente positivo di una manovra a carattere espansivo, che dà e non toglie, in una fase di risorse più scarse che mai. Una manovra che taglia tasse e riduce (o almeno prova) spesa pubblica improduttiva. E tuttavia i nodi che meritano un approfondimento, e magari un ripensamento in Parlamento, non mancano.
Il taglio dell’intera componente lavoro dalla base imponibile Irap (che vale intorno ai 6 miliardi) è uno dei risultati più importanti di questa manovra. Impossibile sottovalutarne il peso, in termini effettivi di risparmio per le aziende e in termini di fiducia nella creazione e nella difesa di posti di lavoro. La copertura della misura è però garantita per una parte (2,1 miliardi) dal dietrofront rispetto alla riduzione del 10% dell’aliquota Irap stabilita con il decreto Irpef del maggio scorso. L’aliquota ordinaria Irap, dunque, tornerà dal 1° gennaio prossimo al 3,9% (dal 3,5%). Va anche considerato, poi, che – sempre in base alle bozze disponibili – il taglio previsto dalla Legge di stabilità si limita al costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, escludendo i lavori a termine e i collaboratori. Tutto questo significherà che talune aziende, quelle che non hanno o hanno pochissimi dipendenti stabili, saranno – per effetto della manovra – penalizzate. Per tutte le aziende, poi, viene meno la deduzione dell’Irap dall’imponibile Ires: questo è ovvio, ma riduce ulteriormente la portata – comunque positiva – del taglio dell’Irap.
Anche la cancellazione dei contributi per i primi tre anni per chi assume a tempo indeterminato è una misura che va nella giusta direzione di creare incentivi per le imprese a creare posti di lavoro stabili. Gli sgravi, tuttavia, valgono solo per le assunzioni effettuate nel 2015 e per chi non ha lavorato a tempo pieno nei sei mesi precedenti. Non si tratta, dunque, di una misura definitiva, mentre va a sostituire un beneficio permanente che è quello previsto dalla legge 407 del 1990, in base alla quale i disoccupati da oltre due anni potevano essere assunti a zero contributi (o con il 50%) per un triennio. Salta anche lo sconto contributivo legato alla prosecuzione di un anno dei contratti di apprendistato dopo il triennio. La cancellazione dei contributi prevede inoltre un tetto annuo di 6.200 euro. Questo significa che potranno giovarsi dell’abbattimento totale solamente i contratti che sono intorno alla soglia retributiva limite, per tutte le altre retribuzioni lo sgravio sarà parziale. Non basta. L’incrocio tra tetto e somme stanziate permette di stimare in 161mila le possibili assunzioni annue, molto meno di quelle stimate dal Governo. Senza considerare, infine, il tentativo di una parte del Pd di far inserire nel testo la clausola che, se il rapporto di lavoro si interrompe prima dei tre anni, l’imprenditore sarebbe costretto a pagare tutti i contributi arretrati. Un modo per rendere più incerto l’incentivo e ridurre la spinta che può venire dalla misura.
Contraddittoria con la linea affermata dal Governo nel Jobs act appare anche la scelta di tagliare 200 milioni al Fondo che incentiva la contrattazione aziendale. Sulla scarsa convenienza fiscale del Tfr in busta paga per chi ha redditi oltre i 15mila euro e sui rischi per la liquidità delle imprese è già stato detto tutto. Va però anche segnalato il rischio di un ulteriore aggravio di procedure burocratiche per le aziende, legato alla certificazione Inps e alla pratica con la banca. Sui tagli di spesa vale la pena soffermarsi. In riferimento a Regioni e Comuni non si può che essere d’accordo con Renzi: i governatori hanno tutta la possibilità di far fronte ai tagli attraverso una maggiore efficienza della spesa ed eliminando gli sprechi. Vi sono Regioni (analisi di Gianni Trovati sul Sole di ieri) che, per il proprio funzionamento, spendono 192 euro pro-capite contro altre che si limitano a 22; Regioni che hanno una spesa corrente di 619 euro pro-capite a altre che si fermano a 275; Regioni che spendono per il personale 174 euro e altre solo 12. Gli spazi per l’efficienza e i risparmi, dunque, ci sono, eccome.
Ma è sui ministeri che il Governo deve dimostrare di saper fare la propria parte. In una tabella preparatoria della manovra sono indicati tagli molto specifici per oltre 3 miliardi, missione per missione, nella logica (quasi) di una vera spending review. Nella bozza della legge a oggi disponibile, quei tagli – come hanno raccontato sul Sole Marco Rogari e Marco Mobili – si riducono a poco più di 1,4. Cosa ne è di tutto il resto? Ci si piegherà ancora una volta alla logica degli interventi lineari, limitandosi a indicare l’obiettivo del 3% di riduzione? O si recupererà quella tabella voce per voce, magari con i dovuti aggiustamenti? Tra i due metodi c’è tutta la distanza che passa tra un Governo che si prende le proprie responsabilità e uno che demanda ad altri le scelte impopolari.
Sull’azzardo di mettere tra le coperture le stime della lotta all’evasione Il Sole-24 Ore si è soffermato tante volte, ma va anche detto che il Governo questa volta ha prudentemente messo da parte una riserva di 3,4 miliardi che può tornare utile, in questo senso, anche nella trattativa con l’Europa. Sul credito d’imposta alla ricerca si parte solo da 260 milioni, una cifra certamente insufficiente e si lega l’incentivo esclusivamente agli incrementi di spesa, anziché al volume complessivo degli investimenti, come chiedevano le imprese. Viene inglobato, tra l’altro, il bonus oggi esistente per l’assunzione dei ricercatori. È francamente poco per riattivare gli investimenti privati. Lo sconto Irap, certamente, dovrebbe fare di più. Ma quello che manca del tutto in questa manovra sono gli investimenti pubblici. Gli 1,7 miliardi che (come racconta Giorgio Santilli a pagina 2) il Governo ha reso disponibili in questi giorni in attuazione dello “Sblocca-Italia” sono utili, ma sono una goccia. Laddove il mare non può che essere, per un Paese con le nostre difficoltà di finanza pubblica, un mare europeo. Renzi ha più volte invocato una maggiore concretezza per il piano Juncker. Ma anche quando si parla di investimenti europei c’è una fondamentale responsabilità nazionale, che è quella di fornire buoni progetti.
L’Italia in questi anni è mancata totalmente in questa sfida: pochi buoni progetti e pochissima capacità di trovare il matching con i finanziamenti. In questi giorni finalmente c’è un tavolo governativo (coordinato da Del Rio e Pagani per conto di Padoan) che sta lavorando con gli uomini della Bei proprio per individuare i progetti possibili. C’è da augurarsi che produca risultati concreti. Perché non c’è dubbio che – come ha sottolineato il Governatore Visco proprio ieri nel suo intervento a Bologna – il rilancio dell’occupazione e della crescita può passare solo attraverso una ripresa degli investimenti. In attesa, certo, del testo definitivo della manovra.