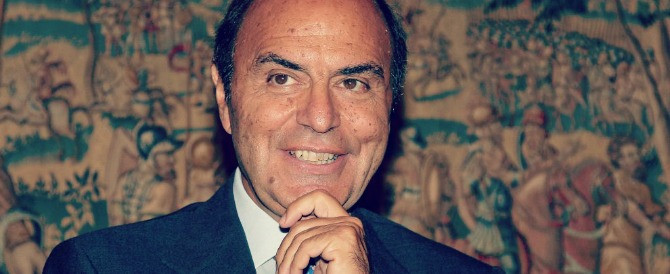Reti e scalate
Davide Giacalone – Libero
La storia di Telecom Italia può essere raccontata come metafora del disfacimento industriale e della degradazione italiana. Una storia che comincia durante il fascismo, con il primo grande errore dei miopi capitalisti nostrani, i quali comprarono volentieri la gestione del traffico locale, ma non vollero quello di lunga distanza, considerato poco profittevole. Fu poi quello più ricco. Proseguì con passaggi eroici e commoventi, come i cavi transatlantici posati a cura di una società, Italcable, finanziata con i risparmi dei nostri emigranti. Venne poi il capitolo della ricostruzione e dell’ammodernamento, con un salto tecnologico epocale, a cura di società facenti capo all’Iri, quindi allo Stato. Amministrate dai così detti “boiardi”, accusati di gestioni anche clientelari, ma che lasciarono società forti, evolute e ricche. Quindi si passò alla distruzione, con la peggiore privatizzazione immaginabile. Ai corsari che scaricarono sui gioielli le scorie organiche dei loro debiti, capaci d’impiombare i conti della società. Quindi l’intervento delle banche e l’ingresso del socio spagnolo. Ora gli spagnoli si sono rotti l’anima e le banche sono in fuga, mentre si annuncia l’ipotesi di una nuova scalata, dall’estero. A parte conoscere la storia e comprenderne le miserie, qual è, oggi, l’interesse collettivo? Come si può farlo valere?
L’interesse dell’Italia, oramai, non è quello di discutere la nazionalità degli azionisti. Purtroppo, finita l’era dell’Iri, sia detto con molteplice dolore, gli italiani si sono dimostrati i peggiori. Almeno fin qui. Il nostro interesse è che le telecomunicazioni siano sviluppate e tecnologicamente aggiornate, senza che altri soldi dei contribuenti (e dei clienti) siano trasferiti nelle tasche degli avventurieri e dei predatori. Sulla rete esiste ancora un diritto pubblico, incarnato nella goldenshare, nascente non solo dalla rilevanza nazionale di quell’infrastruttura, ma anche da fatto di essere stata realizzata con soldi pubblici. Quel diritto va esercitato non per decidere chi deve essere l’azionista, ma per costringere la società a non indebolire l’Italia fornendo un servizio al di sotto degli standard europei. Va esercitato non per limitare la concorrenza, ma per renderla più libera e forte. Poteva andare diversamente, ma oramai è andata.
Le scalate possono destare l’interesse di un pubblico che le segue come fossero avventure di cavalieri erranti, o di chi, legittimamente, spera di trarne un profitto in Borsa. A noi interessa altro: che chi controlla e amministra la società lo faccia sì per trarne profitto, ma da perseguirsi non succhiando ricchezza dagli abbonati, ma investendola per offrire loro servizi al passo con i tempi. E non ci siamo. Lo Stato non deve tornare a fare l’azionista. Non per ragioni ideologiche, ma perché il mondo è cambiato. Lo Stato deve cominciare a fare bene il suo mestiere: dettare le regole e farle rispettare. Facendosi rispettare nella sede in cui gran parte delle regole sono dettate: l’Unione europea. Il che significa evitare di credere che per assicurarsi un futuro si debba tornare al passato, con i soldi della Cassa depositi e prestiti, che sono soldi degli italiani, usati per ricomprare quel che è stato fatto con i soldi degli italiani, ovvero la rete. Tanto più che nella sua società delle reti la Cdp ha preso non soci finanziari, ma soci industriali che sono potenziali concorrenti delle reti italiane. Né serve a nulla dire che la governance rimane in mani italiane, o ci rimane la maggioranza delle azioni, perché nel mercato contano i soldi e la capacità di farli fruttare, il che scatena forze non certo arginabili con qualche nominato cui è già stata data abbastanza ricchezza perché possa andarsene a goderne i frutti.
Dal male può venire il bene, se non ci si ostina a far confusione fra i due. Meglio un mercato libero di crescere e uno Stato libero di controllarlo e sanzionarlo, piuttosto che la melassosa commistione di un mercato impastoiato con la politica e uno Stato prigioniero degli interessi che dovrebbe sovrastare. Anziché fare dichiarazioni spiritose o giocare al piccolo ministro, il personale di governo farebbe bene a dedicarsi alla sola cosa utile che può essere fatta: chiarire a tutti i tempi e le modalità in cui ciascuno deve investire nelle reti e nei servizi, in modo da rendere reale l’evoluzione digitale del nostro mercato, avvertendo che chi non rispetterà gli impegni pagherà pegno.