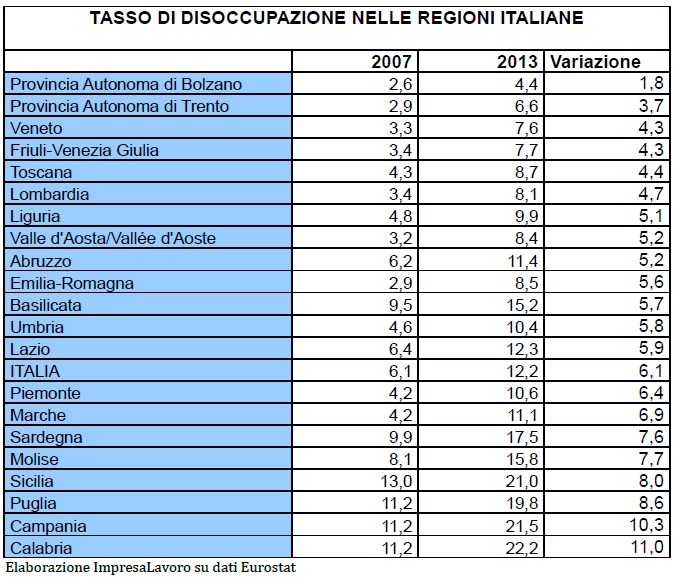Donne, management e mercato del lavoro
di Giuseppe Pennisi
Nonostante la loro elevata qualità, i paper del Dipartimento del Tesoro (Direzione Generale Analisi Economica) del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono relativamente poco conosciuti, rispetto, ad esempio, il vero e proprio fiume in piena dei lavori del servizio studi della Banca d’Italia. Sono utili anche in quanto rappresentano un input alla politica economica. Per riceverli, basta iscriversi al mail dt.research@tesoro.it da dove vengono inviati con cadenza mensile.
Non trattano solo di argomenti di finanza pubblica e simili, ma anche temi di più vario rilievo di politica economica. Ne abbiamo scelti due che riguardano il tema di donne in posizioni manageriali in Italia oggi – materia sempre incandescente e dove analisi asettiche sono particolarmente utili.
Uno dei due riguarda la discriminazione vera od apparente di donne manager. Il titolo è eloquente: “Are women in supervisory positions more discriminated against? A multinomial approach”. Ne sono autori Marco Biagetti e Sergio Scicchitano, i quali utilizzano un approccio a due stadi. In un primo stadio esaminano se differenze di genere incidono su stipendi e carriere di lavoratrici in posizioni non dirigenziali. In un secolo quello di donne a vari livelli di management. È un’analisi statistica empirica tramite una procedura statistica raffinata. Le conclusioni possono sorprendere: ai livelli non dirigenziali le differenze salariali e i segni visibili di discriminazioni aumentano con il passare degli anni (se non sono promosse a gradi direzionali). Diminuiscono invece se riescono a diventare dirigenti. Tuttavia, c’è un processo di “selezione negativa” che rende molto difficile salire il gradino.
L’altro lavoro, sempre di Sergio Scicchitano (“Exploring the gender wage gap in the managerial labour market: a counterfactual decomposition analysis”), evidenzia invece, sulla base di una ricca documentazione statistica, come il divario di genere, persista ai livelli manageriali, principalmente in termini di retribuzioni, ed abbia la forma di una U, ossia solo poche donne, una volta entrate nei gradi manageriali, riescono a raggiungere le vette retributive. La gran parte resta nella palude.