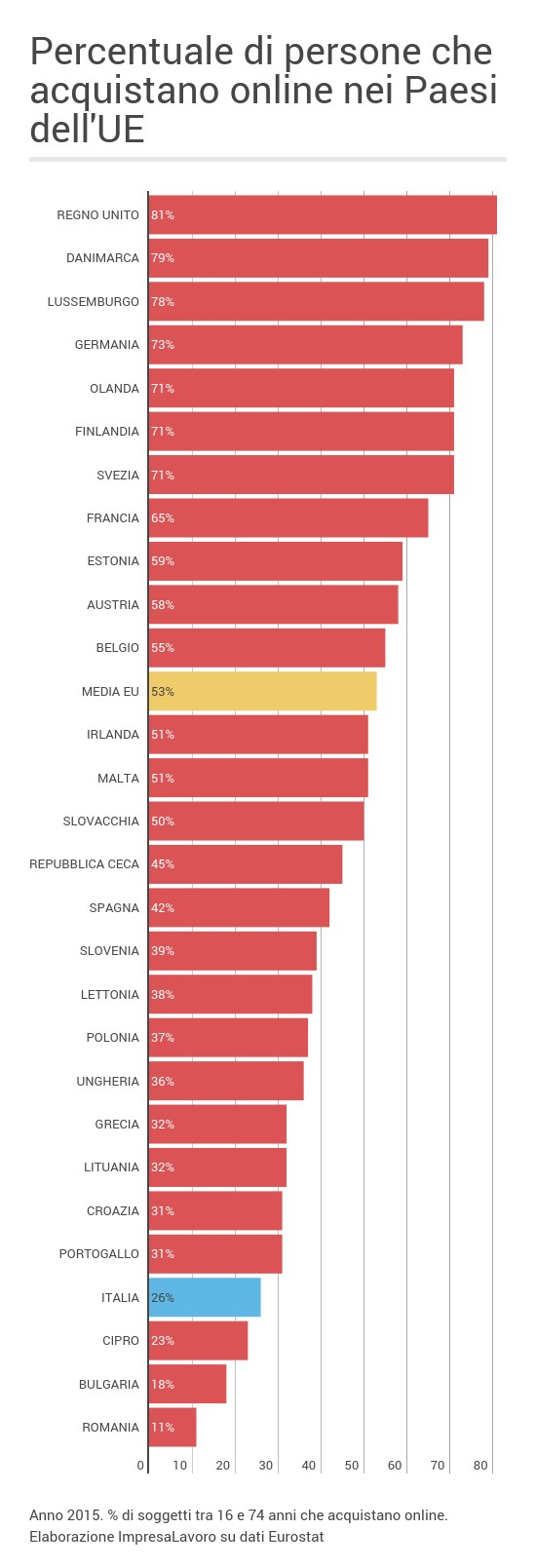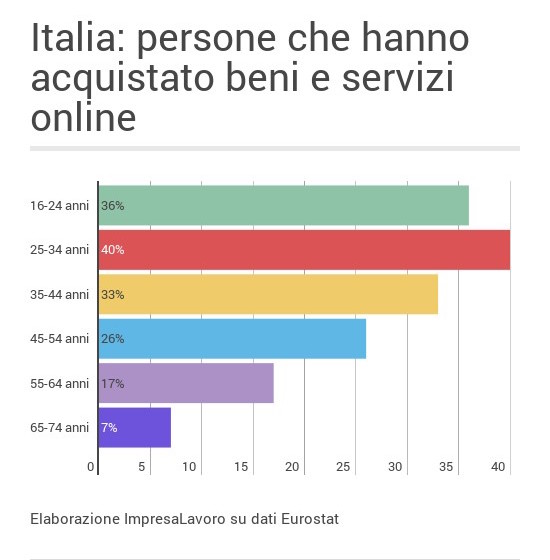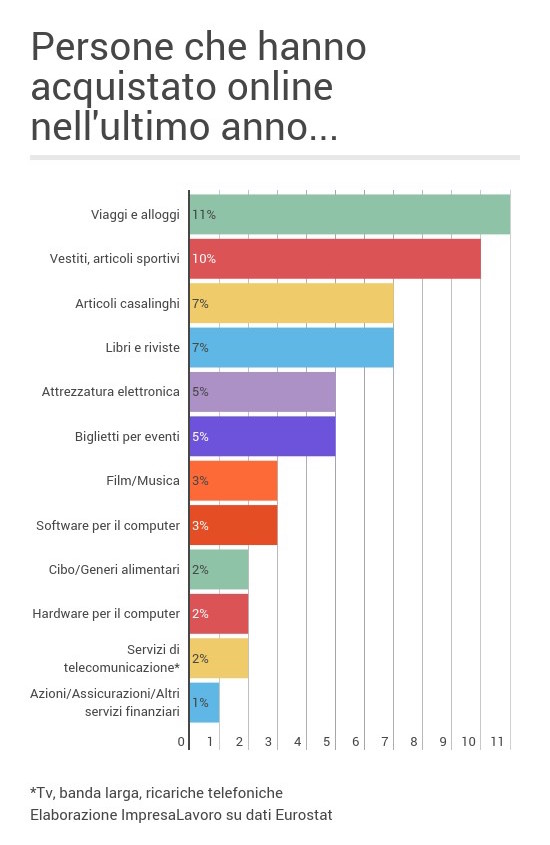Pensioni, dal 2016 le donne dovranno lavorare 22 mesi in più
di Francesca Schianchi – La Stampa
Ventidue mesi di lavoro in più per le donne impiegate nel settore privato, per agguantare la sospirata pensione di vecchiaia. Quattro mesi in più per tutti, come adeguamento alla speranza di vita: si vive più a lungo e allora bisogna anche lavorare più a lungo. E poi, arriva la revisione dei coefficienti necessari per determinare la quota contributiva della pensione: quello che si apre fra pochi giorni è un anno di novità non esattamente piacevoli per quanto riguarda il ritiro dal lavoro.
Per tradurre in esempi la fredda contabilità delle leggi, lo scalino in più che, in base alla legge Fornero, scatterà dal 2016 per le donne lavoratrici del privato, fa sì che potranno lasciare il lavoro per vecchiaia a 65 anni e sette mesi (63 anni e nove mesi sono stati sufficienti nel 2015); per le autonome non prima di 66 anni e un mese, mentre sono già equiparate agli uomini le dipendenti pubbliche. Cioè all’età di 66 anni e sette mesi: gli uomini potranno altrimenti andare in pensione anticipata se hanno versato 42 anni e dieci mesi di contributi; 41 anni e dieci mesi le donne.
Chi sarà particolarmente penalizzato dal meccanismo messo in piedi dalla legge sono le signore nate nel 1953: nel 2018, quando avranno raggiunto il traguardo dei 65 anni e sette mesi, sarà scattato un nuovo scaglione per spostare in avanti l’eta pensionabile (salvo revisioni della legge) e nel 2019 l’asticella dell’età sara spostata ancora più in alto da un nuovo adeguamento alle aspettative di vita. Morale, queste lavoratrici rischiano di potersi mettere a riposo solo nel 2020. Ma questo 2016 è anche l’anno scelto per far scattare i nuovi coefficienti di trasformazione, ossia quelli che servono per trasformare i contributi versati in assegno: nemmeno questa è una notizia allegra, se si considera che tra 2009 e 2016 l’importo calcolato col contributivo, prendendo a riferimento come età di uscita i 65 anni, è diminuito del 13 per cento. E nel 2016, secondo i calcoli di Antonietta Mundo, già coordinatore generale statistico attuariale dell’Inps, riportati dall’Ansa, gli uomini perderanno sulla quota contributiva circa l’1 per cento.
E se queste sono le (fosche) previsioni per le pensioni nel 2016, a tracciare un bilancio degli anni passati, per quanto riguarda invece il lavoro e la crisi, ci ha pensato il Centro studi ImpresaLavoro, partendo da dati Istat: 656.911 sono i posti persi nel periodo 2008-2015, di cui 486mila andati in fumo al sud e nelle isole e 249mila a nord, mentre il centro ha fatto segnare un sorprendente più 78mila, tanto che il Lazio è, insieme al Trentino Alto Adige, l’unica regione che ha visto in questi anni di crisi aumentare gli occupati. Una crisi che, però, secondo la ricerca di ImpresaLavoro, sta forse finalmente allentando la presa: nel terzo trimestre del 2015, sottolinea, c’e stato un aumento di 154mila occupati su base annua.
Nello stesso periodo, 2008-2014, rivela uno studio dell’Istat diffuso ieri, tra gli stranieri, che per il 57 per cento arrivano in Italia per cercare un impiego e per il 29,9 per cento ritengono di svolgere mansioni poco qualificate rispetto al proprio titolo di studio, il tasso di occupazione ha subito un calo molto più accentuato rispetto agli italiani (6,3 punti contro 3,3). E la disoccupazione tra loro è quasi raddoppiata in quei sei anni, facendo registrare un più 7,1 contro il più 5,2 degli italiani.