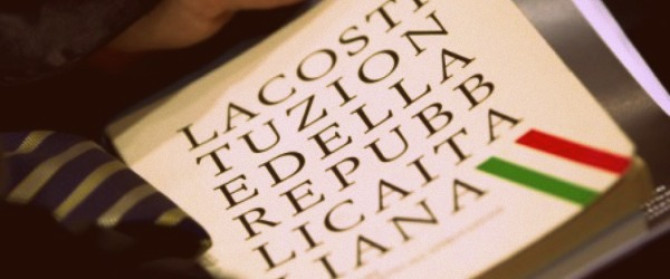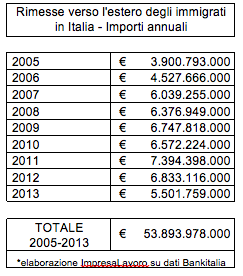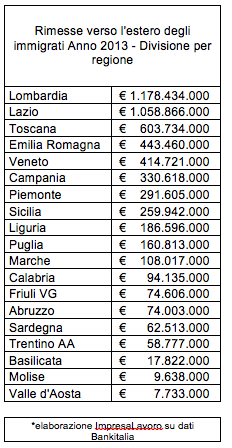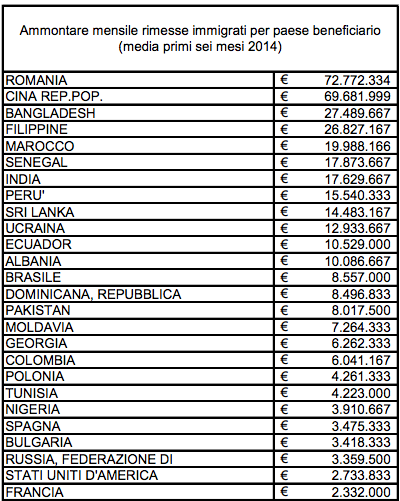Non si usi la Costituzione per difendere l’articolo 18
Andrea Del Re – Corriere della Sera
Il sondaggio di Nando Pagnoncelli (Corriere, 28 settembre) evidenzia che il 53% degli italiani non sa cosa preveda l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Quella norma rimane dunque più un tema della politica che non del sentire quotidiano. Il che conforterebbe l’assunto di quanti sostengono che si tratti di una mera battaglia ideologica. L’articolo 18 si applica a circa un terzo dei lavoratori – chi si trova in imprese sopra i 15 dipendenti (tranne sindacati, partiti, associazioni culturali). Il datore di lavoro sotto quella soglia, in caso di licenziamento illegittimo, se la «cava» con un risarcimento massimo di 6 mensilità, salvo che non venga dichiarato discriminatorio. «Precari» sono dunque, di fatto, tutti i dipendenti, anche a tempo indeterminato, sotto il fatidico numero di 15 assunti.
Vista l’imbarazzante applicazione di certa magistratura, nel 1985 e nel 1987 il «padre» dello Statuto, il giurista socialista Gino Giugni, tentò invano di modificarlo spostando la soglia a 80 dipendenti e 5 miliardi di lire di fatturato. Nel ’90, Dc e Pci approvarono la possibilità per il lavoratore, vinta la causa, di rinunciare al reintegro in cambio di 15 mensilità. Sono rari i casi in cui il lavoratore abbia poi preferito la reintegrazione al risarcimento: il che dimostra l’inapplicabilità dell’art. 18 nella pratica quotidiana. La Consulta, nel ’92, ritenne legittima tale scelta. Nel 2000, la stessa Corte dichiarò l’ammissibilità del referendum per l’abrogazione dell’articolo 18, definendolo una norma dal contenuto non «costituzionalmente vincolato». Il reintegro è solo «uno del modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro»; senza di esso «resterebbe comunque operante la tutela risarcitoria» di cui si sottolineò la «tendenziale generalità». Dai ripetuti pronunciamenti della Consulta, in modo inequivocabile, si ricava che 1’articolo 18 non ha valore di intangibilità costituzionale e può essere sostituito dalla sola tutela risarcitoria – questa sì indefettibile.