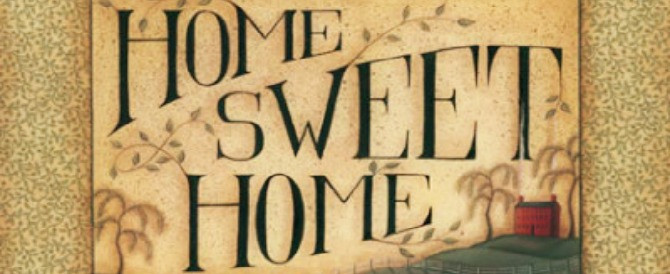Se il fisco manda il scena il teatro dell’assurdo
Il Sole 24 Ore
A volte sembra che il fisco italiano sia al centro di una grande rappresentazione teatrale, seppure con un numero piuttosto ristretto di protagonisti. Facciamo l’esempio di un primo atto, con tre scene ambientate nei primi mesi del 2014.
Gli amministratori di un ente non commerciale (una fondazione, un trust) incontrano il loro commercialista: l’ente possiede una partecipazione in una società italiana che intende distribuire dividendi. Il commercialista non ha dubbi: l’ente tasserà il 5% del dividendo incassato, e dato che l’Ires è al 27,5, il livello di tassazione finale sarà pari all’1,375 per cento. Forti di questa risposta, gli amministratori decidono di dare parere favorevole alla partecipata, che distribuisce i suoi dividendi.
Nella seconda scena, a maggio 2014, una società estera si rivolge a un commercialista italiano per pianificare investimenti produttivi nel nostro paese. Tra le varie domande rivolte al consulente, una riguarda l’Irap. Puntuale la risposta: grazie a un decreto appena entrato in vigore (il Dl 66/14), l’aliquota Irap è ridotta al 3,5 per cento. L’impresa straniera decide di costituire una società in Italia, e inizia a lavorare.
Nella terza scena, è autunno inoltrato. una compagnia di assicurazione contatta gli eredi di un proprio assicurato, appena defunto, beneficiari di una polizza sulla vita. Questi chiedono se dovranno pagare imposte sulle somme che riceveranno e il funzionario della compagnia li rassicura: tutte le somme saranno esenti da imposta.
A questo punto si passa al secondo atto: le cose si capovolgono e tra i protagonisti va in scena un dialogo cosi surreale da far impallidire Samuel Beckett e il suo teatro dell’assurdo.
Prima scena. Siamo agli inizi del 2015. Gli eredi del titolare della polizza hanno appena ricevuto la liquidazione delle somme dalla compagnia di assicurazione, e hanno subìto una ritenuta che non si aspettavano. La compagnia spiega che ha dovuto liquidare l’Irpef su una parte dei capitali. Aveva spiegato loro che erano tutti esenti, e a quel tempo era così; poi, pero,è arrivatala legge di stabilità per il 2015 e ha cambiato le regole. Anche per i contratti stipulati prima del 2015.
Seconda scena. Alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi, gli amministratori della fondazione si presentano dal commercialista, pronti a pagare l’1,375% dei dividendi. Il consulente, però, presenta ben altro conteggio: l’Ires è diventata il 21.3785% dei dividendi, perché la tassazione ora agisce sul 77,74% di quanto percepito. Agli amministratori sbigottiti spiega che non è un errore, e che anche la vecchia risposta non era sbagliata: è la legge di stabilità per il 2015 che ha cambiato la tassazione. Dal 2014.
Terza scena. L’amministratore estero della società costituita in Italia verifica con il consulente il calcolo delle imposte per il 2014 e gli fa notare un piccolo errore: ha applicato l’Irap al 3,9% anziché al 3,5%, dimenticandosi della risposta che lui stesso aveva dato un anno prima. Il consulente ha l’ingrato compito di spiegare a un cittadino di un altro paese che entrambe le risposte sono giuste. Lo farà in modo tecnicamente ineccepibile, argomentando che le aliquote sono state modificate dalla legge di stabilità per il 2015. Dal 2014.
Cala il sipario sullo sconcertante finale. Vladimiro ed Estragone (i personaggi di Beckett) sono ancora in scena a domandarsi cosa sia successo e ad aspettare come sempre Godot, che non arriverà mai. E Godot è un fisco leale che non si permetta di cambiare le regole del gioco retroattivamente, cioè quando i giochi sono già iniziati.