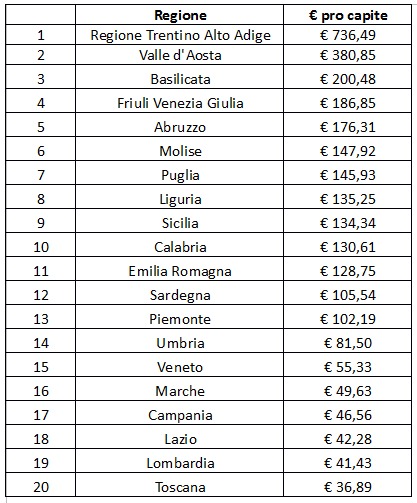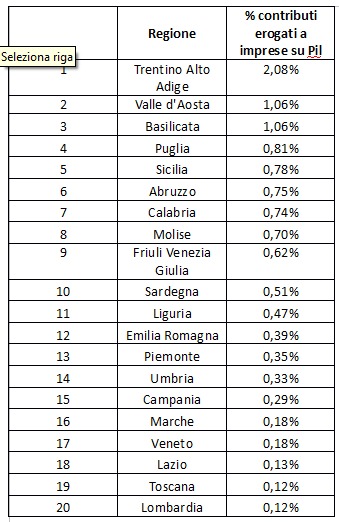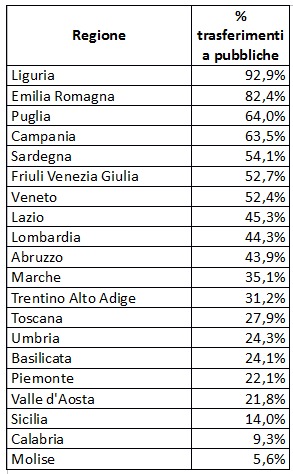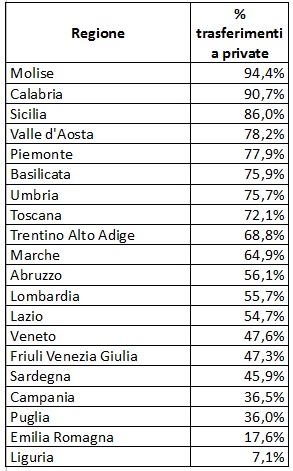Ecco come uscire dall’euro senza far scoppiare l’Europa
Renato Brunetta – Il Giornale
Yanis Varoufakis. Chi è costui? A volte bastano poche parole, per capire chi si ha di fronte. E la descrizione di se stesso fatta nel suo profilo Twitter ci dice chi è il nuovo ministro delle Finanze greco: «Economista, ho scritto testi accademici per anni senza che nessuno si accorgesse di me, fino a che non sono stato spinto nella scena pubblica dall’incapacità dell’Europa di gestire una crisi inevitabile». E noi diciamo, sempre con poche parole: per salvare la Grecia servono 10-15 miliardi. Così come ne bastavano 50 nel 2010, e la storia avrebbe avuto un corso diverso. Ma oggi gli effetti di scelte sbagliate da parte dell’Europa potrebbero avere effetti ancor peggiori di quelli che abbiamo visto negli anni della crisi, perché ai problemi economici e finanziari si aggiungono possibili guerre molto vicine a noi, dall’Ucraina alla Serbia, fino alla minaccia dell’Isis.
Oggi il nuovo governo greco illustrerà il suo programma al Parlamento. L’Europa, ancora tedesca, chiede che sia diverso da quello con cui Tsipras ha vinto le ultime elezioni. Come può un premier appena eletto seguire un programma diverso? Da quello che Tsipras dirà oggi dipenderanno le decisioni dell’Eurogruppo di martedì e del Consiglio europeo di mercoledì. L’Europa si trova a un punto di svolta. Viva l’euro, viva l’Europa. Ma quella amata dai suoi cittadini, non temuta. Non l’Europa emotiva, della deterrenza, dei drammi (anche solo minacciati) o delle costrizioni ma l’Europa solidale, coesa, unita. Non si pone, almeno per ora, il tema dell’uscita della Grecia dall’euro, ma non per questo non bisogna parlarne né sapere come si fa. Finora ha prevalso la vulgata per cui dall’euro non si può uscire, o salta tutto. Invece basta solo attuare bene la procedura, con i tempi necessari. Senza drammi dalla moneta unica si può uscire. E anche la reazione dei mercati può essere meno dura di quanto si immagini.
Lo prevede l’articolo 50 del Trattato, che rimanda, per la procedura puntuale, all’articolo 218. Una procedura tutta burocratica, di ping pong tra le istituzioni europee, che dura 2 anni. Ma lo Stato che ne fa richiesta è considerato fuori dall’Unione da subito, anche nel periodo in cui la procedura è ancora in corso. Amen. Si può uscire dall’euro restando nell’Unione? La dottrina dice che si può. Ci sono 4 vie alternative: referendum sull’euro; uscita unilaterale mediante modifica dei Trattati; recesso dall’Eurozona in base agli articoli 139 e 140 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue); recesso dai Trattati europei secondo il Diritto internazionale. Quest’ultima è la strada più facile, e basta addurre come unica motivazione il cambiamento delle condizioni economiche e politiche rispetto al momento in cui il Trattato era stato firmato. La Gran Bretagna non ha l’euro ma ha indetto per il 2017 un referendum per uscire anche dall’Unione. Non è escluso, pertanto: che si possa uscire dall’Unione senza uscire dall’euro; che si possa uscire dall’euro senza uscire dall’Unione; che si possa uscire contemporaneamente dall’Unione e dall’euro. È un atto di sovranità che, conformemente alle proprie regole costituzionali, ciascuno Stato può fare. Senza drammi.
Azzardiamo con qualche perversa malizia un’ipotesi che potrebbe avere più fondamento di quanto sembra. E se Stati con monete diverse dall’euro (si pensi alla Cina, al Giappone, ma soprattutto agli Stati Uniti d’America, in perenne conflitto con la Germania) decidessero di «appoggiare» l’uscita di uno dei paesi dell’Eurozona dalla moneta unica? Chi ci dice che non riuscirebbero a mantenere calmi i mercati? Poniamo, poi, che questo Stato sia la Grecia, presa da noi ad esempio in quanto molto chiacchierata nelle ultime settimane: se Alexis Tsipras e Yanis Varoufakis dimostrano che uscire dall’euro si può, e che in due, tre anni il paese ricomincia a prosperare grazie a una moneta diversa e senza aver subito traumi, che posizione prenderanno i partiti degli altri paesi dell’Eurozona chiamati a votare, magari nel 2018, come l’Italia?
Avevamo accennato ai Trattati. L’articolo 50 del Tfue recita testualmente: «1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. 5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49».
Chiaro. E l’articolo 218 lo è ancor di più. Ne riportiamo solo stralci: «(…) Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi. (…) La Commissione (…) presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione. (…) Il Consiglio (…) adotta la decisione di conclusione dell’accordo: a) previa approvazione del Parlamento europeo (…) ovvero b) previa consultazione del Parlamento europeo. (…). Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati».
Ecco come si esce dall’Unione europea e, perché no, dall’euro. È scritto nei Trattati. Basta applicarli, se si vuole. E se si è forti/credibili abbastanza per farlo. La decisione è tutta politica. Quanto alla Grecia, siamo sicuri che tutto questo non accadrà. Il «problema» greco è oggi, ancora una volta, drammatizzato in termini di immagine, ma è contenuto nella sostanza dei numeri. Il punto è uno e uno solo: l’Europa non deve di nuovo sbagliare. Non c’è tempo da perdere. Si affronti la questione, con freddezza, subito. O sfuggirà nuovamente di mano. In questo caso il precedente c’è: a ottobre 2009, quando è emerso il buco dei conti pubblici di Atene sarebbero bastati poco più di 50 miliardi per risolvere l’emergenza. Invece sappiamo tutti com’è andata.
Errare è umano, con quel che segue. L’Europa oggi è a un punto di svolta. Non si può più insistere con la filosofia (sbagliata) dei compiti a casa. L’Europa oggi deve cogliere l’occasione per cambiare se stessa, realizzando quelle riforme da anni ormai annunciate, ma ferme al palo: l’unione economica, l’unione politica, l’unione bancaria e l’unione di bilancio. Argomenti che si trascinano stancamente a causa delle resistenze sempre dei soliti paesi. E deve cambiare la mission della Bce, oggi anch’essa troppo condizionata dagli interessi dei partner più forti (leggi: Bundesbank), affinché diventi una vera banca centrale (che funga, cioè, da prestatore di ultima istanza per gli Stati), al pari di tutte le altre principali banche centrali mondiali. E smettiamola, una volta per tutte, di farci del male.