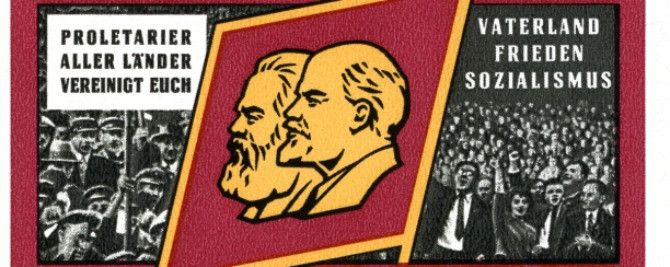La Tasi si mangia gli 80 euro di Renzi
Laura Della Pasqua – Il Tempo
Con una mano dà e con l’altra prende. A pochi giorni dall’appuntamento con il pagamento dell’acconto della Tasi, l’imposta sui servizi indivisibili, coloro che hanno avuto il bonus da 80 euro stanno facendo i conti del bluff. Il bonus se ne andrà in fumo quasi tutto. E una volta pagata la prima rata dell’imposta, nemmeno il tempo di riprendere fiato che ecco arriva la legge di Stabilità. Difficile quindi parlare di rilancio dei consumi quando in tasca di chi ha dovuto spendere gran parte degli 80 euro in tasse. I beneficiari del bonus, lo ricordiamo, non sono in una situazione reddituale privilegiata. Il requisito per accedere alla «paghetta» elargita dal premier Renzi, era di percepire un reddito annuo lordo inferiore ai 25.000 euro. Il bonus è scattato con lo stipendio di maggio. Quindi per fine anno chi è stato «beneficiato» da questo «regalo» avrà percepito circa 640 euro.
Il costo medio della Tasi, secondo i calcoli del centro studi della Uil, ammonta a una media di circa 148 euro (74 euro da versare con l’acconto). Ma se si prendono a riferimento le sole città capoluogo l’importo sale a 191 euro medi (96 euro per l’acconto), con punte di 429, un conto più salato dell’Imu in un caso su due. Pertanto circa due terzi del bonus di 80 euro viene assorbito dall’imposta. A questi record si è arrivati perché la media dell’aliquota applicata dai 105 capoluoghi di provincia è pari al 2,63 per mille (superiore all’aliquota massima ordinaria), anche se «ammorbidita» dalle varie detrazioni introdotte dai relativi Comuni. Ci sono almeno 100mila combinazioni diverse di detrazioni ma se la fantasia è soddisfatta non lo è il portafoglio. Giacchè anche a fronte delle detrazioni il salasso rimane. Secondo la simulazione a Roma si pagheranno 391 euro medi, a Firenze 346 euro, a Bari 338 euro, a Foggia 326 euro, a Como 321 euro, a Trieste 309 euro, a Milano 300 euro, a Monza 299 euro e a Pisa 287 euro. Se all’imposta sui servizi poi si aggiungono la Tari (la tassa sui rifiuti) e le addizionali comunali, il bonus non basta più. Facciamo un esempio. Nel caso di un’abitazione di tipo economico A3 (che è di minor pregio), a Roma, tra Tasi, Tari e l’addizionale comunale Irpef, si pagano circa 1.100 euro. La Capitale si colloca al primo posto nella classifica delle città più tassate. Seguono Bari, con 1.079 euro, Napoli con 1.000 euro e Genova, con 961 euro.
Spulciando le delibere approvate dai principali Comuni capoluogo di Regione in materia di Tari, Tasi e addizionale comunale Irpef è emerso che, in quasi tutte le città, l’addizionale comunale ha raggiunto l’aliquota massima dello 0,8% (Roma applica addirittura lo 0,9%). Solo quattro amministrazioni hanno applicato una aliquota inferiore: Bologna (0,7%), L’Aquila (0,6), Aosta (0,3%) e Firenze (0,2%). Nel caso della Tasi in 9 casi stato applicato il valore massimo consentito per le abitazioni principali: 3,3%. La Tari, invece, colpisce soprattutto al Sud. Nonostante il servizio di raccolta dei rifiuti erogato nelle grandi città del Mezzogiorno non sia sempre «impeccabile», per un’abitazione di tipo civile A2, una famiglia di 3 persone residente a Cagliari paga quest’anno 653 euro. A Napoli 522 euro e a Palermo 497 euro. Quindi in questi casi tutto il bonus basta solo a coprire la tassa sui rifiuti.
Se è vero che il costo della Tasi sarà complessivamente leggermente più basso della vecchia Imu, è anche vero che la distribuzione della nuova tassa è meno equa: pagherà di più chi prima era esente o pagava cifre basse e pagheranno molto meno i proprietari di quelle abitazioni con rendite catastali elevate. Questo vuol dire che sono penalizzati proprio coloro che hanno ricevuto il bonus. L’imposta quindi non è stata concepita con una gradualità tale da favorire i proprietari di immobili di categoria medio bassa. Oltre il danno anche la beffa di vedersi prelevati dal fisco gli 80 euro. Dalle simulazioni fatte dalla Uil emerge che per 1 famiglia su 2 il costo della Tasi sarà maggiore dell’Imu nel 2012. La conclusione è che nel 2014 con la Tasi la pressione fiscale delle famiglie, rispetto al 2013, aumenterà. Gli 80 euro serviranno soltanto ad attenuare la stangata ma non saranno certo soldi che il contribuente potrà destinare ai consumi. Pagate queste imposte, in tasca rimane ben poco o nulla degli 80 euro. In queste condizioni i contribuenti dovranno affrontare l’appuntamento con la legge di Stabilità. Renzi promete che non ci saranno nuove imposte ma aveva anche promesso che il bonus sarebbe servito a rilanciare i consumi.