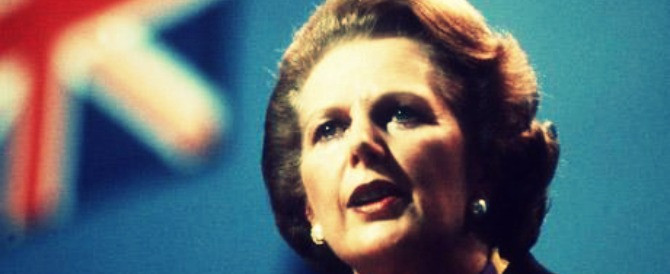Lavoro, le proposte che mancano
Luca Ricolfi – La Stampa
«Care e cari, è il momento delle scelte, chiare, dedicate a creare lavoro». Così Susanna Camusso inizia la lettera con cui invita gli iscritti alla Cgil a partecipare in massa alla manifestazione di sabato prossimo a Roma. La segretaria del primo sindacato italiano ha perfettamente ragione: è il lavoro la priorità assoluta del Paese. E lo è per la semplice ragione che in nessuna parte del mondo avanzato (tranne forse in Grecia) la frattura fra chi ha un lavoro e chi non ce l’ha è così ampia come da noi. Chi lavora, lavora tantissimo, spesso in nero o con il doppio e triplo lavoro, chi è fuori del mercato del lavoro, giovani e donne innanzitutto, ha poche possibilità di entrarci, e pochissime di farlo con un contratto di lavoro «vero», ossia regolare, full time, a tempo indeterminato. Ma c’è anche un dramma nel dramma. Il dramma è che né il governo né il sindacato ci stanno offrendo un piano credibile per creare lavoro.
I due pilastri della ricetta della Cgil sono purtroppo i soliti: aumentare le tasse sui «ricchi», estendere le garanzie dello Statuto dei lavoratori alle piccole imprese. Un’idea, quest’ultima, da cui nel 2002, ai tempi del referendum sull’articolo 18, si era dissociato persino Cofferati. Quanto al governo, spiace dirlo, ma la sua strategia per creare posti di lavoro è scritta sulla sabbia. Il piatto forte è la cosiddetta decontribuzione (non far pagare i contributi sui nuovi assunti), un provvedimento che in questi giorni viene venduto sul mercato dei media ora come capace di creare 800 mila posti di lavoro in 3 anni (il ministro Padoan da Lucia Annunziata su Rai3), ora come capace di «incentivare» 850 mila assunzioni in un anno (il consulente Gutgeld sul Corriere della Sera). Ma si tratta di cifre campate per aria, e ora cerco di spiegare perché.
Prima osservazione: il budget per la decontribuzione stanziato per il 2015, se nelle prossime ore non verrà ancora cambiato qualcosa, è pari a 1,9 miliardi. Il costo dei contributi per un lavoratore a tempo indeterminato a tempo pieno è di circa 10 mila euro l’anno. Questo significa che, con il budget stanziato (1,9 miliardi) il governo è in grado di azzerare i contributi di 190 mila lavoratori, non certo di 850 mila. E infatti, per poter sostenere che potrebbero essere 850 mila, ossia più del quadruplo del reale, Gutgeld è costretto ad arrampicarsi acrobaticamente sugli specchi: molte assunzioni sono a part time, un lavoratore part time costa solo 4.500 euro l’anno di contributi, e comunque non tutte le assunzioni 2015 partono il 1° gennaio, quindi ci saranno anche aziende che richiederanno lo sgravio per pochi mesi. In questo modo, passin passetto, i 10 mila euro di contributi per lavoratore scendono a 2.200, e un budget di 1,9 miliardi riesce, miracolosamente, a «incentivare 850 mila assunzioni». Sembra il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci: visto che i soldi per 850 mila assunzioni incentivate non ci sono proprio, si ricorre al trucco di conteggiare tutto, compresi i rapporti di lavoro part-time e le assunzioni di pochi mesi.
Seconda osservazione: il fatto che un’assunzione sia senza contributi, non garantisce minimamente che a quella assunzione corrisponda un posto di lavoro in più, ossia un posto che, senza quel contributo, non sarebbe mai stato creato. Se gli incentivi sono dati a pioggia, è verosimile che buona parte di essi vadano a coprire assunzioni che vi sarebbero state comunque, ad esempio per rimpiazzare chi va in pensione o cambia azienda; gli incentivi, in altre parole, rischiano di servire solo ad alleggerire i conti delle imprese.
Naturalmente dare una mano alle imprese è più che giusto, dopo anni di asfissia fiscale. Non solo, ma non v’è dubbio che, a fronte di 190 mila assunzioni incentivate, alcune (20 mila? 30 mila?) possano corrispondere a posti di lavoro in più, che senza gli incentivi non sarebbero stati creati. Ma il punto è che questa non è la strada più efficiente per massimizzare la creazione di nuovi posti di lavoro, specie con un budget limitato. Se la priorità è creare posti di lavoro nuovi, che senza gli incentivi non sarebbero mai nati, la via maestra è riservare gli incentivi alle imprese che aumentano l’occupazione, di cui sappiamo che hanno un’elevatissima reattività agli incentivi. La mia stima più prudente è che, con un contratto del genere (Job Italia), in un solo anno si creerebbero almeno 300 mila posti di lavoro che altrimenti non sarebbero mai nati, e si imprimerebbe al Pil una spinta pari ad almeno l’1% (il che, tra l’altro, permetterebbe di coprire i costi della mancata contribuzione).
Lo scenario che si prospetta, invece, pare di tutt’altro tipo. I sindacati, nonostante la generosa apertura di Susanna Camusso al Job-Italia nell’intervista rilasciata l’altro giorno a Francesco Manacorda sulla «Stampa», sembrano intenzionati a dare battaglia su questioni tutto sommato minori, tipo gli annunciati ritocchi alla disciplina dei licenziamenti (articolo 18 e dintorni). Il governo, per parte sua, non sembra rendersi conto che le risorse stanziate per alleggerire i contributi, troppo poche e troppo disperse, non sono in grado, neppure lontanamente, di lenire la piaga della mancanza di lavoro. Così, il dramma nel dramma si perpetua. Tutti parlano di occupazione, ma i tempi della politica sono lentissimi, e il copione, a quanto pare, non è molto diverso da quelli di sempre.