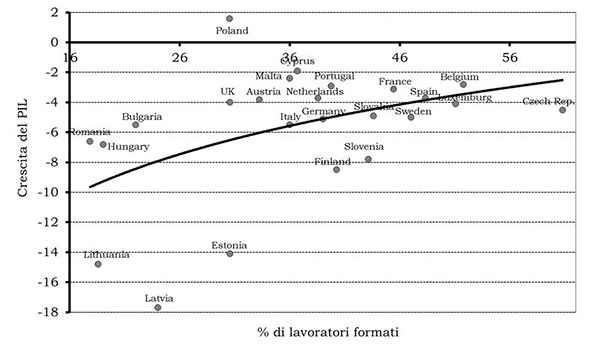Il triste record tricolore: se ne va in tasse quasi mezzo stipendio
Antonio Signorini – Il Giornale
Costo del lavoro sempre più alto e sempre meno soldi in tasca ai lavoratori. Soprattutto per quelli con famiglia. L’anomalia italiana di un cuneo fiscale molto alto non è un ricordo del passato. Nonostante continui proclami dei governi di turno e i tanti richiami da parte degli osservatori internazionali, la differenza tra quanto i datori spendono e l’effettivo stipendio dei dipendenti continua ad aumentare. In totale controtendenza rispetto agli altri paesi occidentali.
Il Centro Studi ImpresaLavoro, presieduto dall’imprenditore Massimo Blasoni, rielaborando dati Ocse, ha calcolato che la somma delle imposte e dei contributi per un lavoratore dipendente single tra il 2007 e il 2015 è cresciuto negli ultimi anni del 2,57%. Il cuneo, cioè la differenza tra il lordo e il netto dello stipendio è arrivato al 48,96% del costo del lavoro.
Gli altri Paesi Ocse hanno imboccato da tempo un’altra strada. La media dei membri dell’organizzazione di Parigi è infatti in calo dello 0,11% rispetto al 2007 e dello 0,72% rispetto al 2000. I Paesi che hanno scelto di rendere il lavoro più conveniente sono economie vicine a quella italiana: la Germania (-2,36%), la Francia (-1,29%) e il Regno Unito (-3,29%). Il cuneo è aumentato anche in altri paesi, ma sempre in misura minore rispetto all’Italia. Negli Stati Uniti (+0,74%), in Australia (+0,65%), in Spagna (+0,57%) e in Canada (+0,36%). Tutti sotto il punto percentuale, osserva il centro Studi ImpresaLavoro.
Il dato peggiora se si prende un lavoratore con famiglia. Nelle coppie sposate con due figli in cui lavora solo uno dei due genitori, per esempio, il cuneo fiscale in Italia è cresciuto del 4,14% rispetto al 2007. Ancora una volta la performance peggiore. Dopo di noi, sempre tra i paesi dell’Ocse, seguono a distanza Giappone (+2,99%), Australia (+2,88%), Stati Uniti (+1,47%) e Spagna (+0/92%). Ancora una volta i partner europei più forti, dimostrano di puntare più di noi sulla competitività e sull’equità. La Germania registra un calo del cuneo per i lavoratori con famiglia del 1,49%, la Francia del 2,00% e il Regno Unito del 2,04%. Va un po’ meglio per le famiglie italiane sposate con due figli nelle quali lavorano entrambi i genitori, con un aumento del cuneo complessivo tra il 2007 e il 2015 che si ferma al 1,55%.
Dati che pongono al governo una sfida complessa. Da un lato quella, antica, che vorrebbe fare recuperare competitività al paese proprio agendo sul cuneo. Quindi tagli al peso del fisco sull’impresa. In realtà il governo ha intenzione di rinviare ulteriormente il taglio dell’Ires, imposta che grava sulle aziende, di un altro anno, per concentrarsi su misure immediatamente percepibili per le famiglie.