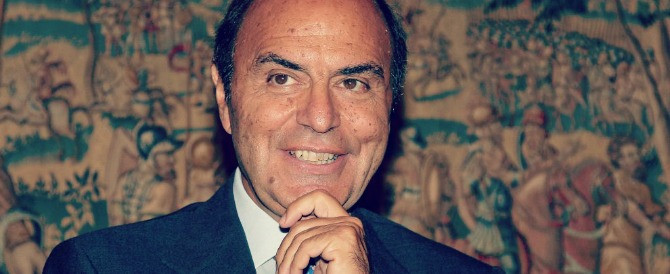Che cosa insegna la lezione americana
Alberto Orioli – Il Sole 24 Ore
Vista dal quartier generale di Auburn Hills, dove la Fca ha recuperato tutta la produzione e l’occupazione in un primo tempo perdute da una Chrysler data per spacciata, la guerra di religione italiana sull’articolo 18 appare ancor più “lunare” di quanto già non appaia a casa nostra nel suo angusto recinto culturale tutto novecentesco. Matteo Renzi e Sergio Marchionne hanno confermato una stagione di consonanza: al premier interessa creare lavoro e guarda a un Paese con un tasso di disoccupazione del 6,1% (da noi è il doppio); al supermanager italo-canadese interessa una chiarezza di strategia e di scelte di sistema che il giovane primo ministro italiano sembra garantirgli. In comune – parole di Marchionne – hanno il coraggio.
È il giorno dell’orgoglio esibito da Oltreoceano. È auspicabile che sia anche quello della consapevolezza. Si comparano grandezze omogenee o almeno commensurabili, per cui può sembrare ingenuo o velleitario accostare la situazione dell’Italia e quella degli Stati Uniti. Ma non lo è quando nelle stesse ore si deve dare conto di un crollo della fiducia delle imprese in ogni settore nel paese europeo e del boom del Pil Oltreoceano. E quand’anche si comparassero due grandezze statisticamente più accostabili, come sono ad esempio l’Europa e gli Usa, le conclusioni non sarebbero molto diverse. Purtroppo.
Questi due dati, pur se parziali e abbinati da un capriccio di calendario, aiutano a fissare, in modo non fallace, il risultato di culture, di atteggiamenti singoli e collettivi, di modelli di sviluppo, di strategie per accrescere e tutelare il capitale umano. E per queste vie rappresentano le scelte per creare fiducia, per investire, per indicare direttrici di sviluppo e di nuova modernità, magari attenta alla sostenibilità dello sviluppo e a una gestione meno selvaggia della globalizzazione. Non si può fare degli italiani altrettanti americani (o tedeschi), ma si può prendere atto delle lezioni che le scelte di quei Paesi offrono a chi le osservi senza pregiudizi. E ha fatto bene Renzi a dire che cambierebbe con gli Usa il modello di istruzione e trasferimento tecnologico ma non quello di welfare. Ma l’Italia non è ancora in grado di sbloccarsi e di usare al meglio il potenziale delle sue energie e risorse. Che la fiducia sia in caduta libera è dimostrato anche dal crollo dei consumi – per nulla scalfiti della pioggia degli 80 euro – dal gorgo della deflazione, dal crollo della produzione e dal primo, drammatico, scricchiolio anche per l’export, in flessione in vari settori dopo anni di crescita continua, unico antidoto alla gelata della domanda interna di un’Italia paralizzata e impaurita del suo stesso futuro. Dagli Usa arriva una lezione su come siano cruciali l’industria, l’innovazione e la flessibilità per ricostruire la fiducia di un intero Paese.
La nuova guerra di religione sul tema sensibile del lavoro che si sta combattendo per l’ennesima volta nel nostro Paese va nella direzione contraria alla fiducia. Se ne parla poco, ma anche negli States esiste in linea teorica il reintegro: ma non lo impone quasi mai il giudice e, soprattutto, non lo considera conveniente il lavoratore che, in genere, monetizza un indennizzo e cerca altre opportunità altrove. Perché lì il mercato – funzionante – lo consente. Ed è questa la vera posta in gioco: creare un mercato del lavoro degno di questo nome in cui la gran parte delle assunzioni siano affidate a contratti a tempo indeterminato flessibile. Superando una concezione assistenziale del welfare, degna più di sudditi che di cittadini-lavoratori consapevoli. E archiviando la stagione del dualismo squilibrato tra gli insider iperprotetti e gli outsider iperflessibili. È un fatto di equità e di efficienza.
Significa una rete di agenzie per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (pubbliche e private in rapporto di sussidiarietà); risorse per gestire formazione per migliorare i curricula di chi perde l’impiego; risorse per garantire un forma di ammortizzatore sociale universale per chi perda il lavoro e si impegni a cercarne un altro. Significa superare le lacune di un federalismo sbilenco che ha destinato alle Regioni la creazione delle agenzie per l’impiego (con drammatici divari territoriali di efficienza) e il tema della formazione, in genere slegato rispetto alle reali esigenze delle imprese che dovrebbero assumere.
Si tratta di un impianto riformista – e la delega in discussione al Senato sembra recepirne l’ambizione, anche se con formulazioni ancora ampie e ambigue – ma ha bisogno di una dote ingente di risorse per funzionare davvero. Invece che dibattere tra i guelfi del sì-articolo 18 e i ghibellini del no-articolo 18 alla ricerca di uno “scambio” pasticciato tra tutele crescenti che abbiano prima o poi anche la “reintegra” sarebbe bene organizzare uno “scambio” tra semplificazione delle regole e dotazione delle risorse per le politiche attive. Anche perché si rischia l’eterogenesi dei fini: una riforma nata per togliere il reintegro per il 5% delle imprese italiane, quelle sopra i 15 addetti, rischia di introdurlo (dopo 5, 7 o 10 anni) per il 100% delle imprese italiane. In sostanza: si estenderebbe invece che ridursi.
La politica attiva è e resta il tema vero per il legislatore. Per le parti sociali, che hanno una storia importante e unica in Italia, l’impegno dovrebbe diventare invece quello di creare e distribuire la produttività. Rimasta finora negletta in questa Italia coperta dalle coltri delle polemiche sui diritti che ha reso impossibile una discussione serena su come creare ricchezza e come allocare gli investimenti. È questa la nuova frontiera di relazioni industriali avanzate, la vera sfida per imprese e sindacati. Negli Usa lo hanno capito. A un passo dal baratro. E si sono salvati. Non è il caso di tenerne conto?