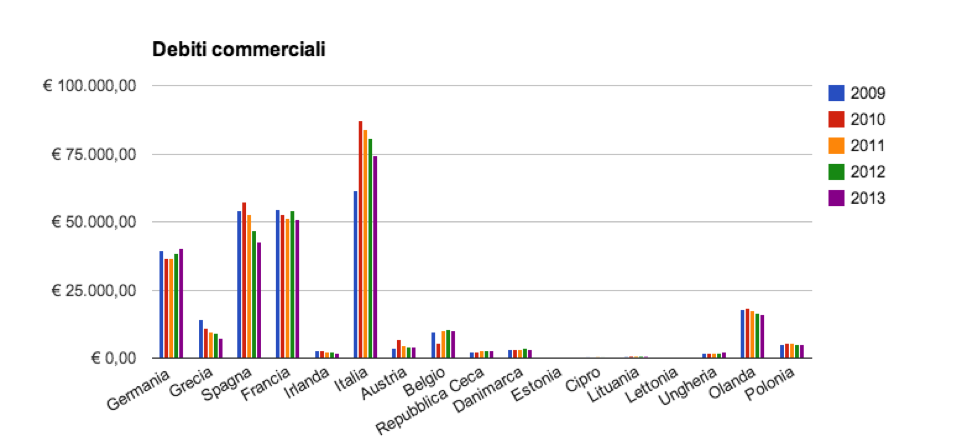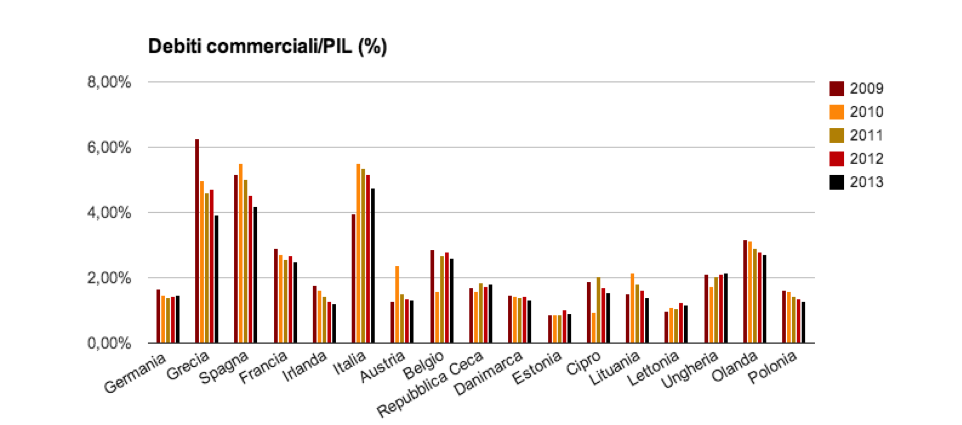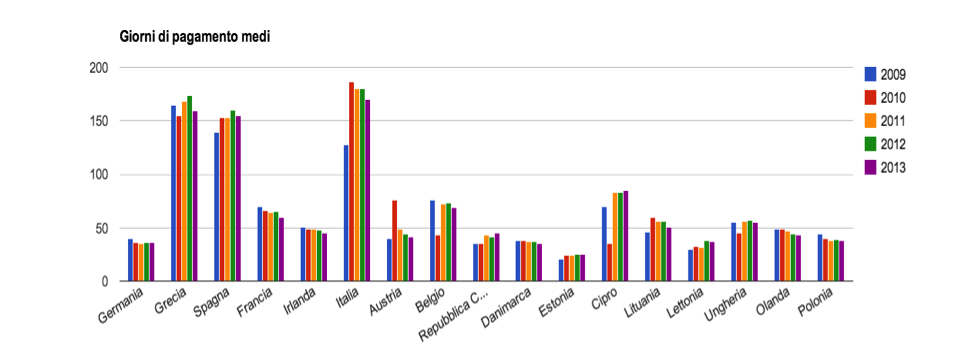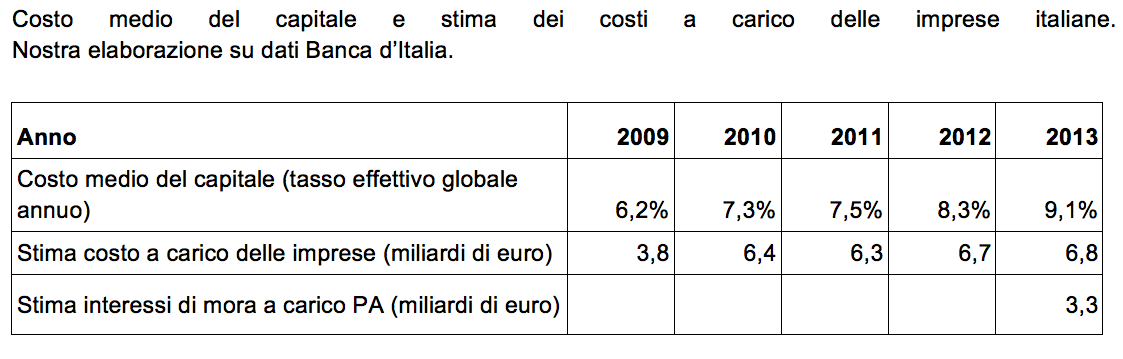L’export non è questione di buona volontà
Antonio Armellini – Corriere della Sera
Le esportazioni italiane tirano, ma non quanto sarebbe necessario, e l’internazionalizzazione del «Sistema Paese» arranca. Il mercato globale richiede tanto una forte capacità di organizzazione da parte delle imprese, quanto una visione strategica da parte dei governi: le parole chiave sono sinergie e gioco di squadra. Come stanno da noi le cose?
L’Italia ha una grande abbondanza di strumenti per il sostegno delle esportazioni. Ci sono le ambasciate, con compiti di supporto generale e di coordinamento; l’Istituto per il commercio estero (Ice) per le analisi di mercato e l’assistenza agli operatori; la Servizi assicurativi del commercio estero (Sace), per l’assicurazione crediti all’esportazione; la Società italiana per le imprese all’estero (Simest), per il sostegno agli investimenti esteri; le Camere di commercio estero. La catena di comando è barocca: ambasciate e Ice fanno capo rispettivamente al ministero degli Esteri e a quello dello Sviluppo economico; di Sace e Simest è stata decisa la privatizzazione e sono entrate nell’orbita della Cassa depositi e prestiti; le Camere di commercio hanno una propria struttura federale. Molti Paesi hanno un numero di strumenti pari, se non superiore, al nostro: essi dispongono in genere di risorse ben maggiori e possono sopportare il peso di qualche ridondanza che, in clima di spending review, non potremmo permetterci. La vera differenza sta nel fatto che, diversamente da noi, la prassi di mettere a fattor comune esperienze e risorse è da tempo consolidata.
Di razionalizzazione si è parlato per anni, ma lo scontro fra incrostazioni burocratiche e logiche corporative ha finito per portare a un nulla di fatto. Nel tentativo di por mano alla situazione il governo Monti ha dato vita a una «cabina di regia per l’internazionalizzazione» che, riunendosi almeno una volta l’anno, dovrebbe fissare le linee strategiche della nostra politica per l’esportazione. L’intenzione è lodevole, ma tradisce il vecchio vizio italiano di affrontare i problemi non già creando linee operative snelle, bensì creando comitati dal carattere consociativo in cui non si capisce bene chi faccia cosa. Alla «cabina di regia» partecipano tutti, dai ministeri alle associazioni industriali, dalle autonomie alle Regioni: quello che ne viene fuori è un’azione informativa magari utile ma non certo una indicazione effettiva di priorità.
Lasciando alla «cabina» la sua funzione di cornice, sarebbe urgente stabilire una linea di comando univoca all’interno: oggi, come detto, essa è divisa fra due ministeri, costantemente tesi alla reciproca sopraffazione, mentre il rapporto con le istituzioni finanziarie – Sace e Simest – rimane in un limbo affidato alla buona volontà dei singoli. La riforma Monti una tale catena l’ha creata, ma solo per l’estero, affidandola alle ambasciate. Basterebbe eliminare la discrasia fra i due modelli per evitare ambiguità e recuperare efficienza. Non importa tanto a chi debba incombere la responsabilità finale: quel che conta è che – in analogia con quanto stanno facendo i nostri partner – questa sia chiara.
Siamo rimasti uno dei pochissimi Paesi in cui il supporto pubblico all’export è gratuito, o quasi, e la cosa non ha più alcuna ragione di esistere. Quello che è gratis è ritenuto spesso senza valore: succede così che quando il servizio è inadeguato – e la cosa succede, ovviamente – viene accettato come il portato delle carenze del settore, con il risultato di aggravarne le inefficienze. È necessario far pagare le attività di supporto agli operatori, a prezzi di mercato: otterremmo da un lato un miglioramento – necessario – della qualità e, dall’altro, una presa di coscienza del fatto che il supporto pubblico non è una concessione del sovrano ma un diritto del cittadino. Il gioco di squadra non riguarda solo il pubblico. L’«effetto chioccia» comune in tanti Paesi a partire dagli Usa – per cui le grandi multinazionali fanno da traino con le loro commesse a interventi a cascata di piccole e medie imprese che, da sole, non avrebbero alcuna possibilità – è da noi praticamente sconosciuto. I pochi grandi gruppi rimasti – Eni, Fiat (ma l’Iri dei tempi d’oro non era da meno) – hanno sviluppato diplomazie parallele, in autonomia e talvolta in contrasto con quella istituzionale, e l’idea di favorire l’inserimento complementare di altre imprese – quando non appartengano al loro stesso gruppo – non fa parte del loro lessico industriale.
Ci siamo cullati per anni con «piccolo è bello», nella convinzione che la flessibilità delle nostre piccole e medie imprese bastasse a garantirne il successo, ma la sfida della globalizzazione richiede dimensioni adeguate. Le nostre imprese sono perlopiù restie a unire gli sforzi, così come da tempo fanno i loro concorrenti, e finiscono spesso per ingaggiare lotte sfibranti fra loro sui mercati esteri per poi cedere, esauste, a concorrenti stranieri che hanno saputo consorziarsi. È stupefacente che il Paese che ha inventato i distretti industriali – nati per sfruttare al meglio le sinergie produttive – non sia stato capace di riprodurre questo modello al di là dei confini della provincia o, al massimo, della regione. C’entrano la nostra storia, la diffidenza nei confronti dello Stato visto come alieno, il peso dei localismi e l’individualismo della nostra società. L’uomo con la ventiquattrore della nostra mitologia industriale ha comunque fatto il suo tempo: potrà ogni tanto mettere a segno qualche colpo, ma andare oltre sarà vieppiù difficile. Pubblico e privato devono imparare a muoversi sempre più in maniera coordinata, per affrontare una concorrenza che non è agguerrita solo nei mercati emergenti, ma anche in quelli dove l’Italia ha occupato tradizionalmente posizioni di forza.