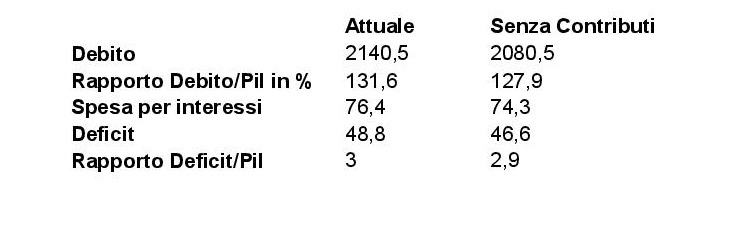L’altra faccia dell’articolo 18
Eugenio Somaini – Europa
La frase di Draghi «il problema non è licenziare ma assumere» si presta a diverse interpretazioni e richiama quella della Sibilla «ibis redibis non morieris in bello», che come è noto poteva essere intesa come «andrai tornerai, non morirai in battaglia» o come «andrai non tornerai, morirai in battaglia». Non sono a conoscenza di studi approfonditi e conclusivi su quale è stato l’impatto dell’articolo 18 sull’occupazione, mi limiterò quindi a qualche considerazione di buon senso.
La prima è che l’esiguo numero dei casi in cui l’articolo 18 è stato invocato e applicato non prova di per sé l’irrilevanza dei suoi effetti concreti: è possibile, e direi addirittura probabile, che la lunghezza dei tempi di decisione dei tribunali e l’incertezza degli esiti della cause abbia dissuaso molte imprese dall’effettuare licenziamenti che avrebbero potuto risultare impossibili e costosi, sia in termini di soldi, sia ancor più in termini di reputazione e di clima sui luoghi di lavoro.
I licenziamenti che l’articolo 18 impediva e che la sua abolizione consente sono quelli che da un lato non hanno giusta causa e dall’altro non hanno carattere discriminatorio o serie motivazioni disciplinari.Ciò che dovrebbe d’ora in avanti essere possibile è licenziare chi lavora poco e male e sostituirlo con chi lavora di più meglio: si tratterebbe di licenziamenti che non avrebbero nulla a che vedere con l’arroganza padronale, le “braghe bianche” evocate da Scalfari con una vena demagogica che finora non gli avevamo conosciuto (che sia un sintomo del populismo dilagante?) e sarebbero dettati solo da ragioni di efficienza e dalla ricerca di una maggiore produttività, qualcosa che andrebbe senz’altro ascritto a merito di un imprenditore. Licenziamenti di questo tipo sarebbero necessariamente accompagnati da assunzioni sostitutive e da guadagni di competitività per le imprese che potrebbero indurre a espansioni della produzione e a nuove assunzioni, questa volta aggiuntive e non meramente sostitutive.
I guadagni di produttività potrebbero anche essere maggiori di quelli immediatamente derivanti dalla sostituzione di un lavoratore scarsamente motivato con uno più capace e motivato ed essere dovuti al fatto che la licenziabilità per scarso impegno o scarsa produttività dovrebbe determinare in tutti reazioni che vanno nel senso di una maggiore produttività, tali effetti potrebbero prodursi anche senza alcun licenziamento, in quanto la licenziabilità dovrebbe indurre molti a mutare la propria condotta e ad abbandonare comportamenti che prima non erano soggetti a sanzioni ma che nel nuovo regime potrebbero portare alla risoluzione del rapporto di lavoro (ovviamente con il pagamento del dovuto risarcimento).
In sostanza è plausibile supporre che l’abolizione dell’articolo 18 produca col tempo effetti benefici attraverso due canali: quello della sostituzione, con licenziamento, di lavoratori poco produttivi con lavoratori più produttivi, e quello dell’incentivo a una maggiore produttività, che non potrebbe non trovare riscontro anche in un aumento delle retribuzioni. L’inconsistenza dei timori talvolta espressi che l’abolizione dell’articolo 18 porti allo scatenamento di impulsi antioperai del padronato risulta evidente alla luce del fatto che i licenziamenti da essa consentiti comportano oneri significativi in termini di risarcimenti che equivalgono alla retribuzione di lavoro che non viene prestato, una circostanza che dimostra come il problema del licenziamento sia ancora considerato soprattutto dal punto di vista del lavoratore.
Un ulteriore effetto positivo potrebbe riguardare l’immagine che gli stranieri hanno del mercato del lavoro e della giustizia italiana in materia di lavoro, un’immagine che per certi versi è probabilmente caricaturale e che può essere dissipata solo da misure che abbiano anche una valenza simbolica, valenza che, a torto o a ragione, l’articolo ha certamente acquisito anche grazie alla strenua e demagogica difesa che ne viene fatta, una difesa che sembra fatta apposta per dare a quella caricatura una credibilità che altrimenti le farebbe difetto.