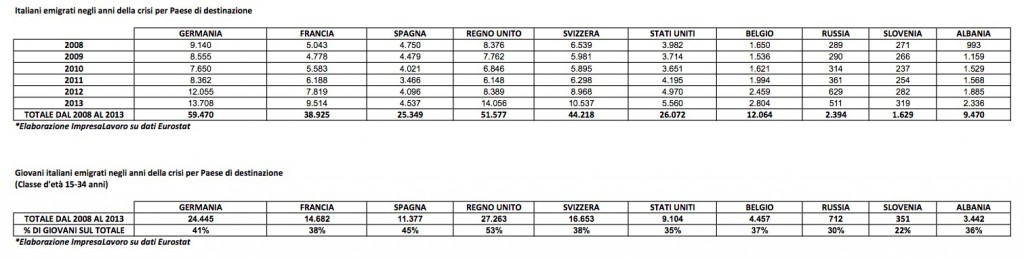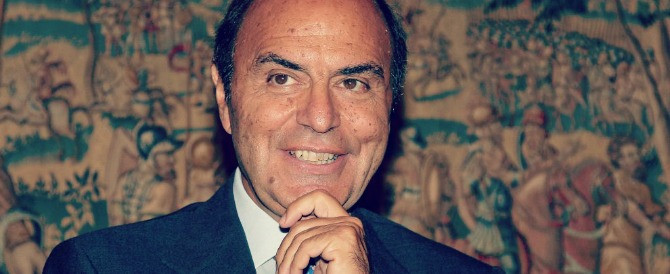Pil: Italia sotto la media europea per 14 anni consecutivi
Per il 14° anno consecutivo, il Pil italiano è cresciuto a un ritmo inferiore rispetto alla media europea. È questo il risultato più significativo di una ricerca elaborata dal centro studi ImpresaLavoro su dati OCSE. Dall’introduzione della moneta unica ad oggi, questa differenza di ritmo di crescita (o di decrescita) è oscillata tra il minimo del 2010 (0,4%) al massimo del 2012 (2,3%), anno nel quale – a fronte del -2,8% fatto registrare dal Prodotto interno lordo nel nostro Paese – la media Ue si è fermata al -0,5%.
Comparando invece l’andamento del Pil italiano con quello tedesco, è interessante notare come, negli anni immediatamente successivi all’introduzione dell’Euro, l’Italia sia cresciuta a un ritmo più sostenuto della Germania. Dopo una serie di riforme strutturali coraggiose (ed efficaci) messe in campo dal governo di Berlino, però, la tendenza si è bruscamente invertita. E dal 2006 ad oggi l’andamento del Pil tedesco è stato nettamente superiore a quello del nostro Paese, con la sola eccezione del 2009 (Italia -5,5%; Germania -5,6%). Negli ultimi dieci anni, mentre l’Italia ha perso in media 4 punti decimali di Pil all’anno, la Germania ha fatto registrare un più che dignitoso +1,4%.
Con un ritmo di crescita del Prodotto interno lordo come quello degli ultimi anni, la strada per far tornare l’Italia ai livelli pre-crisi sembra ancora molto lunga e incerta. Fatto 100 il Pil reale delle economie occidentali più avanzate nell’ultimo trimestre del 2007, solo Italia e Spagna sono ancora al di sotto dei livelli precedenti al terremoto finanziario. Francia e Germania sono “emerse” già nel primo trimestre del 2011; nel penultimo trimestre dello stesso anno è arrivato il turno degli Stati Uniti; mentre il Regno Unito ha dovuto aspettare fino al secondo trimestre del 2013. Mancano all’appello, dunque, solo Italia e Spagna. Ma quest’ultima negli ultimi due anni sembra avere decisamente invertito la tendenza negativa, per tornare a crescere a ritmi molto più sostenuti di quelli italiani. Tanto che, nell’ultimo trimestre del 2015, il Pil reale spagnolo ha ormai raggiunto il 95,8% di quello pre-crisi, mentre nel nostro paese siamo ancora fermi al 91,8%, più o meno la stessa percentuale a cui siamo inchiodati dal primo trimestre del 2013 (quando la Spagna era al 91,2%).
Ci aspetta dunque una strada lunga e in salita. Ma quanto lunga? Dipenderà, naturalmente, dal tasso di crescita del nostro Pil nel prossimo futuro. Con una crescita annua dello 0,8%, come quella del 2015, l’Italia dovrà aspettare fino al 2026. Crescendo invece a ritmi compresi tra l’1,3% e l’1,6%, con numeri analoghi a quelli delle previsioni – molto ottimiste – elaborate dal governo italiano, l’economia italiana tornerebbe ai livelli pre-crisi tra il 2021 e il 2022. Ma sulle previsioni dei governi, è cosa nota, bisogna sempre procedere con estrema cautela.