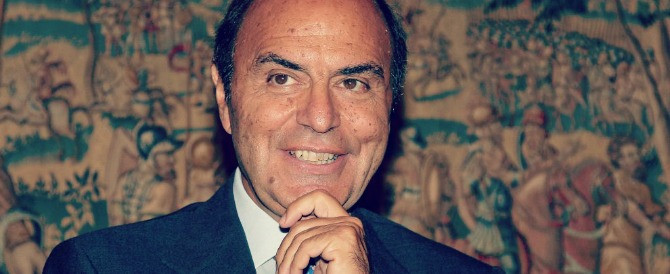“Tutto sul conto corrente”, con la sfiducia boom di risparmi
Giuseppe Bottero – La Stampa
Paradossi della recessione: il denaro è poco e gli italiani che temono di impoverirsi si tengono sempre più stretti i loro risparmi. Risultato: i soldi depositati in banca lievitano e i consumi crollano. Dall’inizio della crisi la liquidità delle famiglie è cresciuta di 234 miliardi arrivando – nel marzo di quest’anno – a 1209 miliardi di euro dai 975 del 2007. È il trionfo (amaro) delle formiche, spiega un’analisi del Censis: i risparmiatori ormai sono l’azienda più liquida d’Italia.
È l’effetto della paura: dal secondo trimestre del 2012, infatti, si è registrato una inversione di tendenza nella creazione di risparmi, che dopo anni hanno ripreso un trend crescente, passando da 20,1 miliardi a 26 miliardi di euro nel primo trimestre del 2014, con un incremento del 26,7% in termini reali. La propensione al risparmio è salita dal 7,8% al 10%, pure a fronte di una riduzione, nello stesso periodo, dell’1,2% del reddito disponibile e nonostante la bassa inflazione abbia attenuato la caduta del potere d’acquisto.
Meno redditi, meno investimenti: il trend fotografato dal Censis allontana la data del rilancio. I soldi servono a fronteggiare difficoltà inattese e sentirsi tranquilli, ma il timore di cadere, dicono i ricercatori, «rischia di diventare paranoia». Il 33% degli italiani teme di diventare povero, e solo il 30% sente di avere le spalle coperte dal sistema di welfare, mentre la percentuale sale al 58% in Spagna, 61% nel Regno Unito, 73% in Germania e 74% in Francia. In un contesto cosi difficile, con investimenti e occupazione che non ripartono, gli italiani pensano sia essenziale proteggersi in caso sopravvenga una malattia, la perdita del lavoro o semplicemente un imprevisto. Il 44% risparmia per far fronte ai rischi sociali, di salute o di lavoro, il 36% perché è il solo modo per sentirsi sicuro, il 28% per garantirsi una vecchiaia serena.
La crisi di fiducia – ragionano dal Censis – spinge a usare i soldi a scopo precauzionale, cosi vince la difesa dalle insidie inattese, piuttosto che lo slancio verso l’investimento che rende nel tempo o l’immissione nel circuito virtuoso dei consumi. Avere liquidità disponibile ha continuato ad essere la scelta primaria di tutti, anche di chi, a caccia di buoni rendimenti, è tornato progressivamente a mettere soldi nel risparmio gestito e nelle azioni, dopo il crollo degli interessi sui titoli del debito pubblico. Le consistenze delle quote dei fondi comuni hanno ricominciato ad aumentare dal secondo trimestre del 2012: +82 miliardi di euro al marzo 2014, con una crescita in termini reali del 31%. Le azioni, invece, sono ripartite un anno dopo, dal secondo trimestre del 2013: +140 miliardi di euro al marzo 2014, con una crescita del 17%.