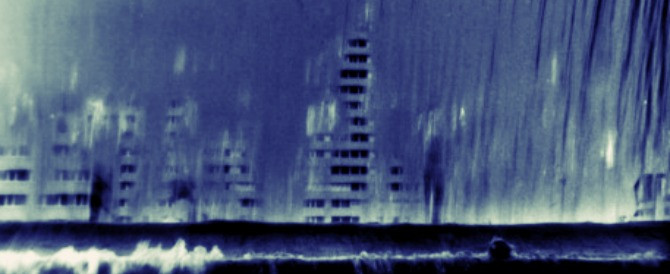Il diluvio fiscale
Il Foglio
Ieri proprietari e inquilini hanno pagato la seconda rata dell’Imu sulle seconde case e sugli immobili in affitto (o sfitti ma abitabili) e la Tasi sull’abitazione principale. Se hanno la partita Iva hanno pagato la rata in scadenza, mentre entro il 29 dicembre verseranno l’acconto per il periodo seguente. Da poco hanno pagato il conguaglio dell’Irpef. Insomma sono tempi di diluvio fiscale. Il ministero dell’Economia si attende un gettito di 23,7 miliardi per quest’anno derivante soltanto dalle tasse sugli immobili (Imu più Tasi). Quest’ultima è la porzione più onerosa perché si aggiunge a una imposta personale sul reddito che ha una pressione che si colloca al vertice di quelle della zona euro.
In questo quadro, c’è quantomeno la necessità di rendere semplice, chiaro e certo l’onere tributario. Attualmente fra Imu e Tasi ci sono quattro pagamenti semestrali, due di acconto e due a conguaglio, con aliquote incerte e complicate. L’introduzione di una local tax, con l’accorpamento di Imu e Tasi entro il 2015, è stata rimandata: la legge di stabilità ha congelato le forchette delle aliquote dei due tributi, ma ciò non scongiura nuovi aumenti. Infatti potranno deciderli i Comuni che non hanno ancora adottato le aliquote massime. La crisi dell’industria delle costruzioni deriva in buona parte dall’aumento della pressione fiscale immobiliare in un periodo già critico. Il gettito che inizialmente doveva essere destinato alla riduzione del disavanzo fiscale del bilancio pubblico complessivo ora è tutto destinato alla finanza municipale. E ciò concorre spesso a sostenere una spesa comunale troppo elevata in relazione ai servizi resi quotidianamente ai cittadini.