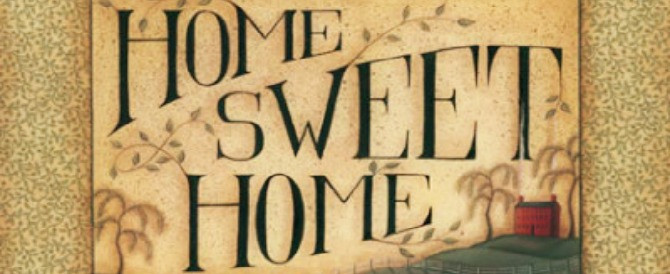Ricchi, eguali
Luciano Capone – Il Foglio
In questi 30 anni – quelli del “liberismo selvaggio” che affama i popoli, distrugge il pianeta, aumenta le disuguaglianze – l’umanità sta vincendo la più grande guerra contro la miseria. La Banca mondiale, lo scorso 9 ottobre, ha pubblicato un rapporto sulla povertà nel mondo. I dati dicono che la percentuale della popolazione mondiale che vive in condizioni di povertà estrema – ovvero con meno di 1,25 dollari al giorno – è crollata dal 36,4 per cento del totale nel 1990 al 14,5 per cento nel 2011. È la più grande riduzione della povertà nella storia dell’umanità, circa 1 miliardo di poveri in meno, una cifra mostruosa, una rivoluzione silenziosa che forse meriterebbe maggiore attenzione del libro glamour di Thomas Piketty, premiato ieri da quei burloni del Financial Times.
La caduta vertiginosa della percentuale di poveri, mentre la popolazione mondiale è cresciuta esponenzialmente, spazza via il malthusianesimo di ritorno, le boiate sulla decrescita felice e il pauperismo no global. Secondo le proiezioni della Banca mondiale, con un tasso di crescita globale pari a quello degli anni 2000, nei prossimi 20 anni la povertà si ridurrà ulteriormente fino a scendere al 5 per cento della popolazione mondiale, che vuol dire altri 600 milioni di poveri in meno. L’ampiezza di questo fenomeno è ancora più impressionante se si guarda allo studio di un economista catalano della Columbia University, Xavier Sala-i-Martin, che dimostra come in un arco di tempo più ampio, dal 1970 al 2006, il tasso di povertà assoluta è crollato dell’80 per cento. Ma non basta: oltre a diventare più ricco il mondo è diventato anche meno diseguale. Sala-i-Martín mostra che sia il coefficiente di Gini sia l’indice di Atkinson (indicatori che misurano la distribuzione dei redditi) segnalano una riduzione della disuguaglianza a livello globale.
Ma a cosa è dovuto questo portentoso progresso? Nazioni Unite? Fondo monetario internazionale? Qualche programma governativo? Aiuti ai paesi in via di sviluppo? No. È merito della globalizzazione, del libero mercato, dei diritti di proprietà, del rule of law, della caduta di barriere interne ed esterne. In una parola, del capitalismo. E questo è evidente anche ai più scettici, dato che il contributo più grande alla riduzione della povertà l’hanno dato i popoli di due paesi fino a poco fa (e in parte ancora oggi) prigionieri dello stato e della pianificazione economica, cioe la Cina e l’India. Come hanno illustrato magistralmente il premio Nobel Ronald Coase e Ning Wang nel loro libro “Come la Cina è diventata un paese capitalista”, pubblicato in Italia dall’Istituto Bruno Leoni, sono stati l’apertura al mercato, la rottura dei monopoli statali, il superamento dei “piani quinquennali” e l’estensione dei diritti di proprietà a garantire una vita più decente a centinaia di milioni di esseri umani, tanto che adesso la povertà estrema sembra essere un problema africano e in particolare subsahariano, riguardante cioè quelle aree dove il capitalismo non ha ancora messo piede.
Questi dati smentiscono gli “intellettuali” che dai pulpiti di paesi ricchi e stanchi da anni parlano di “ritorno a Marx”, crisi del capitalismo, caduta del saggio di profitto e proletarizzazione della borghesia. D’altronde lo stesso Karl Marx, a differenza dei marxisti, era un alfiere entusiasta della globalizzazione e aveva capito bene la potenza rivoluzionaria del capitalismo. E forse, oltre ai marxisti di ritorno, quella che può essere considerata come la più grande moltiplicazione dei pani e dei pesci della storia dell’umanità, seppure di origine non sovrannaturale, dovrebbe indurre a una riflessione anche Papa Francesco sul suo anti capitalismo pauperista esposto nella “Evangelii Gaudium”.