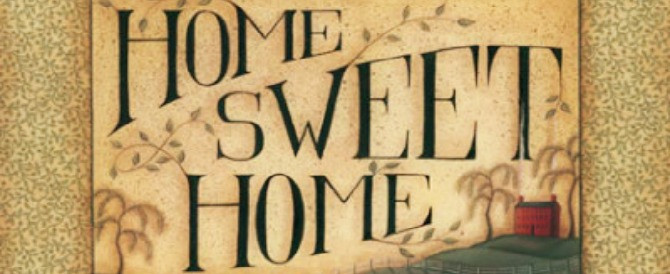Ora sotto esame le banche
Francesco Manacorda – La Stampa
Domenica a mezzogiorno, mentre le famiglie italiane saranno occupate a preparare il pranzo a casa, o magari in gita o dirette allo stadio, ci saranno molte persone – analisti di Borsa e uomini delle banche – che sedute alle loro scrivanie aspetteranno con ansia una serie di numeri. A quell’ora, infatti la Banca centrale europea renderà pubblici i risultati degli esami e degli esercizi condotti sui 131 principali gruppi creditizi del Continente. È un passo necessario per lanciare l’Unione bancaria europea, che comprende anche la vigilanza di una sola autorità – e non più delle singole autorità nazionali – su tutti i maggiori istituti di credito. Mentre a Bruxelles ci si confronta, anche in modo vivace, sui conti pubblici italiani, altri conti – quelli delle banche – si apprestano così a un esame europeo.
Per il mondo del credito la prova è doppia: ogni banca sarà sottoposta ad Aqr, o Asset Quality Review, e Stress test. Se volessimo tradurlo in termini comprensibili l’Aqr, che esamina in sostanza un campione di crediti concessi da ciascun istituto, è un po’ come un esame del sangue; gli Stress test, che simulano invece il comportamento dei conti di una banca in condizioni di difficoltà, somigliano a un elettrocardiogramma sotto sforzo. Proprio come quello che vi fanno sul tapis roulant per vedere come reagite a situazioni estreme. Se per una banca i risultati di Aqr e Stress test non dovessero arrivare a livelli minimi predeterminati, insomma se quella banca fosse giudicata non in grado di avere sufficiente patrimonio per la sua attività, le verrà prescritto un aumento di capitale. In pratica una cura ricostituente per rafforzare il patrimonio.
Ieri sera ogni banca ha ricevuto, in busta chiusa, i suoi risultati. Ma solo domenica tutte sapranno lo stato di salute di tutte le altre. In Italia ci saranno tredici banche esaminate. Gli analisti di mercato prevedono che la Carige non passerà l’esame e hanno dubbi sul fatto che il Monte dei Paschi di Siena ce la possa fare. Uno dei problemi è che l’esame del sangue fatto alle banche, il famoso Aqr, si basa sui dati al 31 dicembre 2013 – un anno brutto in generale e per l’Italia in particolare. È un po’ come se alla Banca centrale avessero fatto il prelievo quel giorno e adesso rendessero pubblici i risultati degli esami. Ma se uno che aveva i trigliceridi alti intanto si è messo a dieta, come si farà a capirlo? Per le banche italiane è un problema, visto che molte di loro in questi primi nove mesi del 2014 hanno effettivamente messo in atto azioni virtuose – ad esempio hanno venduto partecipazioni o hanno varato aumenti di capitale – per rafforzare il loro patrimonio. Così, dopo che da Francoforte arriverà il verdetto della Bce, toccherà alle autorità di vigilanza nazionali – da noi la Banca d’Italia – dettagliare che cosa ogni istituto ha fatto in questo periodo e come le sue analisi del sangue sono effettivamente migliorate.
Avrà senso questo esercizio che le stesse autorità nazionali stanno trovando molto macchinoso? Tornando alla nostra immagine iniziale, avranno significato analisi del sangue i cui risultati ciascuno tenderà poi a modificare o a rettificare a seconda di come si è comportato dopo il prelievo? Da un certo punto di vista sì, il significato c’è. In qualche modo – tutt’altro che preciso, ma comunque indicativo – ogni banca avrà dati trasparenti sullo stato di salute degli altri istituti. Nel migliore dei casi questo potrà portare anche a un aumento di fiducia all’interno del sistema. Anche gli investitori – chi compra direttamente azioni delle banche o chi magari si affida ai fondi comuni – avranno dei parametri per orientarsi meglio.
Ma assieme all’opportunità di una maggiore trasparenza, gli esami della Bce potrebbero offrire anche qualche rischio. Quale? Ad esempio che una visione troppo restrittiva porti a ricapitalizzazioni delle banche che inevitabilmente frenerebbero la concessione di credito. Una cosa è prestare 100 euro se a questo devi far fronte con 8 euro di capitale; un’altra è se di fronte allo stessa cifra prestata bisogna avere 10 euro di capitale. I banchieri italiani lamentano da tempo che il comportamento iper prudenziale dei regolatori – dopo la crisi finanziaria del 2008 molti pensano che per gli istituti sia meglio girare con cintura e bretelle assieme – rischia di penalizzare il credito, specie in un Paese come il nostro dove le imprese sono mediamente piccole e poco capitalizzate. Ovviamente le responsabilità non sono tutte dei regolatori. Ma è il caso di riflettere se non si stia esagerando con i requisiti di patrimonio delle banche in una fase in cui ci sarebbe bisogno di credito. In fondo anche il dogma dell’austerità dei bilanci pubblici come cura a tutti i mali, per anni vangelo della Commissione europea, è stato appena messo in discussione dal nuovo presidente Jean-Claude Juncker.