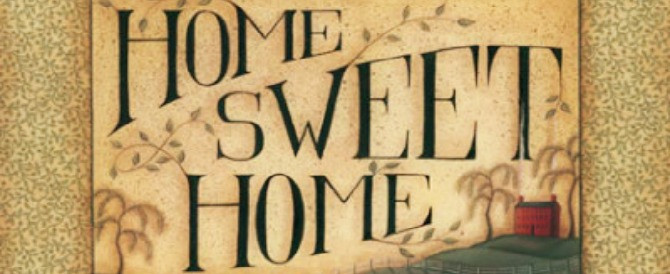La strada obbligata per ritrovare la crescita
Alberto Quadrio Curzio – Il Sole 24 Ore
Il Governo Italiano è impegnato su molti, difficili fronti, in Europa e in Italia. Sappiamo anche che il presidente del Consiglio Renzi, la cui energia è davvero tanta, vuole gestire in prima persona tutto. Sono quindi legittime le preoccupazioni che questo impegno sia eccessivo e che si impongano scelte e deleghe più chiare. Sulle riforme economiche necessarie, per evitare confusione, partiamo dalle raccomandazioni delle istituzioni europee all’Italia per passare poi ad una conclusione. E cioè che la spinta (sia pure limitata, senza quella europea) alla nostra crescita ed occupazione passa dal rilancio degli investimenti con le risorse recuperate dalla spending review e dall’evasione, con la riduzione del carico fiscale ed in particolare dell’Irap (solo simbolicamente ridotta in primavera), con un efficace partenariato pubblico-privato, con l’occupazione promossa da politiche attive e retributive nuove anche nel pubblico impiego.
Le raccomandazioni europee. Sono quelle espresse nel giugno scorso dal Consiglio della Ue e dalla Commissione europea, sul Programma nazionale di riforma e su quello di stabilità presentati dal governo. Purtroppo sono raccomandazioni che si ripetono da anni e sul cui adempimento l’Italia ha fatto poco. Eppure le stesse sono difficilmente contestabili anche se possono apparire semplificanti ed eccessive. Esse si riferiscono 1) alle politiche di bilancio; 2) all’alleggerimento del carico fiscale sui fattori produttivi; 3) all’efficienza della pubblica amministrazione; 4) al rafforzamento del settore bancario; 5) alle riforme del mercato del lavoro; 6) alle riforme del sistema di istruzione; 7) alla semplificazione normativa; 8) alla politica dei trasporti e delle infrastrutture. Il governo ha risposto a queste raccomandazioni evidenziando che le riforme richieste sono in cantiere anche se la realtà è (molto) più contenuta.Anche perché non sono chiare le nostre priorità e questo preoccupa perché l’economia reale italiana continua a peggiorare, pur con tutta l’ Eurozona.
Le valutazioni sul 2014. Infatti le previsioni (ci riferiremo a quelle di Prometeia sia pure con nostre valutazioni) danno troppi segni negativi: il Pil scende dello 0,2%; gli investimenti (macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto) scendono dello 0,4%; gli investimenti in costruzioni del 2,3%; la domanda totale interna dello 0,2%; la disoccupazione ormai si avvia al 13%. Non compensano questi dati negativi l’aumento della spesa delle famiglia dello 0,2% e un saldo dell’interscambio merci sull’estero al 2,8% del Pil. Due altri fatti (uno negativo e l’altro positivo) sono noti ma è bene ricordarli. L’inflazione (al netto di energia e alimentari, che sono componenti più volatili) è scesa in agosto allo 0,5%, che è il nostro minimo storico anche perché mai prima eravamo andati sotto quelle di Francia e Germania. In positivo vi è il calo dei tassi sui titoli di Stato con il conseguente risparmio di interessi passivi che contribuirà a tenere il deficit sul Pil sotto il 3%. In sintesi: i segnali moderatamente fiduciosi di una ripresa sono stati archiviati dai dati del secondo trimestre.
Priorità e risorse. Bisogna allora individuare tra le Raccomandazioni europee le più urgenti, proseguendo nel frattempo con le riforme ad effetto strutturale sul medio termine dei 1.000 giorni prefigurati dal governo. La priorità è quella di rilanciare gli investimenti, l’innovazione e l’occupazione, soprattutto quella giovanile. Perché da questa dipende la fiducia nel futuro che a sua volta contribuisce ad un aumento (vero) nella spesa delle famiglie. Per fare questa operazione vanno trovate le risorse e selezionati gli impieghi. Il reperimento delle risorse deve imperniarsi (ma non esaurirsi) sulla spending review (compresa la ristrutturazione delle aziende partecipate dagli enti locali). Poiché i quasi 60 miliardi di risparmi (al lordo delle minori entrate) del triennio 2014-2016 sono ben documentati dal Programma Cottarelli (che tra l’altro indica prudentemente entità minori di quelle prefigurate da altri nel 2012), bisogna dare esecuzione alla stesso senza esitazione. Inoltre va riequilibrato il carico fiscale recuperando l’evasione. Perché la nostra pressione fiscale apparente è al 44% ma quella effettiva (sui contribuenti leali) è al 54%.
Investimenti e lavoro. Con le risorse che si liberano bisogna spingere gli investimenti, l’innovazione, la tecnoscienza, l’industria, le infrastrutture che, oltre ai noti effetti moltiplicativi, devono anche sostenere la competitività del sistema Paese. Queste misure passano sia attraverso una riduzione del carico fiscale sulle imprese, e in particolare sugli investimenti, sia attraverso iniziative di partenariato pubblico-privato dove nuovi strumenti di finanza per le infrastrutture e l’industria servono molto. Non meno importante è l’intervento sul lavoro e l’occupazione dove il ministro Poletti sta operando bene. Bisogna arrivare alla semplificazione dei contratti, a migliori politiche attive, a contratti a tempo indeterminato ma a protezioni crescenti, a rivalutare l’apprendistato e l’alternanza scuola-lavoro, a rivedere i sussidi di disoccupazione e la cassa integrazione anche per prevenire forme che disincentivano il lavoro stesso. Poi ci vuole una radicale riduzione e ristrutturazione del pubblico impiego premiando solo il merito. Sappiamo che il Governo ha già adottato vari provvedimenti in queste direzioni. Siamo anche convinti che solo un successo pieno al proposito darà una (prima) spinta alla competitività italiana e aumenterà la nostra forza in Europa.
Una conclusione. Tutto ciò è per noi necessario ma non sarà sufficiente se le istituzioni europee non spingeranno gli investimenti infrastrutturali (materiali e immateriali) e una forte reindustrializzazione sostenibile anche con strumenti finanziari nuovi, come gli EuroUnionBond. Perché la politica monetaria della Bce per quanto espansiva (e non priva di rischi per bolle speculative) non può supplire una politica per l’economia reale.