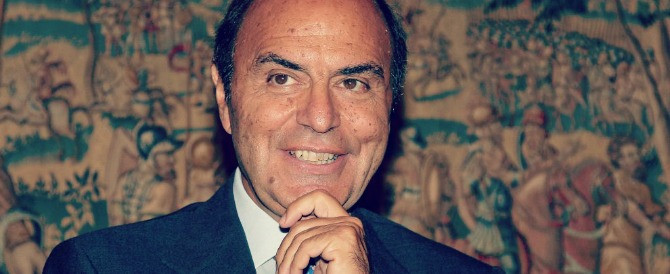Nel Jobs Act la mossa per abbattere l’ultimo tabù
Dario Di Vico – Corriere della Sera
Finora l’attenzione di merito sul Jobs act governativo si è concentrata quasi esclusivamente sulla riscrittura dell’articolo 18, cannibalizzando così un’altra scelta di grande discontinuità contenuta nel provvedimento sostenuto da Matteo Renzi: il salario minimo. In molti Paesi, europei e non, è in vigore da tempo, basta pensare allo Smic dei cugini francesi. In Italia, invece, l’introduzione del salario minimo è stata vista sempre come fumo negli occhi dai sindacati, gelosamente attaccati alla tradizione del contratto nazionale.
In linea di principio non c’è contraddizione tra una legge che stabilisca il salario minimo e un Ccnl stipulato tra le parti, ma in una fase di forte polarizzazione del sistema industriale finisce per rappresentare un’alternativa. Le differenze di mercato e di capacità di creazione di valore non sono più solo tra settori: passano all’interno dello stesso comparto. Dopo sei anni di Grande Crisi la distanza tra un’azienda che esporta stabilmente e un’altra che vivacchia di domanda interna è diventata abissale, come altrettanto ampia è la differenza tra industrie technology o labour intensive. Nello stesso settore metalmeccanico ci sono elettrodomestici e auto, che in virtù del basso valore aggiunto delle lavorazioni sono molto sensibili al costo del lavoro, ma anche le macchine utensili, in cui il livello delle paghe non è certo il principale dei problemi.
Con l’introduzione del salario minimo il contratto nazionale verrebbe fortemente limitato mentre ne uscirebbe esaltata la contrattazione aziendale. Il minimo stabilito per legge avrebbe poi un’altra valenza: far emergere il lavoro sommerso e combattere il caporalato in settori nei quali la rappresentanza sindacale tradizionale è evaporata e vige la pratica degli appalti al massimo ribasso. Si pensi, ad esempio, ad un business di grande rilievo come la logistica dove si è andato creando un far west di rapporti illegali, Cobas, false cooperative, sfruttamento degli extracomunitari e ricatto dei lavoratori. Costretti a retrocedere al datore di lavoro una parte del salario nominale stampato sulla busta paga. È chiaro che in situazioni come questa il salario minimo non è la panacea (servono anche tanti ispettori del lavoro!) ma potrebbe segnalare – specie agli stranieri – che le istituzioni non sono né cieche né sorde.